 Ragionpolitica, 23 ottobre 2007
Ragionpolitica, 23 ottobre 2007
di Stefano Magni
Domani la comunità armena italiana presenterà il testo di un appello destinato ai nostri eurodeputati, in cui si chiede di vincolare il processo di adesione della Turchia alla fine del suo negazionismo sul genocidio armeno.
L’appello recita testualmente: «Accanto a coloro che ritengono fermamente che sia immorale sorvolare sulla politica negazionista turca a discapito dei principi di diritto e di etica sui quali si fonda il Consesso europeo, vi sono taluni settori del Parlamento che credono sia opportuno agevolare il percorso turco di adesione alla Ue omettendo di inserire nell’agenda politica dei colloqui argomenti che suscitino l’irritazione di Ankara: fra questi, appunto, il riconoscimento del genocidio armeno.
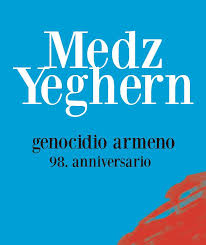 Tale politica, definibile di “opportunità”, rischia tuttavia di scavare un solco incolmabile tra le aspirazioni turche e la Comunità Europea: non è, infatti, nascondendo la propria storia, o rinnegandola, che la Turchia potrà entrare a far parte della storia d’Europa, anzi siamo convinti che accondiscendere all’intolleranza dei negazionisti, significa togliere alla società turca il diritto di maturare democraticamente verso quegli standard richiesti a tutti i Paesi membri dell’Unione».
Tale politica, definibile di “opportunità”, rischia tuttavia di scavare un solco incolmabile tra le aspirazioni turche e la Comunità Europea: non è, infatti, nascondendo la propria storia, o rinnegandola, che la Turchia potrà entrare a far parte della storia d’Europa, anzi siamo convinti che accondiscendere all’intolleranza dei negazionisti, significa togliere alla società turca il diritto di maturare democraticamente verso quegli standard richiesti a tutti i Paesi membri dell’Unione».
Non si tratta di una mera polemica intellettuale, ma di attualità più che concreta. Lo storico turco Taner Akçam (professore all’Università del Minnesota) è tuttora minacciato di morte dagli ultra-nazionalisti turchi, è sottoposto a un vero e proprio linciaggio mediatico in Turchia. La sua unica «colpa» è, appunto, quella di aver osato parlare del genocidio armeno.
 L’eurodeputata Marie Arlette Carlotti ha creato un comitato ad hoc per la mobilitazione in sua difesa, per garantirne l’incolumità da possibili attentati. Il rischio è concreto: il giornalista Hrant Dink è stato assassinato a Istanbul nemmeno un anno fa (il 19 gennaio scorso) per gli stessi motivi e dopo un linciaggio mediatico e intellettuale simile a quello che sta subendo attualmente Akçam. Il figlio di Hrant Dink, Arat Dink, è stato condannato a un anno di carcere per aver usato il termine «genocidio» riferito all’omicidio di massa degli armeni del 1915-1918. L’accusa è di «oltraggio all’identità nazionale turca».
L’eurodeputata Marie Arlette Carlotti ha creato un comitato ad hoc per la mobilitazione in sua difesa, per garantirne l’incolumità da possibili attentati. Il rischio è concreto: il giornalista Hrant Dink è stato assassinato a Istanbul nemmeno un anno fa (il 19 gennaio scorso) per gli stessi motivi e dopo un linciaggio mediatico e intellettuale simile a quello che sta subendo attualmente Akçam. Il figlio di Hrant Dink, Arat Dink, è stato condannato a un anno di carcere per aver usato il termine «genocidio» riferito all’omicidio di massa degli armeni del 1915-1918. L’accusa è di «oltraggio all’identità nazionale turca».
Questi fatti sono doppiamente gravi: da un lato la Turchia nega la libertà di ricerca e di espressione ai suoi storici, in aperta violazione ai principi europei sulla libertà individuale di pensiero. Dall’altro, perseguendo una politica negazionista, la Turchia dimostra di non rigettare (per non dire: approvare ancora) l’ideologia nazionalista che, nel 1915, fu alla base del genocidio.
 Per fare un parallelo nella storia recente, basti ricordare quanta fatica fece la Germania per lavare la macchia dell’Olocausto, pur avendo eliminato del tutto la sua classe dirigente nazista (i cui membri furono uccisi in guerra, processati a Norimberga, costretti alla fuga in Paesi lontani o emarginati dalla società): la Germania occidentale, quella sotto tutela degli Alleati, impiegò quattro anni prima di ricostituirsi come Stato e un decennio prima di essere accettata di nuovo in un’alleanza militare internazionale (la Nato), ma ancora nel 1989 la Francia e la Gran Bretagna nutrivano seri dubbi sulla riunificazione tedesca e nel 1992 il Trattato di Maastricht che accelerò l’integrazione europea fu concepito dalla Francia soprattutto come metodo per «ingabbiare» la nuova Germania in una nuova struttura europea che ne limitasse parzialmente la sovranità.
Per fare un parallelo nella storia recente, basti ricordare quanta fatica fece la Germania per lavare la macchia dell’Olocausto, pur avendo eliminato del tutto la sua classe dirigente nazista (i cui membri furono uccisi in guerra, processati a Norimberga, costretti alla fuga in Paesi lontani o emarginati dalla società): la Germania occidentale, quella sotto tutela degli Alleati, impiegò quattro anni prima di ricostituirsi come Stato e un decennio prima di essere accettata di nuovo in un’alleanza militare internazionale (la Nato), ma ancora nel 1989 la Francia e la Gran Bretagna nutrivano seri dubbi sulla riunificazione tedesca e nel 1992 il Trattato di Maastricht che accelerò l’integrazione europea fu concepito dalla Francia soprattutto come metodo per «ingabbiare» la nuova Germania in una nuova struttura europea che ne limitasse parzialmente la sovranità.
 Forse i dubbi sulla Germania, almeno dopo il 1989, era eccessivi, ma oggi non affrontare la questione del genocidio degli armeni in Turchia, prima di discutere la sua ammissione nell’Unione Europea, è quantomeno un atto di leggerezza.
Forse i dubbi sulla Germania, almeno dopo il 1989, era eccessivi, ma oggi non affrontare la questione del genocidio degli armeni in Turchia, prima di discutere la sua ammissione nell’Unione Europea, è quantomeno un atto di leggerezza.
Il genocidio degli armeni è storicamente importantissimo, perché costituì la matrice di tutti i genocidi successivi nel XX secolo. Lo stesso Hitler, prima di invadere la Polonia e mettere in atto i suoi piani di sterminio, ai generali che lo invitavano alla prudenza rispose: «Ma oggi chi si preoccupa più dell’eliminazione fisica totale degli armeni?». Una domanda retorica che spiega tutto: dimenticare un genocidio, ignorarlo politicamente, legittimare o quantomeno tollerare l’ideologia che lo ha causato, è un invito a compiere gesti analoghi in altri Stati e in epoche successive.
 Non è corretto usare altri termini all’infuori di «genocidio»: i Giovani Turchi (che allora erano il partito alla guida dell’Impero Ottomano) avevano l’intenzione di eliminare fisicamente e in modo definitivo l’intera minoranza etnica armena. Alla fine del XIX secolo, nell’impero ottomano erano stati compiuti altri massacri di armeni, ma la decisione di eliminare del tutto quella minoranza fu presa nel 1915, quando i Giovani Turchi avevano portato da pochi mesi l’Impero ottomano in guerra contro le potenze dell’Intesa (Francia, Gran Bretagna e Russia), il Sultano aveva proclamato (nel novembre del 1914) la jihad contro la Russia e le democrazie occidentali e tutti i vertici dell’impero (religiosi e laici) temevano che le minoranze (non di nazionalità turca e cristiane) al suo interno potessero ribellarsi e schierarsi dalla parte del nemico.
Non è corretto usare altri termini all’infuori di «genocidio»: i Giovani Turchi (che allora erano il partito alla guida dell’Impero Ottomano) avevano l’intenzione di eliminare fisicamente e in modo definitivo l’intera minoranza etnica armena. Alla fine del XIX secolo, nell’impero ottomano erano stati compiuti altri massacri di armeni, ma la decisione di eliminare del tutto quella minoranza fu presa nel 1915, quando i Giovani Turchi avevano portato da pochi mesi l’Impero ottomano in guerra contro le potenze dell’Intesa (Francia, Gran Bretagna e Russia), il Sultano aveva proclamato (nel novembre del 1914) la jihad contro la Russia e le democrazie occidentali e tutti i vertici dell’impero (religiosi e laici) temevano che le minoranze (non di nazionalità turca e cristiane) al suo interno potessero ribellarsi e schierarsi dalla parte del nemico.
 I telegrammi di Talaat Pasha, allora ministro degli Interni, indirizzati a tutte le prefetture provinciali, tra il marzo e il settembre del 1915, parlano chiaramente di «eliminazione fisica totale»: «E’ dovere di ognuno portare a termine, nel minor tempo possibile, la realizzazione del nobile progetto di porre fine all’esistenza dei ben noti elementi che per secoli hanno impedito il progresso e la civilizzazione dell’impero» si legge nel telegramma ai Delegati del Partito di Adana; «vi informiamo che anche donne e bambini sono inclusi negli ordini precedenti riguardo il trattamento dei maschi.
I telegrammi di Talaat Pasha, allora ministro degli Interni, indirizzati a tutte le prefetture provinciali, tra il marzo e il settembre del 1915, parlano chiaramente di «eliminazione fisica totale»: «E’ dovere di ognuno portare a termine, nel minor tempo possibile, la realizzazione del nobile progetto di porre fine all’esistenza dei ben noti elementi che per secoli hanno impedito il progresso e la civilizzazione dell’impero» si legge nel telegramma ai Delegati del Partito di Adana; «vi informiamo che anche donne e bambini sono inclusi negli ordini precedenti riguardo il trattamento dei maschi.
Scegliete elementi di vostra fiducia per portare a termine questo compito» si legge nel telegramma alla prefettura di Aleppo. E sempre alla stessa prefettura: «Siete già stati avvertiti che il governo, su ordine del Djemet (il consiglio esecutivo dei Giovani Turchi, ndr) ha deciso di distruggere tutte le persone indicate (gli armeni, ndr) che vivono entro i confini turchi. Tutti coloro che si oppongono a questo ordine non possono continuare ad essere ufficiali dell’impero. La loro (degli armeni, ndr) esistenza deve terminare, per quanto tragici possano essere considerati i metodi; non deve essere posto alcun limite sulla loro età o il sesso, né devono esservi scrupoli di coscienza».
 Questi ordini furono seguiti sin troppo alla lettera. Le prime vittime furono gli armeni già reclutati nelle file dell’esercito ottomano: furono uccisi a sorpresa, o raccolti dietro le linee e fucilati in massa. L’eliminazione fisica degli elementi più adatti al combattimento fece sì che i villaggi rimanessero alla mercé dei militari. Nella seconda fase del genocidio, militari e milizie irregolari passarono al sistematico massacro dei villaggi armeni in tutta l’Anatolia.
Questi ordini furono seguiti sin troppo alla lettera. Le prime vittime furono gli armeni già reclutati nelle file dell’esercito ottomano: furono uccisi a sorpresa, o raccolti dietro le linee e fucilati in massa. L’eliminazione fisica degli elementi più adatti al combattimento fece sì che i villaggi rimanessero alla mercé dei militari. Nella seconda fase del genocidio, militari e milizie irregolari passarono al sistematico massacro dei villaggi armeni in tutta l’Anatolia.
 Solo alcune comunità, come quella Moussa Dagh, riuscirono a resistere e ad essere evacuate, grazie all’aiuto militare francese. Allo stesso tempo, con maggior prudenza (a causa della presenza di numerosi osservatori internazionali) anche gli armeni di Istanbul furono arrestati e uccisi. Tutte le azioni di violenza contro la popolazione armena furono dettagliatamente pianificate e ordinate dai vertici politici ottomani.
Solo alcune comunità, come quella Moussa Dagh, riuscirono a resistere e ad essere evacuate, grazie all’aiuto militare francese. Allo stesso tempo, con maggior prudenza (a causa della presenza di numerosi osservatori internazionali) anche gli armeni di Istanbul furono arrestati e uccisi. Tutte le azioni di violenza contro la popolazione armena furono dettagliatamente pianificate e ordinate dai vertici politici ottomani.
Dopo la fine della prima guerra mondiale e la resa dell’impero ottomano, gli ufficiali dell’Intesa trovarono ampia documentazione scritta persino sui metodi di tortura da infliggere ai prigionieri. La terza fase del genocidio, la più conosciuta, fu la deportazione di massa dei sopravvissuti ai massacri precedenti: lunghe colonne di civili fatte marciare per migliaia di chilometri in aree lontane dalle loro terre di origine.
 Il massacro procedette anche in questa fase, anche se in modo meno organizzato: le colonne furono attaccate e decimate da guerriglieri irregolari (in prevalenza curdi) precedentemente armati dai militari regolari e scatenati contro i deportati dietro la promessa di un lauto bottino. In molti casi, ad attaccare le colonne dei deportati furono gli stessi soldati regolari turchi, teoricamente dispiegati per scortarli.
Il massacro procedette anche in questa fase, anche se in modo meno organizzato: le colonne furono attaccate e decimate da guerriglieri irregolari (in prevalenza curdi) precedentemente armati dai militari regolari e scatenati contro i deportati dietro la promessa di un lauto bottino. In molti casi, ad attaccare le colonne dei deportati furono gli stessi soldati regolari turchi, teoricamente dispiegati per scortarli.
I pochi che sopravvissero a queste prime tre fasi del genocidio, dovettero subire anni di internamento in campi di concentramento, il più delle volte allestiti nel deserto, in Siria e in Mesopotamia. Il bilancio finale, secondo le stime più accettate, è di un milione e mezzo di vittime, su una popolazione complessiva di circa due milioni di armeni.
(A.C. Valdera)




