Tratto dal blog di Sandro Magister
La testimonianza è di pochi giorni fa. È stata letta in Vaticano da un prete greco-cattolico che è stato sedici anni nelle prigioni comuniste. Ai limiti dell’immaginabile
di Sandro Magister
Immeritatamente trascurata e clandestina, invece, si prospetta la vita di un altro libro presentato 24 ore prima, martedì 23 marzo, nella sala stampa vaticana. Il volume ha per titolo: “Fede e martirio. Le Chiese orientali cattoliche nell’Europa del Novecento”. Raccoglie gli atti di un convegno di storici tenuto in Vaticano nel 1998 sulle persecuzioni delle Chiese dell’est. È stato stampato nel 2003 dall’Editrice Vaticana. Ma nelle librerie è praticamente introvabile. Persino lo scaffale virtuale di Amazon.com lo ignora.
Eppure questo è un libro decisamente fuori dell’ordinario. E ancor più lo è stata la sua presentazione, anch’essa passata sotto immeritato silenzio. Per capirlo, basta leggere il testo riprodotto qui sotto, letto dal suo autore proprio durante la presentazione del volume, in Vaticano. L’autore è un anziano sacerdote della Chiesa greco-cattolica di Romania che ha passato sedici anni nelle prigioni comuniste.
Il racconto della sua prigionia è concretissimo e insieme spirituale. Un po’ Solgenitsin, un po’ atti dei martiri. Tra mistero d’iniquità spinto ai limiti dell’immaginabile e Grazia. Con la “Santa Provvidenza” che opera per le mani inconsapevoli degli aguzzini. In tempi in cui il martirio è parola abusata, applicata anche agli “shahid” islamisti che si fanno esplodere per fare strage, questa è una testimonianza che aiuta a restituir verità. Assolutamente da non perdere
______________
“Ma è più grande il Cielo sopra di noi”
di Tertulian Ioan Langa
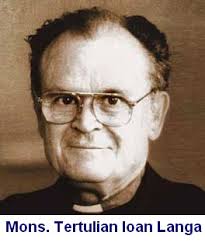 Il mio nome è Tertulian Langa e della mia vita sono ben 82 gli anni che non ho più. Di questi, 16 regalati alle prigioni comuniste. A 24 anni, nel 1946, ero un giovane assistente alla facoltà di filosofia dell’università di Bucarest. Le truppe russe avevano occupato quasi un terzo della Romania e mi fu intimato, come membro del corpo insegnante, di iscrivermi d’urgenza al sindacato manipolato dal partito comunista, imposto al potere dai blindati sovietici.
Il mio nome è Tertulian Langa e della mia vita sono ben 82 gli anni che non ho più. Di questi, 16 regalati alle prigioni comuniste. A 24 anni, nel 1946, ero un giovane assistente alla facoltà di filosofia dell’università di Bucarest. Le truppe russe avevano occupato quasi un terzo della Romania e mi fu intimato, come membro del corpo insegnante, di iscrivermi d’urgenza al sindacato manipolato dal partito comunista, imposto al potere dai blindati sovietici.
Già allora ero pienamente attestato sul fermo atteggiamento magisteriale che la Chiesa cattolica aveva adottato contro il comunismo, dichiarato male intrinseco. Quindi non c’era posto nella mia coscienza per un compromesso. Rinunciai alla carriera universitaria e mi ritirai in campagna come operaio agricolo; ma non fu sufficiente, poiché ero conosciuto, già alla facoltà, come militante cattolico e anticomunista. Velocemente fu improvvisato a mio carico un dossier accusatorio; e visto che le accuse si fondavano su fatti che il codice penale dell’epoca ancora non incriminava (rapporti con i vescovi, con la nunziatura, apostolato laico), il mio dossier fu assimilato a quello dei grandi industriali.
Dopo gli interrogatori accompagnati da atroci trattamenti, il procuratore dichiarò con perfetta logica comunista: «Nel dossier dell’accusato non si trova nessuna prova sulla sua colpevolezza; ma chiediamo ugualmente il massimo della pena: 15 anni di lavori forzati. Poiché, se non fosse colpevole, non si troverebbe qui». Obiettai: «Ma non è possibile che mi condanniate senza avere nessuna prova!». E lui: «Non è possibile? Guarda come è possibile: 20 anni di lavori forzati per aver protestato contro la giustizia del popolo». E questa fu la sentenza.
Ciò avveniva quando la Chiesa greco-cattolica di Romania ancora non era stata messa fuori legge. Si dava per scontato che il mio arresto e le torture sarebbero riuscite a trasformarmi in uno strumento a favore della futura incriminazione di vescovi e preti della Chiesa greco-cattolica e della nunziatura.
Degli interrogatori e della mia prigionia nei campi di sterminio comunisti riferisco soltanto alcuni momenti.
Sono stato arrestato a Blaj, nell’ufficio del vescovo Ioan Suciu, allora amministratore apostolico della metropolia greco-cattolica di Romania e futuro martire. Mi ero presentato a lui, al capo della nostra Chiesa, per chiedere lumi alla Santa Provvidenza, poiché il mio padre spirituale, monsignor Vladimir Ghika, altro futuro martire, era all’epoca nascosto. Mi era stata offerta da qualcuno la possibilità di partire per l’estero. Trattandosi di un passo importante, non volevo compierlo senza confrontarlo con la volontà di Dio. E la risposta arrivò: il mio arresto. Capivo che avrei passato la mia vita nelle prigioni create dal regime comunista, ma ero sereno: seguivo il percorso della Santa Provvidenza.
LA VERGA DI FERRO
Ricordo il giovedì santo dell’anno 1948. Da due settimane, ogni giorno, mi percuotevano con un ferro sulla pianta dei piedi, attraverso gli scarponi: dei fulmini mi percorrevano la spina dorsale e mi esplodevano nel cervello, senza però che mi fosse rivolta alcuna domanda. Mi preparavano col ferro per farmi arrivare più morbido all’interrogatorio. Legato mani e piedi e appeso con la testa in giù, i miei carcerieri mi infilavano in bocca un calzino, già lungamente passato negli scarponi e nella bocca di altri beneficiari dell’umanesimo socialista.
Il calzino era diventato lo strumento antirumore grazie al quale si impediva al suono di oltrepassare il luogo dell’interrogatorio. D’altra parte, era praticamente impossibile emettere un solo gemito. Per di più, mi ero autobloccato psicologicamente: non ero più capace di gridare o di muovermi. I miei torturatori interpretavano questo atteggiamento come fanatismo da parte mia. E continuavano sempre più accaniti, alternandosi nel torturarmi.Notte dopo notte, giorno dopo giorno.
Non mi domandavano nulla, poiché non era la risposta ciò che li interessava, ma l’annientamento della persona, fatto che tardava ad avverarsi. E come si prolungava lo sforzo di annientare la mia volontà, di ottenebrare il mio pensiero, si prolungava indefinitamente la tortura. Gli scarponi maciullati mi caddero dai piedi, pezzo dopo pezzo.
In quella notte del giovedì santo, in una chiesa vicina, si celebrava l’ufficio liturgico, accompagnato come da un pianto di campane spaventate. Trasalii. Gesù avrà sentito il mio grido soffocato, quando, non so come, urlai da quell’inferno: “Gesù! Gesù!”. Fuoruscito attraverso il calzino, il mio grido non fu compreso dagli aguzzini. Trattandosi del primo suono che udivano da me, si dichiararono contenti, sicuri d’avermi piegato.
Mi trascinarono con la coperta fino alla cella, dove svenni. Al mio risveglio, davanti a me stava l’inquisitore, con in mano una risma di carta: «Ti sei ostinato, bandito, ma non uscirai di qui finché non avrai tirato fuori tutto ciò che tieni nascosto dentro. Hai 500 fogli. Scrivi tutto ciò che hai vissuto: tutto su tua madre, su tuo padre, sulle sorelle, i fratelli, i cognati, i parenti, i compagni, i conoscenti, i vescovi, i sacerdoti, i religiosi, le religiosi, i politici, i professori, i vicini e i banditi come te. Non ti fermare finché non avrai finito la carta». Ma non scrissi nulla. Non per chissà quale fanatismo, ma perché non ne avevo la forza: anche la mente mi sembrava svuotata.
LA LUPA
Dopo quattro giorni, lo stesso individuo: «Hai finito di scrivere?». Vedendo che i fogli non erano stati toccati, disse: «Se così stanno le cose, spogliati! Ti voglio vedere come Adamo nel paradiso». Passarono così altri giorni, vissuti a pelle nuda sul pavimento: conforto tipico del socialismo umano.
Un altro individuo mi si presentò dopo un po’ di tempo davanti alla porta: «Vediamo, cosa c’è allora sulla carta? Nulla? Sempre ostinato! Guarda che abbiamo anche altri metodi». Dopo di che uscì. Ritornò accompagnato da un cane lupo enorme, con le zanne minacciose, in vista. «La vedi? È Diana, la cagna eroina, alla quale hanno sparato i tuoi banditi sulle montagne. Ti insegnerà lei cosa devi fare. Comincia a correre!».
E io: «Come a correre? In una stanza di soli tre metri?». Nella stanza c’era anche una lampadina di 300 watt, troppo per una stanza di soli tre metri per due, fissata non in alto ma sul muro, a livello del viso. «Corri!». La lupa, ringhiando, stava pronta ad attaccare. Corsi per sei, sette ore, ma di ciò mi resi conto soltanto verso l’alba, vedendo la luce farsi strada nella cella e sentendo movimenti nell’edificio. Ogni tanto quel tale faceva uscire la lupa per i bisogni.
A me non era concesso. Quando cominciai a perdere l’equilibrio e accennavo a fermarmi, la lupa vigilante, come a un comando, mi ficcava le sue zanne nella spalla, nella nuca e nel braccio.
Ho corso sotto i suoi occhi e le sue zanne per 39 ore senza interruzione. Alla fine crollai e la lupa si lanciò su di me. Mi azzannò al collo, senza però strozzarmi. Sulla fronte e sugli occhi sentii scorrere qualcosa di caldo e bruciante, capii che la bestia mi orinava sul viso. Ed è dalle parole dei miei carnefici che seppi d’aver corso per 39 ore. «Questo lo possiamo mandare alla maratona di Rio! Che resistenza, la bestia fascista!». Ma vedendo che nemmeno la maratona era riuscita a convincermi a rilasciare una dichiarazione sui vescovi e la nunziatura, o su qualche compagno ricercato, ritennero utile passare a un altro metodo di convincimento: il sacchetto di sabbia.
IL SACCHETTO DI SABBIA
Il giorno dopo, in un ufficio, mi legarono mani e piedi a una sedia, davanti a un tavolo con un sacchetto sopra. Dietro di me c’era un aguzzino impalato e muto. A una scrivania, nell’angolo, un individuo calvo con una barbetta da caprone, che voleva rassomigliare a Lenin. Muto anche lui, fece un segno muovendo la testa. Il mio boia capì il comando. Impugnò il sacchetto e me lo picchiò in testa con ritmo, accompagnando ogni colpo con la parola: «Parla!». Decine di volte, centinaia di volte, non so, magari migliaia: «Parla!». Ma nessuno mi chiedeva alcunché.
Soltanto una voce cavernosa, monotona, mi ficcava nel cervello l’idea imperativa di dire, di rispondere a ogni domanda sottoposta alla mia coscienza dall’organo inquisitore. Non mi fu difficile decifrare la satanica idea di voler sottomettere la mia volontà. Dopo circa venti colpi, cominciai ad applicare il principio morale “age contra”, fa il contrario, dicendo tra me ad ogni colpo: «Non parlo!». Decine di volte, centinaia di volte. Con l’autosuggestione avevo impiantato in me lo stereotipo «Non parlo!», col rischio di diventare io stesso schiavo di quell’unico modo di esprimermi. In effetti fu così: da allora in poi, automaticamente, a ogni domanda che mi veniva rivolta, non importa su quale argomento, io rispondevo: «Non parlo!». Mi ci volle un anno intero di sforzi mentali per liberarmi da questo sinistro riflesso automatico.
VENTOTTO CENTIMETRI
Come soggetto privo di valore e interesse negli interrogatori, fui trasferito nella prigione sotterranea della zona paludosa di Jilava, a 8 metri sotto terra, che era stata costruita un tempo a difesa della capitale, ma era allora completamente inutilizzabile a causa delle forti infiltrazioni d’acqua. Nulla e nessuno vi resisteva tranne l’uomo, il più alto tesoro del materialismo storico.
Nelle celle di Jilava, i poveri uomini facevano l’esperienza delle sardine: però non nell’olio, ma nel succo proprio, fatto di sudori, di orine e di acque di infiltrazione, che scorrevano senza sosta sui muri. Lo spazio era sfruttato nel modo più scientifico: due metri di lunghezza e ventotto centimetri di larghezza per ciascuna persona stesa a terra, sul fianco. Alcuni, i più anziani, stavano stesi su tavole di legno, senza lenzuola o coperte. A contatto col legno erano l’osso omerale e la parte esterna del ginocchio e della caviglia.
Stavamo sulla punta delle ossa, per occupare uno spazio minimo. La mano non poteva appoggiarsi che sull’anca o sulla spalla del vicino. Non resistevamo così più di mezz’ora; poi tutti, al comando, poiché non era possibile separatamente e uno dopo l’altro, ci voltavamo sull’altro fianco. La catasta di corpi stipati, così disposti, aveva due livelli, come in un letto a castello. Ma al di sotto di questi c’era un terzo livello, dove i detenuti giacevano direttamente sul cemento.
Sul cemento i vapori di condensa del respiro dei settanta uomini, assieme alle acque di infiltrazione e all’orina che fuorusciva dalle latrine, formavano una miscela viscosa in cui nuotavano i malcapitati. Al centro della cella-tomba di Jilava troneggiava un recipiente metallico, di circa settanta-ottanta litri, per l’orina e le feci di settanta uomini. Non aveva coperchio e l’odore e il liquido traboccavano abbondantemente. Per raggiungerlo, dovevi passare per il “filtro”, vale a dire per un controllo severo applicato a pelle nuda, controllo nel quale veniva sottoposto ad esame l’intero organismo e ogni suo orifizio.
IL “FILTRO”
Con una bacchetta di legno ci raspavano in bocca, sotto la lingua e le gengive, nel caso in cui noi banditi avessimo lì nascosto qualcosa. La stessa bacchetta ci perforava le narici, le orecchie, l’ano, sotto i testicoli, rimanendo sempre la stessa, rigorosamente la stessa per tutti, come segno d’egualitarismo. Le finestre di Jilava non erano fatte per dare luce, ma per ostacolarla, poiché tutte erano accuratamente chiuse da tavole di legno inchiodate. La mancanza d’aria era tale che per respirare, tre per volta, ci avvicendavamo a turni, pancia in giù, con la bocca accanto allo spiraglio della porta, posizione in cui contavamo sessanta respiri, affinché poi anche altri compagni potessero riprendersi dallo svenimento e dalla carenza d’ossigeno.
Contribuivamo così, a nostro modo, all’edificazione del più umano sistema del mondo. Sapevano queste cose Churchill e Roosevelt, quando, con un colpo di penna, sul tavolo della vergogna di Teheran, stabilirono che noi rumeni dovessimo finire macinati dalle fauci del Moloch orientale rosso e facessimo da cordone di sicurezza per la loro comodità? E la Santa Sede poteva forse immaginare qualcosa?
NUDI NEL GELO
Da Jilava, dopo lunghi anni di profanazioni umane, fummo trasferiti, catene ai piedi, al carcere di massimo isolamento, chiamato Zarka, padiglione del terrore della prigione di Aiud. L’accoglienza si svolse secondo lo stesso rituale sinistro, diabolico, di profanazione dell’uomo creato dall’amore di Dio. La stessa raspatura, gli stessi stivali tremendi che ci si ficcavano nelle costole, nella pancia e nei reni. Nonostante ciò, notammo una differenza: non eravamo più sottoposti al regime di conserva in orine, sudori, condensa e carenza d’ossigeno, ma fummo sottoposti a una intensa cura di ossigenazione a pelle nuda e nel gelo, bandito dopo bandito (da intendere ministri, generali, professori universitari, scienziati, poeti) compreso me, che non ero nulla tranne che un «Non parlo!» gigante, una ferma e umile fiducia nella Grazia che mi avrebbe fatto superare la prova.
Tutti dovevamo sparire, come nemici del popolo. Altrimenti, come avrebbe potuto farsi avanti il tanto proclamato «Uomo nuovo sovietico»? La cella in cui ero stato introdotto non conteneva nulla: né letto, né coperta, né lenzuolo, né cuscino, né tavolo, né sedia, né stuoia e nemmeno finestre. Soltanto sbarre di acciaio e io, come tutti gli altri, da solo nella cella: mi meravigliavo di me stesso, vestito con la sola pelle e coperto dal freddo.
Era la fine di novembre. Il freddo si faceva sempre più penetrante, come uno scomodo compagno di cella. Dopo circa tre giorni, dalla porta violentemente sbattuta mi furono gettati dei pantaloni logori, una camicia con maniche corte, mutande, una divisa a strisce e un paio di scarponi consumati, senza lacci, senza calzini. Nulla da mettere in testa. E in più una specie di latrina, un misero recipiente di circa quattro litri. Mi vestii come un razzo. Congelati, il quarto giorno ci contarono. Al posto del nome mi diedero un numero: K-1700, l’anno in cui la Chiesa della Transilvania si riunì con Roma. All’anagrafe, ero già ucciso. Sopravvivevo solo come numero statistico.
Arrivò poi il brodo, servito con un mestolo da 125 grammi: un fluido allungato prodotto dalla bollitura di farina di mais. Come pranzo ci fu distribuita una minestra di fagioli, nella quale potei contare all’incirca otto, nove chicchi, con parecchie bucce vuote, senza contenuto. Per la cena, ci portarono del te con una crosta di pane bruciato. Dopo una settimana, i fagioli furono sostituiti da un passato di crusche, nel quale contai quattordici chicchi. Di tanto in tanto, i fagioli si alternavano con il passato di crusche. Vivevamo con meno di quanto si dà a una gallina.
CAMMINARE O MORIRE
Per sopravvivere al freddo, eravamo costretti a muoverci continuamente, a far ginnastica. Nel momento in cui cadevamo stremati dalla stanchezza e dalla fame, precipitavamo nel sonno; un sonno brevissimo, giacché il freddo era tagliente. Da un tale sonno mi svegliò un giorno una voce proveniente dall’altra parte del muro: «Qui professor Tomescu. Chi sei ?». Era un ex ministro della sanità che, udito il mio nome, così proseguì: «Ho sentito parlare di te. Ascoltami attentamente: siamo stati portati qui per essere sterminati. Non collaboreremo mai con loro. Ma chi non cammina muore, e quindi diventa un collaboratore. Trasmettilo agli altri: chi si ferma, muore. Camminare senza sosta!. Il padiglione, immerso nel silenzio lugubre della morte, risuonava sotto i nostri scarponi senza lacci.
Eravamo animati dalla misteriosa volontà di un popolo di rimanere nella storia e dalla vocazione della Chiesa di restare viva. Ci fermavamo dal camminare solamente intorno alle 12,30, per una mezz’ora, quando il sole si fermava avaro per noi nell’angolo della stanza. Là, rannicchiato col sole sul viso, rubavo un fiocco di sonno e un raggio di speranza. Quando il sole mi abbandonava anche lui, sentivo però di non essere abbandonato dalla Grazia. Sapevo di dover sopravvivere. Camminavo, dicendomi come in un ritornello, sillabando: «Non voglio morire! Non voglio morire!». E non sono morto! A ogni passo cadenzavo nella mente una preghiera, componevo litanie, recitavo versetti di salmi.
Continuammo a camminare così, per non inciampare nella morte, diciassette settimane. Chi non aveva più la forza o la volontà di muoversi, moriva. Degli 80 uomini entrati nella Zarka, appena 30 sopravvissero. La sbarre di ferro, piano piano, si rivestivano di brina, formatasi dagli aliti di vita del nostro respiro, brillante abito di passaggio verso il cielo.
MA TUTTO È GRAZIA
Credetti fortemente, più volte, che sarei arrivato fino ai margini della notte. Ma avevo ancora una lunga strada da percorrere. Arrivato poi, anni dopo, in ciò che immaginavo dovesse essere la libertà, costatai che non era in realtà che un nuovo modo di essere della notte, che il gelo tra la Chiesa greco-cattolica e la gerarchia della Chiesa sorella ortodossa non si lasciava sciogliere ancora; che le nostre chiese continuavano ad essere confiscate, e il gregge diminuiva sempre di più, ucciso dalle promesse. Ma anche Cristo Signore ha vinto soltanto quando ha potuto pronunciare con l’ultimo respiro: «Consummatum est», tutto è compiuto.
Non ho scritto molto di queste mie drammatiche esperienze. Chi può credere a ciò che sembra incredibile? Chi può credere che le leggi fisiche possono essere superate dalla volontà? E se dovessi raccontare i miracoli che ho vissuto? Non sarebbero considerati delle fantasmagorie? Sopporterei più difficilmente questa incredulità che non altri anni di prigione. Ma nemmeno Gesù è stato creduto da tutti coloro che l’hanno visto: «Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui» (Gv 6,66).
Nulla avviene per caso nella vita. Ogni attimo che il Signore ci concede è gravido della Grazia – impazienza benevola di Dio – e della nostra volontà di rispondergli o di rifiutarlo. Spetta a ciascuno di noi non ridurre tutto a un semplice racconto duro, feroce, incredibile, e capire invece che la Grazia accolta non frena l’uomo, ma lo porta oltre le sue aspettative e forze.
Questa testimonianza spero di cuore che apra una finestra di Cielo. Perché è più grande il Cielo sopra di noi che non la terra sotto i nostri piedi.





