Strumenti culturali di Litterae Communionis n.3 luglio 1981
I GRANDI DELLA CULTURA MODERNA RIVISITATI

CLEMENTE MARIA REBORA
Il mio canto è un sentimento e domandava la vita. Vive la trottola e gira, / la sferza Iddio, la sferza è il tempo: così la trottola spira / dentro l’amore verso l’eterno
testo di Giampiero Beltotto
scelta antologica di Gianni Musini
LA SUA VITA
«Per l’umano divenir possente
certezza ineluttabile del vero ordisci,
ordisci dei tuoi fili il panno
che saldamente nel tessuto è storia
e nel disegno eternamente è Dio »
Premessa
Innamorato di Cristo. Se con una sola, sintetica definizione dovessimo fissare l’esperienza umana e letteraria di Clemente Maria Rebora, questa — innamorato di Cristo — è certo la più idonea.
Amore vero, perciò travagliato, a tratti lacerato, urlato, rifiutato. Davvero, l’incontro determinante con l’unico vero Significato della vita, prima solo intuito poi desiderato infine accolto. Solo indagando su questo amore, su questo incontro con la Verità di un roveto che arde e che urge nel cuore e nella carne potremo accostarci a una delle più singolari figure del Novecento italiano. Prima indicazione di metodo è dunque quella di abbandonare gli orpelli ipocriti — e comunque parziali — dell’accademia per addentrarci nell’ipotesi della fede, quella cioè logicamente più credibile.
Solo da qui gli strumenti della filologia, della critica letteraria, dell’analisi storica acquisteranno credibilità. Il reciproco non è dato. Da qui anche si comprende perché una delle voci più profonde e letterariamente fondate del nostro secolo è stata così duramente e ottusamente emarginata dalla cultura dominante. Poche e distratte pagine sulle antologie scolastiche, nessuna edizione critica nel corso dell’ultimo trentennio (e ringraziamo l’editore Vanni Scheiwiller e il valentissimo amico Gianni Mussini che stanno dando alle stampe le poesie e le prose liriche di cui pubblichiamo un’antologia su queste pagine), la sua quasi totale dimenticanza nel limbo dei poeti cosiddetti minori: questa cultura di Rebora non ha capito nulla, o quasi. Hanno persino scritto che don Clemente, attorno alla metà degli anni Cinquanta, quando cioè tornò a scrivere, era come «morto alla poesia». Questo perché nei confronti di Rebora venne perpetrato l’orribile peccato di prescindere dalla fede per comprenderlo, per sondarne l’anima, per coglierne l’eredità.
Poche le eccezioni; per tutti l’indimenticabile Mario Apollonio, che di Rebora — e di tutto Rebora — è splendido esegeta. Ma anche in altro senso esiste un’eccezione: questa volta data dalla possanza di acume e di patrimonio culturale di Gianfranco Contini. Si potrà giudicare forse parziale il suo illuminante articolo sul «primo» Rebora (proprio perché prescinde dall’ansia, dalla «mania di eterno» costante nell’esperienza reboriana). Gli dev’essere dato comunque atto di aver fatto luce su quanto di essenziale è da scoprire nella cosiddetta «grammatica reboriana». Ricerca dunque solo linguistica e filologica, parziale come s’è detto, ma altresì geniale.
Nel 1955 usciva presso l’editore Scheiwiller di Milano il Curriculum Vitae, un poemetto che valse a Rebora il Premio Cittadella di poesia, l’unico riconoscimento ufficiale del Parnaso italiano al poeta lombardo.
Nel Curriculum, don Clemente ripercorre alla luce di una fede ormai divenuta pienezza di giudizio e di esistenza una vita segnata da folgoranti illuminazioni e da laceranti disperazioni. Ero a ott’anni una bruna susina / intatta ancora nella sua pruina, / l’ignorato Battesimo operando.
Clemente Maria Rebora era nato a Milano il 6 gennaio 1885 da una famiglia della soda borghesia ambrosiana. L’eredità culturale di casa Rebora è quella laica e mazziniana del progressismo di allora, con i suoi ideali repubblicani e giustizialisti. Dunque, nulla a che vedere con la fede, che in lui comincia altresì ad operare nonostante ogni sfavorevole condizione. Il primo rilevante dato della sua biografia è comunque il «lombardismo», accettato nei suoi dati culturali e linguistici e vissuto, come si constaterà più innanzi, con assoluta consapevolezza. Crescerò forte, tutto urti e frastuono / mamma scusava: in fondo in fondo è buono. / Ma bisognava pur esserlo in cima.
Questo, come si desume anche dall’imponente raccolta epistolare il clima di casa Rebora e il legame profondo tra madre e figlio. … ammiccando l’enigma del finito / sgranavo gli occhi a ogni guizzo; / fuor scapigliato come uno scugnizzo, / dentro gemevo, senza Cristo: il giovane Rebora vive costantemente dilaniato dal tormentante furore generato dall’insoddisfazione del finito nel desiderio, solo a tratti consapevole, di toccare con mano l’eternità, l’ideale, il significato di tutto. Sono numerose in questo senso le testimonianze che ci ha lasciato.
Ancora nel Curriculum Vitae: Un guasto occulto mi minava in basso, / un lutto orlava ogni mio gioire: / l’infinito anelando, udivo intorno / nel traffico o nel chiasso, un dire furbo: / Quando c’è la salute, c’è tutto; / e intendevan le guance paffute, / nel girotondo di questo mondo.
Da una lettera del 17 marzo 1907 all’amica Daria Banfi Malaguzzi Valeri: Io per me, quando, toltomi dallo schifo delle oblique miserie libero l’anima, selvaggia leonessa indomabile, verso le altre anime belle nell’infinito benedico le più tremende angosce, tutti i mali e tutti i dolori; essi solamente infine fanno di noi medesimi una divinità; in quest’infinito solo noi, solo pochi, si purificano contemplando meraviglie inenarrabili; i vili e gli inetti non possono più toccarci. Il 4 luglio 1908 scrive ancora: Tanto più ch’io ora mi libro in un’aspirazione semplice e superba insieme: giungere a una bontà cosi vasta di spirito da poter ritrovare dolcezze purissime per gli altri e per me, sempre, anche di fronte ai sudici offici della bestialità.
Certo, Rebora ha letto Nietzsche, il filosofo che più d’ogni altro sta influenzando la gioventù d’inizio di secolo con le sue irraggiungibili profezie, ascolta il Tristano e Isotta di Wagner e ne esce in eccitamento formidabile dello spirito, si sta avvicinando alla comprensione della spiritualità asiatica; ma questo non basta a ridurre o a tentar d’ideologizzare il possente richiamo religioso nella sua vita giovanile. È un fatto.
È lui stesso l’oggetto di questa stupenda invocazione: O allodola, a un tenue filo avvinta, / schiavo richiamo delle libere in volo, / come in un trillo fai per incielarti / strappata al suolo agiti invano l’ali!
Intanto Rebora si è laureato in lettere all’Accademia scientifico letteraria di Milano dopo aver frequentato al Parini il ginnasio e poi il liceo. I suoi grandi amici d’allora sono Sebastiano Giacomelli, Angelo Monteverdi, Antonio Banfi, Daria Malaguzzi. Frequentavano gli stessi corsi in una vecchia aula, lunga e stretta. Diedero vita a un circolo letterario, chiamato un po’ pomposamente «Quadrivio» prima e poi «Trivio». In questo clima di entusiasmo culturale nasce la tesi di laurea su Giandomenico Romagnosi svolta negandosi in partenza ogni successo scolastico perché teso a cercare nuove vie, che mi paiono tutte degne del mio amore.
Il 9 maggio 1908 Giuseppe Prezzolini annota nel suo diario: «Penso d’inaugurare una rivista di cultura per l’anno prossimo, fatta come avevo pensato prima che Papini, sotto l’influenza di Soffici, buttasse fuori “Il Commento”. Forse ci sacrificherò del denaro; forse qualcuno mi aiuterà». La rivista di cui scrive il «nume» del pensiero laico italiano è «La Voce» che, sempre a parere di Prezzolini «corrisponde, interamente, a uno sforzo di pulizia». Soffici e Papini, Cecchi e Slataper, Bastianelli e Jahier, Boine e tanti altri giovani entusiasti parteciperanno a un’avventura che per onestà, coraggio e acume non avrà pari nel cosiddetto «fronte dei laici». Rebora non poteva mancare.
Ecco il giudizio di Prezzolini: «Eccellente impressione, animo saldo, sicuro, fa e fa bene, che meraviglia sono questi giovani in provincia…».
Con i quaderni della «Voce» Rebora pubblicherà la sua opera indubbiamente più originale e famosa, I frammenti lirici, che usciranno nel 1913. La gioia per l’immediato e trionfale successo di questa raccolta — dedicata ai primi dieci anni del secolo XX — è subito smarrita nel caos prebellico e nell’infinito dolore che accompagnerà le vicende della prima grande guerra.

Rebora soldato, nel 1915
Di superbia ubbriaca si avanzava / la guerra, come suol, femmineggiando. Nell’ultimo giorno dello stesso anno conoscerà Lidya Natus, un’artista russa di origine ebrea. Rebora visse con lei fino al 1919 un rapporto dolcissimo, testimoniato dalle nove poesie per una Lucciola. A sradicarlo dalla sua compagna fu il colpo di rivoltella di Serajevo. Ed ecco il fischio dell’andata al fronte: / Sibilla profetava: / Giovani, avanti al rischio benedetto! I Però, in trincea, chiuso l’orizzonte, / Moloch faceva pasto grasso. / Perso nel gorgo, vile fra gli eroi, / spatriato quaggiù, Lassù escluso, / ruotando giacqui, mentr’era pugna atroce.
Non era stata energica la posizione neutralista di Rebora, ma nemmeno interventista quale quella dell’amico Monteverdi e di tanti altri poeti, letterati e uomini di cultura. In quest’episodio il suo stato d’animo: Quando partii per il fronte, al brindisi familiare «viva l’Italia» io ribattei: «Sì, ma non quella di D’Annunzio». E gli stessi sentimenti saranno espressi nella lirica Fantasia di carnevale coraggiosamente pubblicata da Prezzolini nel numero del 28 febbraio della «Voce».
Nell’aprile del 1915 Clemente è militare con il grado di sergente e tra poco meriterà le stellette di ufficiale. La guerra rappresenterà la sua grande officina di dolore che solo pochi attimi di serenità potranno illuminare. La scheggia di un proiettile d’obice che lo colpisce alla tempia; il calvario tra ospedali e manicomi; il grave esaurimento nervoso che seguirà a tutto questo; la volontà di tornare al fronte ma senza più comandare — perché comandare era uccidere — e il pesante calamaio tirato in fronte a un colonnello che si rifiutava di credere che un «baldo ufficiale» volesse essere degradato; la visione, tremenda, della morte: tutto questo segnerà indelebilmente la sua esperienza di uomo e di poeta. Scriverà a sua madre: Mamma mia, sono nella guerra ove è più torva: fango, mari di fango e bora freddissima e putrefazione fra incessanti cinici rombi violentissimi. Del 1919 poi, a congedo avvenuto, la separazione con la Natus.
Nel 1922 Clemente pubblicherà i Canti anonimi. Poi il silenzio, fino al 1955. Che cosa accade in questo lungo periodo? Ciò che già viveva in Rebora, la sua ansia religiosa, il suo desiderio di eternità, di pace, la sua indomabile sete di verità avrà soddisfazione, si placherà nella fede cattolica ch’egli accosterà in due gigantesche figure: il cardinale Schuster, che gli impartirà il sacramento della Cresima, e Rosmini, per il quale Rebora scriverà, nel Curriculum, questi versi: E fui dal Ciel fidato a quel sapiente / che sommo genio s’annientò nel Cristo / onde Sua virtù tutto innovasse. / Dalla perfetta Regola ordinato, / l’ossa slogate trovaron lor posto: I scoprì l’intelligenza il primo dono: / come luce per l’occhio operò il verbo, / quasi aria al respiro il Suo perdono.

Rebora sacerdote
Nel 1931 entra dunque come novizio nell’Istituto della Carità dei padri Rosminiani al Monte Calvario di Domodossola; il 13 maggio 1933 emette la sua professione religiosa e finalmente, il 20 settembre 1936 è ordinato, sempre a Domodossola, sacerdote. Toccherebbe ora parlare dei suoi ultimi giorni, ché anche in questo periodo don Clemente ci ha insegnato tanto, ci ha mostrato il significato della mortificazione, ci ha indicato la via da seguire perché la conversione divenga carne e sangue della nostra esperienza, ci ha, nel cuore e nell’anima, segnato con la consapevolezza del suo patire. Padre Ezio Viola ci ha lasciato la testimonianza di questi giorni, di questi mesi, di questi anni tremendi e dolcissimi, pagine di indimenticabile pathos umano e divino («Mania dell’eterno»).
Padre Ezio è stato il suo infermiere, la persona che più da vicino può raccontare di che lagrime grondi e di che sangue la santità eroica — per dirla con Apollonio — di don Clemente. E’ un volumetto che ciascuno dovrebbe tenere sul comodino, personale pietra d’inciampo e goccia di conforto …
La prefazione è di Enzo Fabiani, che narra del suo incontro con Rebora. Riportiamo della sua prefazione l’ultima parte, con il commosso omaggio di Fabiani al maestro lombardo. «Colui che qui parla e del quale si parla, è un uomo di oltre 70 anni umilialo dalla malattia: è insieme un sacerdote che molti stimano un santo; ed è un uomo e un sacerdote che da tanti anni ormai ha lasciato, chiamato da Dio con violenza, la poesia: alla quale aveva donato due dei libri più importanti di questo secolo: Frammenti lirici e Canti anonimi…

Rebora nel 1955, di ritorno da Lourdes
Ora qui, a causa della sofferenza, non è più lui, o meglio Io è soltanto a tratti. Lo sentiamo gemere immolandosi, dubitare di sé, della propria salvezza eterna. Lo vediamo umiliato dalle necessità fisiche, dalla stanchezza, dal disorientamento, a volte vaneggia. È diventato, Clemente Maria Rebora, una specie di “uomo dei dolori”, un “lebbroso” come il suo Divino Maestro. Anch’egli sta salendo il Calvario. Eppure egli è e resta, nonostante tutto, uomo sensibile e gentile (anche se, a volte, scatta e si ribella); è e resta il credente che spasima d’amore per Dio e la Madonna; è e resta il poeta che trasalisce — squisitamente lombardo — accorgendosi che fuori dalla finestra un pioppo è verde nel vento e per l’aria limpida …
Un documento straordinario, acceso, straziante e a volte allucinante; ma specialmente documento che scrive, e conferma, a lettere maiuscole come la forza della fede possa trionfare su tutto. Altro io non sono capace di dire: ma vorrei tanto pregare chi è preparato e autorevole a non perdere questa occasione per far meglio conoscere quest’uomo dolce e tragico; questo sacerdote ardito e ardente; questo poeta unico: che nella sua agonia non geme più con le nostre parole, ma con la voce profonda e ferma dei profeti; che chiama Dio, ormai, con la voce solamente umana dei martiri, cioè dei veri e non letterari testimoni».
Omaggio a Clemente Maria Rebora che è anche il nostro, di quelli cioè che han tentato d’imparare dalle sue vicende d’uomo e di poeta non solo e non tanto a por mano a scherzi letterari, ma che su di sé, attraverso lui, hanno provato a compiere un altro passo in avanti verso la casa del Padre.
|
|
LA SUA OPERA
«Le parole mi servono per comunicare a chi sa e attende e conosce e traduce in termini di vita le comunicazioni»
Ha scritto nel 1960 Mario Apollonio: «Il primo quesito che mi sono posto è: ma non è tutta poesia religiosa la poesia di Clemente Rebora? Conosco anche le responsabilità di questa parola. Non vorrei che, cercando le tracce o le direzioni o le situazioni d’intuizioni, in una fondamentale religiosità di tutta la parabola della poetica di Clemente Rebora, si dimenticasse quello che egli ha pure asserito con tanta magnanima evidenza o — se volessimo dichiarare la sua persona e la sua opera nella prospettiva dogmatica — con santità eroica. Per un uomo che ha fatto di sé strumento di redenzione e che solo perché aveva acquistato questa sostanza primaria di vita — la santità eroica —- ha potuto illuminare così drammaticamente anche in parole la vita religiosa, far tutt’uno dei due momenti sarebbe non solo pericoloso e contraddittorio, ma anche un andar contro le indicazioni che egli stesso ci dà. Noi, procedendo a queste ricognizioni dì grande poesia e illuminandola, a nostra volta, con la presenza della testimonianza eroica, dobbiamo accompagnare e dobbiamo cercare nel profondo: guardare alla meta, ma guardare anche al punto di partenza».
Non si tratta dunque di «far tutt’uno», ma di condividere integralmente un’esperienza di umanità e di poesia, in una parabola che ci si presenta come fondamentalmente religiosa, come fondamentalmente tesa cioè all’Assoluto, al Giusto, al Vero e al Bello. È questa tensione morale infatti che costituisce il tessuto connettivo di una poesia che parte dalla constatazione dell’umana debolezza per giungere alla pace della contemplazione.
Uno sguardo unificante dell’opera reboriana non significa perciò ottusità o pregiudizio di fronte alle controindicazioni eventualmente fornite dal testo, ma si pone come rilettura di una memoria e di un desiderio «intuizione ed illuminazione sulla via del cattolicesimo — come suggerisce Apollonio — di una poesia che dilatandosi verso i confini del mondo procede verso infiniti spazi della vita dello spirito».
Rileggiamo gli ultimi versi dei Frammenti lirici: Il mio verso è un istrumento / che vibrò tropp’alto o basso / nel fermare la prima corda: / ed altre aspettano ancora. / Il mio canto è un sentimento I che dal giorno affaticato / le ore notturne stancò: / e domandava la vita. / Tu, lettor, nel breve suono / che fa chicco dell’immenso / odi il senso del tuo mondo: / e consentir ti giovi.
Un canto che domandava la vita, ne accoglieva le contraddizioni, gli affanni, le brevi gioie, la prodigiosa sorte e il privilegio tremendo. Nella poesia l’uomo può rinnovare la lotta fra cielo e terra: Bello incrociar la vita / nella maglia del tutto, ma ne esce sconfitto, incapace di dare quella risposta ultima ed esauriente al proprio destino, come si legge in questi altri versi, dall’amaro sapore malinconicamente leopardiano: Anima hai gioia: perché? / A qual fonte bevesti, / a quale sole splendesti, / se d’intorno per noia / ogni forma è ritrosa / e sta la nebbia e appanna / l’ostinata città irosa, / e tutto ha un muro livido di fronte?
Ma la sua è una sconfitta non definitiva, un morire che assapora il gusto del rinascere e già ne intravvede la sagoma, i contorni, la verde fertile terra di quell’universo promesso, più saldo del trasmutabile giorno, /questa lusinga più vera / della tua isola, Circe; / al nostr’occhio di lince / anche la notte è vasta / per aguzzar lontano, / al nostro polmon sano / anche poc’aria basta / per respirar profondo, / se turbini con Dio / la volontà nutrita / di ricrear nel mondo / quest’angoscia gioita, / quest’impeto fecondo, / questo veggente oblio: / questa vita che è vita.
Questa vita che è vita rappresenta la prima tappa fondamentale del suo itinerario di uomo e di poeta, la cui genesi vive ancora in una domanda: L’egual vita diversa urge intorno: / cerco e non trovo e m’avvio / nell’incessante suo moto: / a secondarlo par uso o ventura, / ma dentro fa paura. / Perde chi sente, / l’irrevocabil presente. E ancora: … l’indistinto / mister si fa passione / dove circola il mondo / Tu fosti e sei il desiderio mio.
Domanda, desiderio, anelito che sgorgano dal profondo dell’anima e del sentimento, ma smarriscono il proprio oggetto — l’oggetto della propria contemplazione — perché ancora fragili e paurosi di fronte all’immensità della vita che il cuore riesce a percepire solo immane e indifferente.
A questo punto la domanda si trasforma in denuncia, bestemmia e pianto di un tempo che non si può possedere, ma da cui non si ha ancora il coraggio di essere posseduti: Per l’acre fluir dei minuti I che vita distrugge e ricrea, / mentre è violenza di strade / e divisa vicenda di case, / nel fiato e nel sangue un’idea / mi strozza senza grida I consuma senza fiamma. / Romba, splende, s’inspira il contrasto / dell’uomo, del mondo, di Dio. / Dalla mia carne si veste e si cela / palpata da un sogno di incubi, / agita nervi per trine e fibrille / di vene per chioma, / sbarra nel viso pupille / rosse d’un cuore spezzato; / ma tutto la solita mano / mi porge dov’io rimango.
La risposta non può venire dallo sforzo morale, dall’impegno civile, dalla politica o dal sozial, dalla stessa ispirazione poetica o dall’ideologia della ragione (cagna che ha piscio per ogni cantone!) perché né gli uni né l’altre — e in un primo tempo è proprio dall’ideologia che vien cercata salvezza contro la città vorace / che nella fogna ancor tutti affratella — possono qualcosa contro l’onnipotente tempo della morte, e vivono nella coscienza come mosche d’inverno, intanto cadon morte!
In questa sensibilità religiosa Rebora si ritrova peraltro assieme ad alcuni protagonisti della cultura del suo tempo. Il giovane Rebora appartiene infatti a quel gruppo di scrittori che radunati attorno all’esperienza vociana, sono dominati dalla preoccupazione morale, e in cui più chiaro sedimenta il sentimento della crisi spirituale da cui sta uscendo sconfitta la società moderna.
Dopo aver conosciuto Prezzolini, entra in contatto con Jahier, Slataper, Boine, Michelstaedter, uomini che vivono il disagio di una condizione oppressiva, espressa dalla società borghese e mercantile, cinica e filistea degli anni a cavallo dei due secoli, e che cercano il modo di uscirne.
Certo, la protesta che essi esprimono è ancora confusa; in alcuni (Jahier, Sbarbaro) con più vivo accento moralistico, in altri (Boine, Slataper) con una disperazione spirituale forse più accentuata, che probabilmente risulta più lucida come documentazione piuttosto che come proposizione positiva. Certamente Rebora ne condivide le passioni e le speranze, le angosce e la disperazione. Ma se pure indiscutibile appare questa poetica del grido, della voce; se pure è indubitabile lo svilimento delle strutture che conduce alla sconsacrazione della letteratura; se pure la moda letteraria conduce al frammento, nonostante tutto ciò che costituisce l’officiatura, l’«iniziazione» poetica del giovane Rebora, nel poeta lombardo muta l’orizzonte, si fa vivo il sentimento del rischio di tale condizione di vita e, accanto al desiderio sempre insoddisfatto della conquista dello spirituale nascosto nella realtà, ingigantisce l’ombra di una responsabilità, di un impegno, di un’Altra presenza.
Così, mentre Boine scrive: «Come i galeotti rasati striscio sgomento pei muri e a tutti gli spigoli urto» e Slataper si consuma nelle proprie contraddizioni scrivendo il suo libro più famoso (Il mio Carso), Rebora compone il suo frammento forse più bello, che così conclude: Oh per l’umano divenir possente / certezza ineluttabile del vero, / ordisci, ordisci dei tuoi fili il panno / che saldamente nel tessuto è storia / e nel disegno eternamente è Dio: / ma così, cieco e ignavo / tra morte e morte il ritmo fuggente, / anch’io t’avrò fatto; anch’io.
|
Frammenti lirici
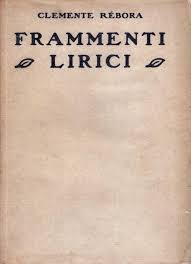 Se da questi tentativi emerge un’officiatura che nel frammento vuole demolire l’impalcatura di un’accademia ansimante, ormai in agonia senza più partecipazione né civile né morale, pare evidente l’estrema diversità dell’azione e del messaggio reboriano da quello dei contemporanei.
Se da questi tentativi emerge un’officiatura che nel frammento vuole demolire l’impalcatura di un’accademia ansimante, ormai in agonia senza più partecipazione né civile né morale, pare evidente l’estrema diversità dell’azione e del messaggio reboriano da quello dei contemporanei.
Il verso come momento sentimentale e la prosa come momento razionale della scrittura erano i canoni della vecchia letteratura, storicistica e carducciana, incapace di offrire nuovi strumenti a questo modo d’intendere e di vivere la letteratura che stava lievitando in una civiltà pervasa da idealità e direzioni del tutto inedite. Si viene instaurando un rapporto critico nei confronti delle istituzioni, una cocente insoddisfazione nei confronti dei detentori dei canoni della retorica, che i nuovi autori rifiutano in nome di un’asserita dignità umana e intellettuale. La risposta all’accademia è la provocazione: il frammento.
Ma, capovolgendo in polemica la constatazione, si accusò la nuova poesia di frammentismo, ciò che appunto era il suo vanto. Probabilmente più che dispetto o provocazione il frammento nasce dall’esigenza — autentica fuori da ogni volontà polemica — di una comunicazione vibrante, secca, concentrata, estremamente espressiva e soprattutto simbolica di quell’esigenza di novità spirituale che definiva il rapporto che questi nuovi autori desideravano vivere con il mondo circostante. Il breve brano di poesia si è liberato dall’impaccio della rima e dai problemi della metrica, e la prosa tende a diventare momento d’officiatura poetica.
L’elemento comune va cercato nella direzione di un linguaggio interiore, personale, a tratti spiritualistico, che ricostruisca l’idea della poesia come impegno e responsabilità etica.
Ma questa reazione all’accademia e al positivismo non si declina in un reale coinvolgimento civile e sociale: si va esaurendo nel momento stesso in cui viene pronunciato. Una reazione che diventa sovente restaurazione: non quella del fascismo — come giustamente sottolinea Barberi Squarotti — ma pur sempre qualcosa di staccato dalla realtà, la società del dantesco castello del limbo, fuori del tempo: l’impegno spiritualistico e religioso non è un reattivo — conclude Barbieri Squarotti — per cogliere le contraddizioni storiche, è un mezzo per allontanarsene, invece in buona coscienza.
Ora questa fuga non vede mai Rebora protagonista. Mai la sua poesia si affaccia alle soglie del «castello del limbo». Mai il poeta lombardo cerca di fuggire, anche se «in buona coscienza», dalle situazioni o dalle contraddizioni che va denunziando. E questo impegno può essere affermato proprio nel momento in cui si svela la natura non ideologica del suo messaggio: o, per meglio dire, che il contenuto della sua poesia non sta nell’affermazione di un’ideologia — foss’anche spiritualistica o di natura religiosa — di cui ha scoperto l’inganno e il limite proclamato nel tempo della morte.
La grandezza e dunque anche la diversità di Rebora rispetto ai suoi contemporanei vive dunque nella profondità di quella domanda che costantemente si percepisce nei Frammenti: in questo anche l’indubbia esperienza religiosa che dà cuore e vita al suo messaggio poetico. Quella di Rebora è una costante tensione morale verso l’Assoluto, il desiderio di incontrare il Significato, qualunque sia l’esito o la risposta definitiva a tale tensione.
Nel Rebora dei Frammenti le risposte che cerca di offrire alla propria coscienza inquietata e incalzata da quest’urgenza di credere, cadono a una a una sotto i colpi di un’anima che cerca la propria origine, il proprio «perché», e rimane la domanda, nel proprio lacerante e profondo dolore: Il mio canto è un sentimento / e domandava la vita.
E da qui che il suo messaggio si fa incessantemente provocatorio rifiutando a priori l’astrattezza intellettualistica. Vive totalmente immerso nel suo mondo, nel suo tempo, nelle contraddizioni, nelle ingiustizie, nelle gioie e nei dolori della vita quotidiana: ed è proprio in quest’esperienza quotidiana che va modellandosi il suo destino d’uomo e di poeta.
In queste esperienze di tutti i giorni, come testimoniano i Frammenti, trova le amicizie, i modelli, uno stile. E’ frammentista con i frammentisti, è poeta tra i poeti: eppure, se coglie in coloro che lo circondano il desiderio di una sincera ispirazione, originalmente propone la propria diversità, una sincerità cioè «più sincera», perché capace di scavare nel fondo della coscienza a proclamare l’inanità dello sforzo, la disillusione, feroce, dell’ideologia.
È da questa esigenza interiore che nasce il bisogno espressivo di una poesia attaccata al reale, che anzi fa della concretezza che rifugge da ogni astrazione il proprio canone stilistico.
Poesia religiosa quella dei Frammenti lirici, riproponendo il quesito posto da Apollonio? Sicuramente una poesia tesa all’Ideale che solo può inverare l’ispirazione.
|
Musica O musica, soave conoscenza, tanto innaturi l’anima fin ch’ella delle imagini vere la più bella in sua voce ritrova e in sua movenza; e come a noi perman l’intelligenza se vada in labil suono di favella, armoniosa in te non si cancella l’eterna verità mentre è parvenza. Virtù ti crea che non par segreta, ma il ritmo snuda l’amor che discende dall’universo a rivelar la meta: amor che nel cammino nostro accende l’inconsapevol brama triste o lieta, e in te, raggiunto il tempo, lo trascende. |
Curriculum vitae
 Ma quando nel 1955 Rebora fa uscire il Curriculum Vitae dov’è approdata la sua ricerca? Tutto, si badi, dipende dalla risposta a questa domanda. Lasciarla inevasa equivale a tradire tutta la sua esperienza umana e poetica.
Ma quando nel 1955 Rebora fa uscire il Curriculum Vitae dov’è approdata la sua ricerca? Tutto, si badi, dipende dalla risposta a questa domanda. Lasciarla inevasa equivale a tradire tutta la sua esperienza umana e poetica.
E non solo perché a una comparata analisi del linguaggio usato da Rebora nei Frammenti e nel Curriculum si sveleranno sorprendenti analogie, tali da radicare la certezza che nel poeta lombardo non s’è smarrita l’intima struttura linguistica. Come sottolinea l’amico e profondo studioso del poeta, Gianni Mussini, «Lo stile non è determinato da una necessità estetica, ma diventa una conquista morale. Per colmare il divario tra i diversi piani della realtà, occorrerà dunque far violenza alla lingua, piegarla ad immagini ardite per descrivere l’indescrivibile: l’urto tra spirito e materia. Nasce di qui l’affascinante ruvidità dello stile reboriano, determinata da un linguaggio “di movimento”, con una preponderanza di soluzioni verbali, una sintassi rapida e continue vicinanze lessicali strane, aventi la funzione di unificare idea e realtà, astratto e concreto». Da questo punto di vista è decisiva la lettura di un saggio di Ferdinando Bandini (Ricerche sulla lingua poetica contemporanea) che squaderna quella che con lucida intuizione è definita «la grammatica reboriana».
E non debbono essere dimenticati gli «indizi» danteschi presenti sia nei Frammenti che nel Curriculum. Altro studio questo che, se portato a compimento, potrebbe forse giungere a una memoria dantesca addirittura interpretativa rispetto al testo reboriano, in grado cioè di orientarne l’intima motivazione.
Da queste sorprendenti analogie si può dunque desumere il fatto che quando Rebora dopo circa trent’anni di silenzio tornò a scrivere, non potè rinunciare, almeno in assoluto alla sua capacità e volontà espressiva. Perché «in assoluto»? Pei ché a qualcosa Rebora rinunciò: alla «sua» parola, come se questa fosse inadeguata a esprimere la novità della sua vita convertita. Don Clemente cioè rimane fedele allo scheletro, alla struttura intima del proprio linguaggio — quello già presente nei Frammenti — intessuto di sofferenza individuale e di tormento dell’anima, ma lo piega e lo modella nelle forme «eterne» della preghiera.
Il Curriculum è approdato alla verità ultima, a quella verità che dà forma e significato a tutto l’essere, a cui sola ci si può affidare perché interamente esprima la sofferenza e il tormento nello stesso momento in cui alla sofferenza e al tormento viene offerto l’unico, vero lenimento: la fede.
Una rilettura in questo senso del Curriculum offrirà il senso di quest’itinerario. Il Curriculum Vitae prende spunto dalla memoria della propria vita non convertita, l’ignorato Battesimo operando, nella quale misteriosamente agisce la Grazia.
Sola, raminga e povera / un’anima vagava: è gemito del peccatore che non riconosce Cristo come verità ultima di sé. Il mondo, dicotomico rispetto alla realtà della Grazia, fornisce modelli da imitare, ideologie di cui diventar schiavo, idoli da adorare: Immaginando m’esaltavo in fama / di musico e poeta e grande saggio: / e quale scoramento seguitava!; errore e verità stavano al gioco; e nella frode del piacer caduto / sussurrava la gente scaltrita: / Adesso conosci la vita; saggezza da ogni stirpe affastellavo / a eluder la sapienza: Non come fibre fuse in un sol tronco / i miei pensieri, ma fascio di rami / cui rotto il laccio ognuno a sé ritorna.
La poesia è idolo che si origina nel disperato desiderio della verità: Però non ogni canto è buon respiro / né tutti i versi fanno poesia. E alla poesia percepita come idolo corrisponde la natura, colta nel mar convulso sotto il vento, in una tempesta delle acque metafora di quella dello spirito.
Questo è il momento della solitudine, disperazione di un tempo che non racchiude in sé l’eternità ma che fissa in spasimi drammatici la propria condizione di peccatore. È il disordine interiore ed esteriore: è la lacerazione tra terra e cielo che strazia l’anima vincolata dalle catene del proprio male, spatriato quaggiù, Lassù escluso. Ma la forza per ricomporre tale lacerazione non può essere trovata da chi giace in questa profonda prostrazione: occorre che altri ti cinga; per risvegliare quella Grazia che ha sempre continuato a palpitare nel fondo della coscienza, sopita nell’oblio del peccato, c’è bisogno di un incontro.
Ecco infatti che sotto la montagna del pentimento e dell’espiazione, un vecchio, in dignità modesta / s’accompagnava all’andar stanco mio / … / con un pio / piglio mi offerse la certezza. Certezza offerta che non è meccanicamente certezza accettata. Comunque essa significa il risvegliarsi nella coscienza del desiderio della verità e della totalità. Da qui, da questa scommessa su di sé, anche la realtà esterna viene percepita in modo radicalmente rinnovato. La natura non è più nemica: Tutto era irraggiamento al solleone: / cullato in barca stavo in mezzo al lago / svanì il creato e apparve il Creatore. I colori coperti dalla caligine infernale si risvegliano: ora anch’essi esistono. La realtà tutta viene ricomposta dal disordine al proprio ordine naturale, quello dato da Dio. Il Signore prepara e poi dà il via. / Nell’ora che la notte figlia il giorno.
Ma questo non è ancora esser pronti al grande incontro con la propria Origine: ancora qualcosa incatena la carne e l’anima, l’allodola non può ancora incielarsi; un intrico di rami mi costrinse a farmi piccolino, perché non gli è ancora possibile fisicamente sopportare la luce della salvezza negli occhi di Maria.
La storia di quest’anima deve ancora valicare, nell’itinerario della salvezza, lo scoglio dell’obbedienza passata al crogiolo della preghiera. Ma finalmente è libera dalla disperazione: la Certezza è riconosciuta e accettata; la montagna è ancora da scalare ma se ne intravvede la vetta. La strada può essere persa, è vero, evanescente il suolo perdo traccia. / La caligine cupa ormai mi schiaccia: / sfuggo qua, là: par d’ogni parte abisso perché un velario copre gli occhi e perciò l’angoscia riprende fino al pianto.
A salvarlo è il belato di un agnellino la pecora pensando e l’agnellino / presagio sorse nella fantasia: / Ecce Agnus Dei (mi dissi?) e per Maria. Agnellino di cui è evidente il senso figurale; cioè il rinvio non alla immagine, ma alla Presenza di Cristo.
Il frutto di quest’ubbidienza è il riconoscimento, nunc et semper, dell’origine della salvezza. Il principio dell’eterno amore è finalmente accettato in una rinnovata consapevolezza, esito della trasfigurazione, della conversione avvenuta. Il gesto è convertito: l’ubbidienza è libertà. E se questo distrugge i suoi scritti, Oh sì che quello fu un gran bel stracciare, perché è uno stracciare per la verità di Cristo e anche se nel momento della rinuncia si può cogliere mestizia forse, ma non tristezza.
Il cammino in salita è terminato: la montagna dell’espiazione diventa poggio aperto a ogni vista amena e il primo frutto a essere colto è la possibilità dell’innocenza, finalmente davanti a sé, negli occhi di una bambina quasi a me segno del divin favore.
L’innocenza, la contemplazione: il cuore si apre alla visione dell’eterno, e tutta la verità di sé compare improvvisamente davanti agli occhi del viandante. L’ossa slogate trovaron lor posto: / scoprì l’intelligenza il primo dono: / come luce per l’occhio operò il verbo, / quasi aria al respiro il Suo perdono: / Gesù Amore in me fu gravidanza.
|
Certezza del vero Sciorinati giorni dispersi, cenci all’aria insaziabile: prementi ore senza uscita, fanghiglia d’acqua sorgiva: torpor d’àttimi lascivi fra lo spirito e il senso; forsennato voler che a libertà si lancia e ricade, inseguita locusta tra sterpi; e superbo disprezzo e fatica e rimorso e vano intendere: e rigirìo sul luogo come cane, per invilire poi, fuggendo il lezzo, la verità lontano in pigro scorno; e ritorno, uguale ritorno dell’indifferente vita, mentr’echeggia la via consueti fragori e nelle corti s’amplian faccende in conosciute voci, e bello intorno il mondo, par dileggio all’inarrivabile gloria al piacer che non so, e immemore di me epico armèggio verso conquiste ch’io non griderò. — Oh per l’umano divenir possente certezza ineluttabile del vero, ordisci, ordisci de’ tuoi fili il panno che saldamente nel tessuto è storia e nel disegno eternamente è Dio: ma così, cieco e ignavo, tra morte e morte vii ritmo fuggente, anch’io t’avrò fatto; anch’io. |
|
Il carro vuoto O carro vuoto sul binario morto, ecco per te la merce rude d’urti e tonfi. Gravido ora pesi sui telai tesi; ma nei ràntoli gonfi si crolla fumida e viene annusando con fàscino orribile la macchina ad aggiogarti. Via del suo spazio assorto all’aspro rullare d’acciaio al trabalzante stridere dei freni, incatenato nel gregge per l’immutabile legge del continuo aperto cammino: e trascinato tramandi e irrigidito rattieni le chiuse forze inespresse su ruote vicine e rotaie incongiungibili e oppresse, sotto il ciel che balzàno nel labirinto dei giorni nel bivio delle stagioni contro la noia sguinzaglia l’eterno, verso l’amore pertugia l’esteso, e non muore e vorrebbe, e non vive e vorrebbe, mentre la terra gli chiede il suo verbo e appassionata nel volere acerbo paga col sangue, sola, la sua fede. |
CONCLUSIONI
 Ha scritto Giovanni Getto in un articolo che analizza l’ultima parte della produzione reboriana: «La lettura del Curriculum Vitae rimanda alla prima e più importante, per misura esterna e intima (di estensione e di profondità) esperienza lirica, quella precedente la conversione, la quale può essere datata al 1929. Non solo per il rapporto che, nell’ambito ben definito di una personalità ogni opera istituisce necessariamente con l’opera e le opere che precedono. Ma per più stretti e precisi legami di contenuto e di forma, quei legami che un fatto decisivo come la “conversione” parrebbe invece aver spezzato, avviando su strade totalmente nuove la realtà di questa poesia».
Ha scritto Giovanni Getto in un articolo che analizza l’ultima parte della produzione reboriana: «La lettura del Curriculum Vitae rimanda alla prima e più importante, per misura esterna e intima (di estensione e di profondità) esperienza lirica, quella precedente la conversione, la quale può essere datata al 1929. Non solo per il rapporto che, nell’ambito ben definito di una personalità ogni opera istituisce necessariamente con l’opera e le opere che precedono. Ma per più stretti e precisi legami di contenuto e di forma, quei legami che un fatto decisivo come la “conversione” parrebbe invece aver spezzato, avviando su strade totalmente nuove la realtà di questa poesia».
Getto evidenzia poi un tratto che appare totalmente inedito nella poesia di Clemente Rebora: «Quell’aperto linguaggio del dogma cattolico: “Dio, Trinità, Cristo, Maria”, intuiti rispettivamente nella prospettiva della creazione e della provvidenza, del mistero e della grazia, della crocefissione dolorante e generosa, della maternità sollecitata per gli uomini tutti». Un linguaggio, quello che Rebora usa in questa prospettiva di religiosità — di cattolicità — dogmatica, che non viene trasfigurato, ma in cui la parola tocca, non per emblemi ma direttamente il nuovo contenuto dogmatico e religioso, e che non si rinnova, ma rimane comune, «ecclesiastica», appunto.
|
Dall’imagine tesa Dall’imagine tesa vigilo l’istante con imminenza di attesa — e non aspetto nessuno: nell’ombra accesa spio il campanello che impercettibile spande un polline di suono — e non aspetto nessuno: fra quattro mura stupefatte di spazio più che un deserto non aspetto nessuno: ma deve venire, verrà, se resisto a sbocciare non visto, verrà d’improvviso, quando meno l’avverto: verrà quasi perdono di quanto fa morire, verrà a farmi certo del suo e mio tesoro, verrà come ristoro delle mie e sue pene, verrà, forse già viene il suo bisbiglio. |
Un tono affabulatorio che non si semplifica tanto in quella che potrebbe apparire una ingenuità quasi giaculatoria (o Immacolato Cuore di Maria / nel sangue di Gesù con te io sia) quanto si piega alle esigenze di una parola che vuole servire l’Assoluto; una parola che volutamente viene scarnificata perché solo così può riuscire a esprimere quell’intuizione immediata dell’essere che è la fondamentale caratteristica della poesia religiosa.
Un rapporto quello reboriano tra poesia e religione che, come annota Apollonio, «vale in due momenti. Anzitutto poesia come premessa contemplativa dell’essere, per cui il poeta si affida alla sua ispirazione per capire il mondo: poi la dogmatica la soccorre e la rivela». Il che equivale a parlare dell’esistenza che accetta di abbandonarsi al proprio Significato: è, infine, la storia della propria, personale conversione.
|
Notturno Il sangue ferve per Gesù che affuoca. Bruciamo! dico: e la parola ò vuota. Salvami tutto crocifisso (grido) Insanguinato di Tel Ma chiodo ai muro, in fisiche miserie io son confitto. La grazia di patir, morire oscuro, polverizzato nell’amor di Cristo: far da concimò sotto la sua Vigna, pavimento sui qual si passa, e scorda, pedaliera premuta onde profonda sai le voce dall’organo nei tempio — e risultare infine inutil servo: questo. Gesù, da me volesti; e vano promisi, se poi le anime allontano. Bello è l’offrir, quale il fiorire al fiore; ma dal sognato vien diverso il fatto. Padre, Padre che ancor quaggiù mi tieni, fa che in me l’Ecce non si perda o scemi! A non poter morire intanto muoio. Il sangue brucia: Gesù mette fuoco; se non giunge all’ardor, solo è bruciore. Maria invoco, che del Fuoco è Fiamma; pietosa in volto, sembra dica ferma: — Penitenza, figliolo, penitenza: prega in preghiera che non veda effetto; offriti sempre, anche se invan l’offerta; e mentre ‘atti senza sorte certa, umiliato, e come maledetto. Dio in misericordia ti conferma. ‘ |
Da qui, come prosegue Apollonio «una specie di poesia estesa; è l’acquisto di un mondo, mondo spaziale geografico, mondo storico, mondo spirituale. Poi, quando la dogmatica è diventata un fatto accettato, quando la vita religiosa ha obbedito e si esprime secondo i canoni formali, quando il Credo è una disciplina, direi quotidiana del vivere e del ripensare, allora questa religione di fronte alfe poesia, che è estesa, si presenta come intento, intento d’anima naturalmente, intenzione nel significato etimologico. In Rebora questi momenti sono dichiarati con estrema franchezza: il primo è poesia come vita, il secondo è invece l’officiatura».
La sua stessa vita è officiatura: è sacerdote, e la sua è parola «paraliturgica» che si deve piegare, non deve soverchiare, la preghiera, «forse nemmeno dichiararla, perché il momento della preghiera, la vita unitiva con Dio, basta a se stessa: è un’officiatura, un’aggiunta alla liturgia che il poeta come un buon artigiano va compiendo. Lode a Dio naturalmente la parola».
E proprio quest’officiatura, questa parola strumento dell’incontro e del rapporto con l’Assoluto può deludere, può apparire insipida. Avverte Getto: «Se a una considerazione puramente letteraria o, peggio, di poesia e non poesia la lettura dell’ultimo Rebora può apparire insipida o lasciarci delusi, ad un esame animato da più ricchi e vivaci umori essa si insapora di un gusto pungente, di un interesse avventuroso».
Il gusto avventuroso della totale immersione nel mistero, della totale decisione per Dio. Decisione di diventar strumento che vibra per la Verità, per la sola Verità che libera, cioè capace di mantenere la sua promessa: una verde fertile terra su cui finalmente poter posare il capo.
|
Gira la tròttola viva Gira la tròttola viva sotto la sferza, mercè là sferza; lasciata a sé giace priva, Stretta alla terra, odiando la tèrra;
fin che giace guarda il suolò; ogni cosa è ferma, e invidia il moto, insidia l’Ignoto; ma se poggia a un punto solo mentre va s’Impernia, e scorge intorno vede d’Intorno;
il cerchio massimo è in alto se erige il capo.se regge il corpo; nell’arie tersa è In risalto se leva il corpo, se eleva il capo;
gira — e il mondo variopinto fonde in sua bianchezza tutti i contorni, tutti i colori; gira, — e il mondo disunito fascia in sua purezza con tutti i cuori per tutti i giorni;
vive la trottola e gira, là sferza Iddio, la sferza è il tempo: così la trottola aspira dentro l’amore verso l’eterno. |
BIBLIOGRAFIA Opere di Clemente Rebora
PER UN LEOPARDI MAL NOTO (estratto). «Rivista d’Italia», Roma, settembre 1910. Tip. dell’Unione Ed., Roma, 1910.
G.D. ROMAGNOSI NEL PENSIERO DEL RISORGIMENTO, «Rivista d’Italia», Roma, novembre 1911.
FRAMMENTI LIRICI. Libreria della Voce. Firenze 1913.
CANTI ANONIMI raccolti da Clemente Rebora. Il Convegno Editoriale, Milano 1922.
LE POESIE (1913-1947) (Frammenti Lirici. Poesie sparse. Canti anonimi. Poesie religiose) raccolte ed edite a cura di Piero Rebora. Vallecchi, Firenze 1947.
VIA CRUCIS (Il gran grido). Le quattordici stazioni modellate da Francesco Messina. All’Insegna del Pesce d’Oro, Scheiwiller, Milano 1955.
CURRICULUM VITAE. Scheiwiller, Milano 1955. Premio Cittadella 1956.
CANTI DELL’INFERMITÀ. Scheiwiller, Milano 1956.
GESÙ IL FEDELE (Il Natale). Scheiwiller, Milano 1956.
CANTI DELL’INFERMITÀ. Raccolti da Vanni Scheiwiller. Scheiwiller, Milano 1957.
LE POESIE (1913-1957), All’insegna del pesce d’oro, Milano 1981 (a cura di Vanni Scheiwiller e con una nota di Giovanni Lucilio Mussini).
Saggi critici
MARIO APOLLONIO, Quaderno reboriano 1960, All’insegna del Pesce d’oro, Milano 1960.
FERDINANDO BANDINI, Ricerche sulla lingua poetica contemporanea, Liliana editrice, Padova.
GIANFRANCO CONTINI, Esercizi di lettura, Einaudi.
GIOVANNI GETTO, L’ultimo Rebora, in «Ausonia», luglio/agosto 1956.
RENATA LOLLO, Mania dell’eterno, in «Il ragguaglio librario», maggio 1968.
MARGHERITA MARCHIONE, L’imagine tesa. La vita e le opere di Clemente Rebora. Prefazione di G. Prezzolini, Ed. di Storia e Letteratura, Roma 1960.
PIER PAOLO PASOLINI, Passione e ideologia, Garzanti 1960.
BARBERI SQUAROTTI, Alcune indicazioni sullo stile di Clemente Rebora, in «La fiera letteraria», marzo 1958.




