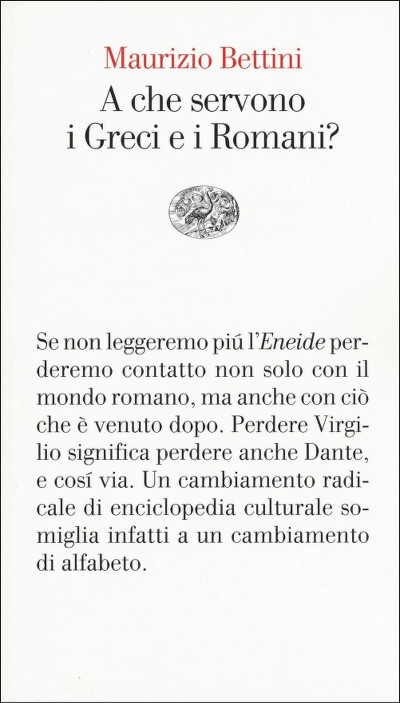 Tempi 27 Marzo 2017
Tempi 27 Marzo 2017
Con i nostri antenati greci e romani condividiamo molto più di quel che immaginiamo. Perfino il modo di pensare e di percepire le cose. Un filologo spiega perché
Maurizio Bettini
Abbiamo parlato del patrimonio culturale classico disseminato sul suolo italiano – sotto forma di monumenti, musei, biblioteche – e del secolare fiorire di studi che questa condizione ha prodotto, in Italia e nel mondo. A fronte di questo patrimonio culturale “esterno”, come potremmo chiamarlo, non bisogna però dimenticare che l’Italia ne possiede anche uno “interno”, la cui presenza rischia di essere ignorata o trascurata quando si parla di questi argomenti.
Si tratta infatti di “beni” che, a differenza di sculture o architetture, non si possono né osservare con gli occhi né toccare con le mani, un patrimonio fluido e astratto, ma che come tale è ancora più prezioso di quello visibile e tangibile. Ci riferiamo al fatto che l’enciclopedia culturale condivisa dagli italiani – il loro modo di vedere il mondo, articolarne l’esperienza, esprimerla – è profondamente legata alla cultura romana, in particolare, e attraverso di essa a quella greca. In primo luogo a motivo della lingua che parliamo.
Ad ogni livello infatti l’italiano manifesta una fortissima contiguità con la lingua latina, e fra le lingue moderne è certo quella che al latino è più vicina. Lo è a tal punto che – ci perdonino i linguisti – alla fin fine l’italiano è soltanto un latino parlato male. Marcel Proust, del resto, lo aveva già detto a proposito del meraviglioso francese in cui scriveva la Recherche: «Quelle parole che siamo così fieri di pronunziare con esattezza, non sono forse […] altrettanti errori fatti da bocche galliche, le quali pronunciavano a rovescio il latino? La nostra lingua non è che la pronuncia difettosa di alcune altre».
Ma davvero il latino sarebbe così difficile, astruso, tanto che i nostri poveri studenti, per impararlo, debbono rompersi la testa, con grave costernazione dei solleciti genitori? Non riesco a immaginare cosa accadrebbe se Cornelio Nepote dovessero tradurlo dal turco o dal magiaro. (…) Di recente un collega mi ha raccontato di uno studente cinese, iscritto a un’università per stranieri, che messo di fronte ad alcuni versi di Dante ha chiesto al professore, in perfetta buona fede: ma questo è italiano o latino? Aveva ragione lui, la sua distanza linguistica e culturale lo faceva veder meglio, e più chiaro, di quanto non accada a noi.
Quanti panni sciacquati nel Tevere
 Lasciando comunque da parte ironia, aneddoti e citazioni letterarie, è indiscutibile che l’italiano e il latino siano estremamente simili. Questa condizione è tale non solo perché l’italiano deriva direttamente dal latino, come sappiamo; ma perché nel nostro paese lo studio ininterrotto di questa lingua, da parte delle classi colte, ha fatto sì che lessico e sintassi dell’italiano continuassero a essere plasmati e arricchiti da un ininterrotto ritorno verso la propria origine. In altre parole, l’italiano non ha mai smesso di rilatinizzarsi. Non abbiamo forse continuato a studiare il latino per secoli? È raro trovare un manuale di letteratura italiana che non registri il trito aneddoto di Manzoni che andò a risciacquare in Arno i propri panni. Benissimo.
Lasciando comunque da parte ironia, aneddoti e citazioni letterarie, è indiscutibile che l’italiano e il latino siano estremamente simili. Questa condizione è tale non solo perché l’italiano deriva direttamente dal latino, come sappiamo; ma perché nel nostro paese lo studio ininterrotto di questa lingua, da parte delle classi colte, ha fatto sì che lessico e sintassi dell’italiano continuassero a essere plasmati e arricchiti da un ininterrotto ritorno verso la propria origine. In altre parole, l’italiano non ha mai smesso di rilatinizzarsi. Non abbiamo forse continuato a studiare il latino per secoli? È raro trovare un manuale di letteratura italiana che non registri il trito aneddoto di Manzoni che andò a risciacquare in Arno i propri panni. Benissimo.
Nessun manuale, però, si degna di ricordare le centinaia di scrittori, artisti e scienziati, le migliaia di preti, notai, medici, avvocati, bargelli, podestà, perfino capitani di ventura o dentisti, e chi più ne ha più ne metta, che nei secoli passati e fino a ieri hanno sistematicamente risciacquato il proprio linguaggio nella latine acque del Tevere. Imparando cioè a scrivere e parlare come si deve attraverso le frasi di Cesare o di Cicerone, e dunque rilatinizzando, ad ogni generazione, la lingua italiana.
Alla scoperta del nostro intelletto
Tutto ciò provoca delle conseguenze di grande importanza, che vanno ben al di là del far rilevare agli studenti – spesso peraltro con loro lieto stupore – il numero di parole italiane che hanno una trasparente etimologia latina; ovvero la matrice profondamente latina dell’aspetto più astratto della nostra articolazione linguistica, la struttura sintattica dell’italiano (quando ancora ci ricordiamo che esiste, usiamo il congiuntivo proprio come facevano i Romani).
Diciamo piuttosto che questa continuità fra l’universo linguistico latino e il nostro corrisponde anche a una continuità di pensiero, implica uno stesso e condiviso modo di segmentare e rappresentare la realtà attraverso il linguaggio. Conoscere il latino, approfondirne con intelligenza il lessico e la sintassi, significa contemporaneamente esplorare una parte consistente del nostro universo intellettuale. Come quando, per vedere con che faccia ci svegliamo al mattino, ci si mette di fronte a uno specchio.
Al di là del linguaggio, però, questo patrimonio culturale interno comprende anche un altro tipo di ricchezza, ugualmente proveniente dal mondo classico, e non meno importante della lingua che dai Romani abbiamo ereditato. In Italia, infatti, ad essere studiata per decine di secoli non è stata semplicemente la lingua latina, ma attraverso di lei lo sono stati anche e soprattutto i testi che ci venivano dagli autori Romani: Terenzio, Cesare, Cicerone, Virgilio, Ovidio, Seneca e così via.
 Non solo lingua, insomma, ma anche contenuti: personaggi, caratteri, pensieri, sentimenti, racconti, descrizioni del mondo. In pratica, a dispetto della caduta dell’impero romano, in Italia la cultura di Roma, intesa come il patrimonio di testi che essa ha prodotto, non ha mai smesso di essere studiata; in certa misura, si potrebbe dire che nel tempo la sua conoscenza è stata perfino ulteriormente approfondita e ampliata. Di conseguenza attraverso questa continua osmosi di letture e di studio, la tradizione culturale italiana è stata profondamente impregnata dalla presenza della cultura classica, quella romana e attraverso di essa quella greca. (…)
Non solo lingua, insomma, ma anche contenuti: personaggi, caratteri, pensieri, sentimenti, racconti, descrizioni del mondo. In pratica, a dispetto della caduta dell’impero romano, in Italia la cultura di Roma, intesa come il patrimonio di testi che essa ha prodotto, non ha mai smesso di essere studiata; in certa misura, si potrebbe dire che nel tempo la sua conoscenza è stata perfino ulteriormente approfondita e ampliata. Di conseguenza attraverso questa continua osmosi di letture e di studio, la tradizione culturale italiana è stata profondamente impregnata dalla presenza della cultura classica, quella romana e attraverso di essa quella greca. (…)
Ogni volta che si legge l’Eneide, per esempio, varrebbe la pena riflettere sul fatto che così facendo noi abbiamo un “libro” in comune con Giovanni Pascoli, con Alessandro Manzoni, con Ludovico Ariosto, con Dante Alighieri, con sant’Agostino e perfino con l’imperatore Augusto, alla cui presenza furono letti alcuni libri del poema. In altre parole, noi leggiamo lo stesso identico libro (provando dunque sentimenti simili, restando impressionati dalle stesse vicende, dalle stesse immagini) che è stato letto, tra gli altri, da un poeta che sette secoli fa ha scritto un’opera fondamentale per la lingua e per la cultura italiana; da un filosofo che quindici secoli fa ha impresso una svolta durevole alla cultura cristiana; da un imperatore che, venti secoli fa, nel bene e nel male ha mutato la storia del nostro continente e del mondo allora conosciuto.
Un flusso ininterrotto di memoria
Tutto ciò, inutile dirlo, crea uno straordinario meccanismo di continuità culturale, un flusso ininterrotto di memoria che si propaga spontaneamente all’interno della nostra tradizione. E vorrei sottolineare l’importanza dell’avverbio “spontaneamente”, perché la natura di questa continuità è tale che, per l’appunto, essa si perpetua anche in coloro che non ne hanno consapevolezza. Per fare solo un esempio banale, certe forme di pensiero che ci vengono attraverso le opere filosofiche di Cicerone (come la distinzione fra l’utile e l’onesto) sono presenti anche nell’esperienza di chi non ha mai sentito parlare del suo De officiis.
 Allo stesso modo in cui passare sotto un arco o sedere sotto una volta provoca in noi una sorta di benessere estetico anche se non si è consapevoli del fatto che queste forme costruttive ci giungono dall’architettura antica. Il fatto è che le opere filosofiche di Cicerone, o l’Eneide di Virgilio, costituiscono comunque dei “libri condivisi”, in quanto divenuti parte di una comune enciclopedia culturale. A questo punto, anzi, tanto varrebbe dare a questi libri il nome che meritano: “classici”.
Allo stesso modo in cui passare sotto un arco o sedere sotto una volta provoca in noi una sorta di benessere estetico anche se non si è consapevoli del fatto che queste forme costruttive ci giungono dall’architettura antica. Il fatto è che le opere filosofiche di Cicerone, o l’Eneide di Virgilio, costituiscono comunque dei “libri condivisi”, in quanto divenuti parte di una comune enciclopedia culturale. A questo punto, anzi, tanto varrebbe dare a questi libri il nome che meritano: “classici”.
Per quanto ci siano state, e tuttora ci siano, molte discussioni su che cosa renda “classica” una certa opera – e soprattutto su quali opere meritino di essere definite tali – credo si possa essere d’accordo almeno su questo: per essere considerata un classico, una certa opera deve essere stata letta e studiata da molte generazioni di individui, tanto che la sua sostanza si sia fusa, in modo spesso inseparabile, con quella della cultura successiva. I classici costituiscono il midollo della nostra cultura.
La nostra enciclopedia culturale presenta dunque una fortissima contiguità, anzi continuità, con quella romana. Una continuità che si manifesta attivamente non solo attraverso la lingua, come abbiamo detto sopra, ma anche e soprattutto in ragione dei modelli culturali – etici, psicologici, comportamentali, affettivi: ma anche architettonici, artistici, cromatici… – che si sono insediati nella nostra percezione del mondo attraverso l’ininterrotta consuetudine con la classicità.
Tratto da A che servono i Greci e i Romani?, Einaudi 2017, 160 pagine, 12 euro
_______________
Leggi anche:
L’Europa è nata in pellegrinaggio e la sua lingua materna è il latino




