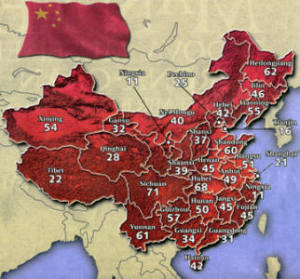dal sito Arcipelago Laogai
dal sito Arcipelago Laogai
15 Dicembre 2019
Articolo tratto da Forbes, del 14/12/2019
Traduzione di: a cura di Arcipelago Laogai
Le recenti fughe di documenti segreti che descrivono in dettaglio il funzionamento dei campi di internamento nella regione cinese dello Xinjiang hanno cambiato il gioco per le imprese straniere che hanno interessi economici con operazioni e fornitori nella regione.
Giornalisti e gruppi per i diritti umani avevano documentato a lungo l’esistenza dei campi sulla base delle testimonianze dei sopravvissuti, dei documenti sugli appalti pubblici e di immagini satellitari che mostravano la rapida espansione di questi campi.
 Inizialmente il governo cinese ha negato la loro esistenza, ma dopo che le prove sono diventate inconfutabili, Pechino ha iniziato a chiamare i campi “centri di istruzione professionale” e ha affermato che erano necessari per sradicare il terrorismo e il separatismo.
Inizialmente il governo cinese ha negato la loro esistenza, ma dopo che le prove sono diventate inconfutabili, Pechino ha iniziato a chiamare i campi “centri di istruzione professionale” e ha affermato che erano necessari per sradicare il terrorismo e il separatismo.
Negli ultimi due anni circa 1,5 milioni di membri di minoranze etniche tra cui uiguri, kazaki, kirghisi e huis sono stati rinchiusi all’interno dei campi, secondo ricercatori e governi stranieri. I sopravvissuti al campo parlano di torture e abusi e di essere stati costretti a rinunciare alla loro lingua e tradizioni.
Una volta rilasciati dai campi di internamento, si dice che le persone siano inserite in un sistema di lavoro forzato in cui guadagnano appena $ 100 al mese e continuano a essere monitorate, indottrinate e tenute separate dai loro familiari.
 Aziende come Adidas, Hennes & Mauritz, Kraft Heinz e Coca-Cola sono state collegate alla campagna di lavoro forzato e di assimilazione nello Xinjiang. All’inizio di quest’anno, i rappresentanti delle società hanno dichiarato al Wall Street Journal di aver adottato una serie di misure, come indagare sulle loro catene di approvvigionamento e sospendere gli acquisti da determinati fornitori.
Aziende come Adidas, Hennes & Mauritz, Kraft Heinz e Coca-Cola sono state collegate alla campagna di lavoro forzato e di assimilazione nello Xinjiang. All’inizio di quest’anno, i rappresentanti delle società hanno dichiarato al Wall Street Journal di aver adottato una serie di misure, come indagare sulle loro catene di approvvigionamento e sospendere gli acquisti da determinati fornitori.
 Tuttavia, le fughe di notizie di novembre al New York Times e al Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi (ICIJ) hanno sollevato la posta in gioco nel Xinjiang. I documenti dimostrano che i cosiddetti “centri di formazione professionale” erano destinati sin dall’inizio a servire come centri di internamento per le minoranze etniche.
Tuttavia, le fughe di notizie di novembre al New York Times e al Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi (ICIJ) hanno sollevato la posta in gioco nel Xinjiang. I documenti dimostrano che i cosiddetti “centri di formazione professionale” erano destinati sin dall’inizio a servire come centri di internamento per le minoranze etniche.
 Secondo i documenti, interi gruppi di persone sono stati arrestati in base alla massiccia raccolta di dati e algoritmi. Joerg Wuttke, presidente della Camera di commercio dell’Unione europea in Cina durante una tavola rotonda dei media di questa settimana ha dichiarato: “Quello che posso dire è che tutti noi sapevamo che prima delle fughe di notizie che c’era qualcosa che non andava bene, e penso che abbiamo fatto in modo di assicurarci che nelle nostre operazioni tutto si sia svolto secondo gli standard internazionali. Ma penso che ciò che il New York Times e altri giornali stanno guardando con occhio troppo severo le nostre catene di approvvigionamento”.
Secondo i documenti, interi gruppi di persone sono stati arrestati in base alla massiccia raccolta di dati e algoritmi. Joerg Wuttke, presidente della Camera di commercio dell’Unione europea in Cina durante una tavola rotonda dei media di questa settimana ha dichiarato: “Quello che posso dire è che tutti noi sapevamo che prima delle fughe di notizie che c’era qualcosa che non andava bene, e penso che abbiamo fatto in modo di assicurarci che nelle nostre operazioni tutto si sia svolto secondo gli standard internazionali. Ma penso che ciò che il New York Times e altri giornali stanno guardando con occhio troppo severo le nostre catene di approvvigionamento”.
 Ciò che renderà ancora più difficile, forse, per le aziende è la crescente pressione pubblica. Gli uiguri all’estero hanno iniziato a utilizzare gli hashtag #ShameOnVW e #BoycottVW sui social media, confrontando la presenza di Volkswagen in Germania durante la seconda guerra mondiale con l’attuale coinvolgimento dell’azienda nello Xinjiang.
Ciò che renderà ancora più difficile, forse, per le aziende è la crescente pressione pubblica. Gli uiguri all’estero hanno iniziato a utilizzare gli hashtag #ShameOnVW e #BoycottVW sui social media, confrontando la presenza di Volkswagen in Germania durante la seconda guerra mondiale con l’attuale coinvolgimento dell’azienda nello Xinjiang.
La SAIC Volkswagen, l’accordo tra Volkswagen e la casa automobilistica cinese SAIC Motor, ha aperto una fabbrica a Urumqi, la capitale dello Xinjiang, nel 2013, dove attualmente produce il modello Volkswagen Santana. Volkswagen afferma in una dichiarazione che non ci sono indicazioni di violazioni dei diritti umani nella sua fabbrica e che la società ritiene che “nessun dipendente è costretto a lavorare”.
La società afferma di voler dare un contributo allo “sviluppo locale positivo nello Xinjiang” e che è a conoscenza della situazione nella regione. Secondo un rapporto del Center of Strategic and International Studies.
Altre società, tra cui i rivenditori giapponesi Muji e Uniqlo, sono state prese di mira per pubblicizzare il loro uso di forniture di cotone dallo Xinjiang. La regione produce l’84% del cotone cinese.
Oltre alla necessità per le società straniere di controllare le loro catene di approvvigionamento e garantire che le loro operazioni siano conformi ai codici di condotta internazionali, la domanda più ampia da porsi è se a questo punto è persino possibile fare affari etici nello Xinjiang.
Questa settimana Adrian Zenz, un ricercatore di spicco dello Xinjiang, ha sostenuto in un articolo di politica estera che in realtà non è possibile, scrivendo: “L’attuale Xinjiang è diverso da quasi tutti gli altri difficili ambienti politici del pianeta e l’equilibrio di potere è tutto a favore dello stato. Qualunque bene possa derivare dalla Better Cotton Initiative o dalla Volkswagen che operano nello Xinjiang, il guadagno della Cina è di gran lunga superiore a quello di queste società”
 Ha aggiunto: “Il punto più ampio è che gli approcci tradizionali per identificare casi specifici di lavoro forzato non funzionano per lo Xinjiang. Nella stragrande maggioranza dei casi, tali prove non saranno mai direttamente disponibili. L’intreccio in atto di diverse forme di formazione e lavoro involontari e il livello di controllo che il Partito Comunista esercita sulle società rendono tali missioni conoscitive ancora più inutili. L’unica soluzione praticabile è considerare l’intera regione sfrutta a fondo diverse forme di lavoro coercitivo. Questo significa che tutto o in parte di ciò che viene realizzato o prodotto nello Xinjiang dovrebbe trovare posto in una catena di approvvigionamento eticamente pulita ”.
Ha aggiunto: “Il punto più ampio è che gli approcci tradizionali per identificare casi specifici di lavoro forzato non funzionano per lo Xinjiang. Nella stragrande maggioranza dei casi, tali prove non saranno mai direttamente disponibili. L’intreccio in atto di diverse forme di formazione e lavoro involontari e il livello di controllo che il Partito Comunista esercita sulle società rendono tali missioni conoscitive ancora più inutili. L’unica soluzione praticabile è considerare l’intera regione sfrutta a fondo diverse forme di lavoro coercitivo. Questo significa che tutto o in parte di ciò che viene realizzato o prodotto nello Xinjiang dovrebbe trovare posto in una catena di approvvigionamento eticamente pulita ”.