 [intervento al Congresso internazionale su I valori permanenti nel divenire storico. Roma, 3-6 ottobre 1968, pubblicato in Ethica, 1969, II, pp. 107-119].
[intervento al Congresso internazionale su I valori permanenti nel divenire storico. Roma, 3-6 ottobre 1968, pubblicato in Ethica, 1969, II, pp. 107-119].
di Augusto del Noce
La crisi presente della fiducia in valori permanenti richiama alla memoria quella che si verifica nei primi anni del Seicento. Si trattava anche allora del periodo successivo alle guerre di religione e alle scoperte di civiltà diverse da quelle mediterranee; e anche allora fu messa in discussione, insieme con l’assolutezza dei valori, la tradizione comune del pensiero greco e del pensiero cristiano.
Allora, però, l’affermazione della relatività storica dei valori appariva come una sfida al senso comune. Oggi, invece, l’idea che quelli che erano stati tradizionalmente creduti valori permanenti siano sempre condizionati da situazioni determinate e abbiano fatto la loro apparizione come corollari di definite situazioni sociali, ha completamente permeato la sensibilità comune.
 Inoltre il pensiero di coloro che allora si dicevano i deniaisés, quelli che avevano perso l’ingenuità in dipendenza dell’amplificazione dell’esperienza, si richiamava al pensiero antico nelle linee che apparivano incomponibili col cristianesimo. Oggi invece il sentimento comune è di vivere in un’epoca nuova, separata dal passato dalla cesura delle due guerre mondiali.
Inoltre il pensiero di coloro che allora si dicevano i deniaisés, quelli che avevano perso l’ingenuità in dipendenza dell’amplificazione dell’esperienza, si richiamava al pensiero antico nelle linee che apparivano incomponibili col cristianesimo. Oggi invece il sentimento comune è di vivere in un’epoca nuova, separata dal passato dalla cesura delle due guerre mondiali.
All’idea che tutto si ripete si è sostituita l’accelerazione massima del tempo; l’adeguazione a un oggi che non è più tanto il compimento dell’ieri quanto la sua negazione. Di più, nel Seicento la critica delle autorità condusse a ricercare nella coscienza l’autorità dei valori.
Oggi, è la coscienza stessa che viene posta in dubbio; si è instaurata quella che Ricoeur chiama la scuola del sospetto, la decisione di considerare la coscienza nel suo insieme come falsa; maestri Marx, Nietzsche e Freud. I termini di demistificazione, di demitizzazione e simili appartengono ormai alla cultura elementare.
 Come è avvenuto questo mutamento della sensibilità? Una risposta estremamente semplice è quella secondo cui il sentimento di vivere in un’epoca nuova, tale che si possa affermare che l’uomo è una “realtà antiquata”, sarebbe da riferire, come a suo riflesso, al progresso tecnico o allo sviluppo delle scienze dell’uomo.
Come è avvenuto questo mutamento della sensibilità? Una risposta estremamente semplice è quella secondo cui il sentimento di vivere in un’epoca nuova, tale che si possa affermare che l’uomo è una “realtà antiquata”, sarebbe da riferire, come a suo riflesso, al progresso tecnico o allo sviluppo delle scienze dell’uomo.
Ora io non credo che sia così: penso invece che alla base del mutamento ci sia un giudizio storico sul periodo delle due guerre mondiali e soprattutto sul ventennio tra le due guerre.
Si è oggi generalizzato questo pensiero: coloro che in qualsiasi senso, diretto oppure dissimulato, parlavano o parlano di valori permanenti o di verità assolute, di fatto coprivano o coprono, dietro a queste affermazioni, ancor più che la difesa di interessi particolari, la paura del trascendimento storico, di quell’intramondano procedere oltre che fa apparire come provvisoria ogni posizione che l’uomo abbia raggiunta.
 Senza questa falsa coscienza, che per sé è un fenomeno transpolitico, neppure avrebbero potuto affermarsi i fascismi come fenomeno politico. Non già che questo conservatorismo ideale abbia significato, almeno in generale, un consenso diretto: ma l’opposizione a quello che, tra il ’30 e il ’40, veniva detto il vitalismo o l’irrazionalismo fascista, doveva confinarsi in questi assertori della tradizione in una dimensione puramente morale.
Senza questa falsa coscienza, che per sé è un fenomeno transpolitico, neppure avrebbero potuto affermarsi i fascismi come fenomeno politico. Non già che questo conservatorismo ideale abbia significato, almeno in generale, un consenso diretto: ma l’opposizione a quello che, tra il ’30 e il ’40, veniva detto il vitalismo o l’irrazionalismo fascista, doveva confinarsi in questi assertori della tradizione in una dimensione puramente morale.
A partire da ciò si è passati facilmente all’idea che questi valori permanenti abbiano cessato di essere una guida efficace per l’azione; e poiché questo atteggiamento di attaccamento al passato viene genericamente denominato romanticismo diventò corrente l’opporre allo storicismo tradizionalista, di tipo romantico, uno storicismo illuminista, o addirittura vedere nella liberazione dal romanticismo il problema ideale del dopoguerra.
Quando questa scuola del sospetto ha preso inizio? Che tale inizio abbia coinciso con la riscoperta del marxismo filosofico, già avvenuta in Germania negli anni intorno al ’20, ripresa, senza rapporto diretto, in Francia negli anni tra il ’30 e il ’40, esplosa poi negli anni dopo il ’45, è quel che sarebbe troppo facile documentare (basti pensare a scrittori marxisti francesi degli anni intorno al ’30, a un Politzer, a un Gutermann, a un Lefebvre o a un Nizan).
 A differenza di quel che era accaduto negli ultimi anni dell’800, il marxismo fu riscoperto proprio a partire da questa tesi della denuncia della “falsa coscienza”. In relazione a questo modo di riscoperta, non c’è da meravigliarsi della recente elevazione di Freud, da inventore di un metodo terapeutico a grande filosofo.
A differenza di quel che era accaduto negli ultimi anni dell’800, il marxismo fu riscoperto proprio a partire da questa tesi della denuncia della “falsa coscienza”. In relazione a questo modo di riscoperta, non c’è da meravigliarsi della recente elevazione di Freud, da inventore di un metodo terapeutico a grande filosofo.
Consideriamo infatti la differenza tra la valutazione del significato filosofico dell’opera freudiana quale era stata data nel 1936 nella più importante opera di carattere filosofico che gli fosse stata sino allora dedicata, quella di Roland Dalbiez: l’opera di Freud è l’esplorazione di quel che nell’uomo è il non umano.
Che oggi gli scritti su Freud si muovano nel significato opposto, di cercarvi un metodo di comprensione dell’uomo, non si può spiegare senza quel richiamo alla teoria della falsa coscienza alle origini della cui riscoperta si è accennato.
La veduta che ora vorrei proporre è esattamente l’opposta: quella che negli anni dal ’45 a oggi sia avvenuta l’autoconsunzione delle idee contrapposte a quella di valori permanenti: quella di rivoluzione, quella di progresso, idee che oggi si sono affatto dissociate, e infine della stessa idea di modernità come valore, in modo che oggi si ripresentano le condizioni per una riscoperta nel loro senso vero dell’idea della permanenza e dell’assolutezza dei valori.
 In qualche misura, proprio questi ultimi anni, e vorrei anzi dire, la contestazione di quest’anno 1968 — che fu il più ricco di filosofia implicita dal ’45 a oggi, — ha fornito l’occasione storica per un rovesciamento degli idoli. Il sospetto si è rovesciato proprio sull’idea normalmente ammessa secondo cui il compito del pensiero presente sarebbe la liberazione da quei tabù repressivi, che interdicono la libera esplicazione dell’attività umana.
In qualche misura, proprio questi ultimi anni, e vorrei anzi dire, la contestazione di quest’anno 1968 — che fu il più ricco di filosofia implicita dal ’45 a oggi, — ha fornito l’occasione storica per un rovesciamento degli idoli. Il sospetto si è rovesciato proprio sull’idea normalmente ammessa secondo cui il compito del pensiero presente sarebbe la liberazione da quei tabù repressivi, che interdicono la libera esplicazione dell’attività umana.
Rapidamente accenniamo all’idea di rivoluzione, intesa nel senso forte, per cui è vista come la soluzione del mistero della storia attraverso quell’evento unico che medierebbe il passaggio dal regno della necessità — cioè della dipendenza dell’uomo dalle cose e particolarmente dalle cose che egli ha prodotto, dalla reificazione, dalla alienazione — a quello della libertà.
La liberazione è vista come un’autoredenzione dell’uomo; in quest’opera alla religione si sostituirebbe la politica, come politica che ha però inglobato in sé la religione. Onde nel marxismo, la morale, la religione, la metafisica, ogni altro aspetto dell’ideologia e le loro corrispondenti forme di coscienza non mantengono più la loro apparente indipendenza.
 La storia dell’idea rivoluzionaria in questo preciso senso è stata più volte tracciata, il suo percorso da Rousseau a Marx, le sue connessioni col millenarismo, il carattere precristiano del millenarismo, legato a un messianismo ebraico che non mantiene più significato dopo la venuta del messia, il suo continuo incontrarsi col pensiero eretico, il processo di secolarizzazione a cui si trova esposto.
La storia dell’idea rivoluzionaria in questo preciso senso è stata più volte tracciata, il suo percorso da Rousseau a Marx, le sue connessioni col millenarismo, il carattere precristiano del millenarismo, legato a un messianismo ebraico che non mantiene più significato dopo la venuta del messia, il suo continuo incontrarsi col pensiero eretico, il processo di secolarizzazione a cui si trova esposto.
Ora, il punto su cui merita di essere portata l’attenzione è il seguente: il pensiero rivoluzionario marxista, che pretendeva di essere il compimento dell’incompiuta rivoluzione francese, in quanto in essa aveva avuto il trionfo la classe borghese, è stato di fatto l’occasione per il compimento dello spirito borghese nella società cosiddetta tecnologica, termine che qui non uso per designare una società caratterizzata dall’incremento dell’attività scientifica e tecnica, ma invece dalla concezione della ragione strumentale ossia dell’interpretazione dell’intera attività umana in termini di attività tecnica.
Importa qui vedere brevemente l’opposizione tra il pensiero rivoluzionario e la società tecnologica, il carattere necessario per cui il primo porta al successo della seconda, la rottura che si stabilisce tra l’idea di rivoluzione e quella di progresso, le contraddizioni della società tecnologica e l’impossibilità del loro superamento da parte del pensiero rivoluzionario, almeno nella forma in cui lo si è prima definito; e ciò al tempo stesso che si deve riconoscere la validità morale delle critiche che il pensiero rivoluzionario muove a certi aspetti necessari della società tecnologica.
 L’opposizione è ben messa in chiaro in quella che resta la principale opera del Marcuse, Ragione e rivoluzione, attraverso i termini di pensiero negativo o dialettico e pensiero positivo; opposizione, in sostanza, tra Marx e Comte. La sua diagnosi può essere in molta parte seguita, ma interpretata come segno non già della ripresa del pensiero rivoluzionario, ma dell’impossibilità di questa ripresa.
L’opposizione è ben messa in chiaro in quella che resta la principale opera del Marcuse, Ragione e rivoluzione, attraverso i termini di pensiero negativo o dialettico e pensiero positivo; opposizione, in sostanza, tra Marx e Comte. La sua diagnosi può essere in molta parte seguita, ma interpretata come segno non già della ripresa del pensiero rivoluzionario, ma dell’impossibilità di questa ripresa.
Come definire infatti la società tecnologica, quando la si intende non già come quella in cui attraverso lo sfruttamento pieno delle forze della natura sia stata completamente eliminata la distinzione tra liberi e schiavi, realizzando un mondo in cui il lavoro delle macchine permetterebbe all’uomo l’esercizio soltanto di quelle attività che sono specificamente umane, ma invece come quella che è caratterizzata, per così dire, dal totalitarismo dell’attività tecnica, per cui l’intera attività dell’uomo viene interpretata come ordinata alla trasformazione e al possesso?
 Ne proporrei la definizione seguente: è una società che accetta tutte le negazioni del marxismo nel riguardo del pensiero contemplativo, della religione e della metafisica; che accetta quindi la riduzione marxista delle idee a strumento di produzione; ma che d’altra parte rifiuta del marxismo gli aspetti rivoluzionario-messianici, quindi quel che di religioso rimane nell’idea rivoluzionaria.
Ne proporrei la definizione seguente: è una società che accetta tutte le negazioni del marxismo nel riguardo del pensiero contemplativo, della religione e della metafisica; che accetta quindi la riduzione marxista delle idee a strumento di produzione; ma che d’altra parte rifiuta del marxismo gli aspetti rivoluzionario-messianici, quindi quel che di religioso rimane nell’idea rivoluzionaria.
Sotto questo riguardo rappresenta veramente lo spirito borghese allo stato puro; lo spirito borghese che ha trionfato dei suoi due tradizionali avversari, la religione trascendente e il pensiero rivoluzionario. Si potrebbe forse arrivare a dire, e documentarlo coi testi del Manifesto: per una singolare eterogenesi dei fini il marxismo ha condotto lo spirito borghese a manifestarsi allo stato puro, ma, una volta che ha raggiunto questo, si trova impotente a combatterlo.
La società tecnologica segna l’abdicazione del marxismo nei riguardi degli inventori dell’organizzazione razionale della società industriale, Saint-Simon e Comte, considerando anche qui in Saint-Simon e Comte l’aspetto per cui essi sono rappresentanti dell’esprit polytechnique, separato da quello della bizzarra religione a cui volevano congiungerlo.
 Una tale definizione mi sembra facilmente accettabile, perché corrisponde a giudizi che possono bensì essere visti come problematici, ma che tuttavia sono consolidati nella pubblicistica corrente.
Una tale definizione mi sembra facilmente accettabile, perché corrisponde a giudizi che possono bensì essere visti come problematici, ma che tuttavia sono consolidati nella pubblicistica corrente.
Non si sente ripetere di continuo che, come materialismo storico, il marxismo deve riconoscere che le posizioni di pensiero variano col variare delle forme di produzione e che, oggi, la trasformazione conseguente all’avvento dell’età tecnologica costringe a considerare il marxismo rivoluzionario come una posizione del passato, che poteva essere vera “allora”, ma che, “oggi”, non lo è più, perché la realtà è mutata?
Oppure l’altro equivalente giudizio: anche il marxismo rivoluzionario può ancora sussistere nelle zone di sottosviluppo; ma quando lo sviluppo è avvenuto, esso deve, per mantenere il suo carattere scientifico, rinnovarsi, altrimenti esso si dissolve in un romanticismo anarchico?
 In giudizi di questo tipo si potrebbe continuare all’infinito: quel che importa è osservare che la società del benessere, con il dimostrarsi atta ad abolire la miseria, o almeno di essere sulla via di poterlo fare, ha tolto al marxismo la molla rivoluzionaria della dialettica delle classi.
In giudizi di questo tipo si potrebbe continuare all’infinito: quel che importa è osservare che la società del benessere, con il dimostrarsi atta ad abolire la miseria, o almeno di essere sulla via di poterlo fare, ha tolto al marxismo la molla rivoluzionaria della dialettica delle classi.
Che quella che viene chiamata società tecnologica o società del benessere o società opulenta, si sia formata come società successiva al marxismo, ma insieme come società totalmente secolarizzata, è ciò che si impone con grande evidenza.
All’indomani della guerra la società borghese si trovava a dover respingere due avversari: uno era il comunismo, ma non meno temibile era il pericolo di un risveglio religioso. Si deve dire che con l’invenzione della società tecnologica si è mostrata adeguata alla soluzione del problema, respingendo insieme il comunismo in nome della democrazia e il pensiero religioso in nome della modernità, e costruendo un’unità illuministica del pensiero laico tra liberalismo e socialismo e un’altra parallela nella forma di modernismo religioso.
 È riuscita così a costruire una società che regge sull’equilibrio delle contraddizioni. Indubbiamente, il sentimento di essere nuova corrisponde per questa società a qualcosa di effettivamente reale. Non soltanto si dice nuova, lo è.
È riuscita così a costruire una società che regge sull’equilibrio delle contraddizioni. Indubbiamente, il sentimento di essere nuova corrisponde per questa società a qualcosa di effettivamente reale. Non soltanto si dice nuova, lo è.
Tuttavia, novità può significare compimento e può significare sradicamento; si direbbe che vi si rifletta l’ambiguità del termine tanto usato da Hegel: aufheben, superare, che può significare così conservare come abolire. Onde lo stato d’animo composito della gioventù di oggi, in cui non si sa se prevalga l’orgoglio del nuovo o la paura dello sradicamento; e in cui l’attivismo distruttivo sembra esprimere l’angoscia di chi si sente sradicato.
È da notare come questa società sopravviva soltanto per un tacito ricorso alle riserve di quei valori permanenti, sulla cui negazione pure si è edificata. Consideriamo, ad esempio, le idee correnti sulla funzione purificatrice che avrebbe la scienza rispetto ai problemi politici, ai morali, ai religiosi.
Limitiamoci qui ai problemi morali. Si dice ad esempio: le scienze dell’uomo permettono di comprendere coloro che siamo abituati a considerare delinquenti perché hanno trasgredito a una norma; siccome per grandissima parte il loro deviare è dipeso da certe condizioni psicologico-morali, le scienze dell’uomo ci permettono di sentirci corresponsabili delle colpe che hanno commesso e al tempo stesso ci pongono nelle migliori condizioni per assisterli.
 Ha termine la contrapposizione tra il giudice che rappresenta soltanto la giustizia e il reo che soltanto personifica la colpa. Ora questo ragionamento è certo corretto, ma presuppone l’esistenza di quei valori permanenti che si vorrebbero negare e l’utilizzazione della scienza al loro servizio.
Ha termine la contrapposizione tra il giudice che rappresenta soltanto la giustizia e il reo che soltanto personifica la colpa. Ora questo ragionamento è certo corretto, ma presuppone l’esistenza di quei valori permanenti che si vorrebbero negare e l’utilizzazione della scienza al loro servizio.
Quando parliamo del significato morale che la scienza può assumere, sempre presupponiamo nell’uomo la presenza di un principio ideale che lo costituisce fine in se stesso. Se noi invece pensassimo abolita ogni traccia di valori permanenti, se pensassimo l’uomo ridotto alla pura dimensione scientifica e tecnica, non si vede perché non dovrebbe valere quello che asserì molti anni fa l’Adorno a proposito della Juliette di Sade: che essa incarna esattamente il tipo che ha per credo soltanto la scienza; anzi, che essa opera con la semantica e la sintassi logica come il positivismo più moderno.
Vi è quindi nella società del benessere una contraddizione palese tra l’umanitarismo teoricamente professato e lo spirito di disumanizzazione praticamente attuato, nella misura in cui diminuiscono — e devono necessariamente diminuire — le riserve di valori tradizionali.
 Un’altra contraddizione, poi, è dato ritrovare nei contrasto stridente tra una tolleranza apparente e un totalitarismo reale, in quanto una società così configurata non può più ammettere autonomia di sovrastrutture culturali, religiose e politiche.
Un’altra contraddizione, poi, è dato ritrovare nei contrasto stridente tra una tolleranza apparente e un totalitarismo reale, in quanto una società così configurata non può più ammettere autonomia di sovrastrutture culturali, religiose e politiche.
La cultura vi è per definizione mercé di consumo o, quando vi è scientificamente ricercata e apprezzata, è a sua volta strumento per l’ulteriore incremento di efficienza e di produzione. Sembra dunque che senza un appello a valori permanenti non possa essere salvato l’aspetto positivo della società tecnologica.
È curioso come ciò si trovi parzialmente confermato dagli stessi movimenti contestativi. Consideriamo. Viene abitualmente chiamata contestazione la critica della società tecnologica in nome del pensiero rivoluzionario.
 Si tratterebbe ora di dimostrare: 1) come la forma tracciata dal Marcuse esprima effettivamente l’unica possibilità di riaffermazione del pensiero rivoluzionario dopo la società tecnologica; 2) come d’altra parte una tale riaffermazione concluda nella decomposizione del pensiero rivoluzionario stesso; 3) come in questa decomposizione riemerga espressamente il problema dei valori permanenti.
Si tratterebbe ora di dimostrare: 1) come la forma tracciata dal Marcuse esprima effettivamente l’unica possibilità di riaffermazione del pensiero rivoluzionario dopo la società tecnologica; 2) come d’altra parte una tale riaffermazione concluda nella decomposizione del pensiero rivoluzionario stesso; 3) come in questa decomposizione riemerga espressamente il problema dei valori permanenti.
È stato giustamente osservato da un critico cattolico che nel pensiero di Marcuse ciò che vi è di buono non è nuovo, e ciò che vi è di nuovo non è buono. D’accordo: ma resta il fatto che quando Marcuse muove la sua critica alla società unidimensionale si trova curiosamente forzato a ragionare in termini di metafisica classica.
 Da un punto di vista marxista non possono infatti non apparire stupefacenti le critiche conclusive che egli muove alla società opulenta, di essere costretta a insidiare la sfera privata dell’individuo, persino nelle quattro mura della sua casa.
Da un punto di vista marxista non possono infatti non apparire stupefacenti le critiche conclusive che egli muove alla società opulenta, di essere costretta a insidiare la sfera privata dell’individuo, persino nelle quattro mura della sua casa.
Ma quel che più importa è il fatto che egli conduce la critica del nuovo positivismo esattamente come un discepolo di alto livello della metafisica classica : quel che dice, ad esempio, sul senso che si deve dare alla realtà degli universali, sulla connessione tra universale e valore, sulla rivalutazione del concetto astratto, ha il sapore della riscoperta del significato vero delle tesi che stanno a fondamento dell’idea dei valori permanenti; e propongono il problema come ciò sia dovuto avvenire pur essendo ovviamente da escludere che egli sia ricorso esplicitamente alla metafisica classica: poiché, anzi, quando egli accorge di queste coincidenze, ha premura di avvertire il lettore che le sue affermazioni non implicano in modo alcuno una reminiscenza di “valori spirituali” o di cose simili; e di definire anzi il suo ideale di una realtà umana essenzialmente nuova “in un’esistenza piena di tempo libero sulla base dei bisogni vitali soddisfatti” (1).
 In realtà, è facile scorgere quale sia la contraddizione ultima, attestata dalle contraddizioni parziali del suo pensiero. C’è per lui un punto che resta indiscusso già dall’inizio, in Ragione e rivoluzione: quello che lo hegelo-marxismo debba essere interpretato come critica di tutto ciò che sino allora era considerato come verità oggettiva, e insieme come la filosofia che ha assunto le verità di tutte le precedenti filosofie, e in essa tutta l’esperienza che l’umanità ha accumulato nel corso del suo lungo cammino verso la verità (2); e che, d’altra parte, se Hegel non aveva concluso in Marx era soltanto perché la ragione dei tempi lo aveva costretto alla rassegnazione.
In realtà, è facile scorgere quale sia la contraddizione ultima, attestata dalle contraddizioni parziali del suo pensiero. C’è per lui un punto che resta indiscusso già dall’inizio, in Ragione e rivoluzione: quello che lo hegelo-marxismo debba essere interpretato come critica di tutto ciò che sino allora era considerato come verità oggettiva, e insieme come la filosofia che ha assunto le verità di tutte le precedenti filosofie, e in essa tutta l’esperienza che l’umanità ha accumulato nel corso del suo lungo cammino verso la verità (2); e che, d’altra parte, se Hegel non aveva concluso in Marx era soltanto perché la ragione dei tempi lo aveva costretto alla rassegnazione.
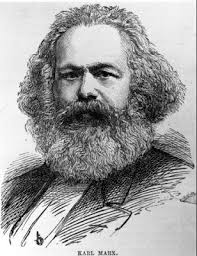 Per la connessione, dunque, tra ragione e rivoluzione, il suo pensiero non può fermarsi nella pura critica della realtà presente come abnorme, oltre a tutto perché in tal caso egli si troverebbe costretto a un processo di ritrovamento di una realtà normativa trascendente, ossia di quell’idea del Logos che egli presenta invece come il principio del pensiero repressivo.
Per la connessione, dunque, tra ragione e rivoluzione, il suo pensiero non può fermarsi nella pura critica della realtà presente come abnorme, oltre a tutto perché in tal caso egli si troverebbe costretto a un processo di ritrovamento di una realtà normativa trascendente, ossia di quell’idea del Logos che egli presenta invece come il principio del pensiero repressivo.
Ma, siccome non può neppure riprendere il marxismo originario perché la situazione nella società tecnologica ha portato a una forma di dipendenza reciproca “che non è più la relazione dialettica tra il Padrone e il Servo, spezzata nella lotta per essere riconosciuto dall’altro, ma è piuttosto un vicolo vizioso che racchiude sia il padrone che il servo” (3); dato inoltre che la civiltà nel suo processo produttivo ha questa funzione repressiva e alienante, ne viene che la rivoluzione non può generarsi dall’interno della società industriale.
Di qui la sua posizione forzatamente astorica: poiché non è dal processo storico che ci si può attendere la rivoluzione che porti alla libertà, in quanto questo processo è storia della ragione repressiva, il passaggio alla libertà si otterrà soltanto attraverso l’eliminazione della repressione degli istinti.
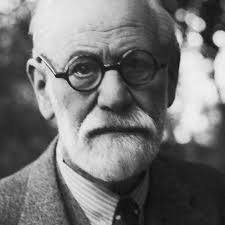 È su questo punto che si opera la curiosa contaminazione di motivi marxisti e di motivi freudiani — di un freudismo particolare dato che il Freud reale aveva sostenuto la necessità della repressione per la civiltà. Ma allora la liberazione non potrebbe operarsi che sulla base dello scatenamento di forze primitive e in qualche maniera, per la loro estraneità alla civiltà, barbare; a una liberazione che sorgerebbe dall’interno per la dialettica delle classi si sostituisce in Marcuse una liberazione che viene dall’esterno. Solo queste forze primigenie avrebbero la capacità di abolire i modi della repressione produttiva.
È su questo punto che si opera la curiosa contaminazione di motivi marxisti e di motivi freudiani — di un freudismo particolare dato che il Freud reale aveva sostenuto la necessità della repressione per la civiltà. Ma allora la liberazione non potrebbe operarsi che sulla base dello scatenamento di forze primitive e in qualche maniera, per la loro estraneità alla civiltà, barbare; a una liberazione che sorgerebbe dall’interno per la dialettica delle classi si sostituisce in Marcuse una liberazione che viene dall’esterno. Solo queste forze primigenie avrebbero la capacità di abolire i modi della repressione produttiva.
Ma se su questa repressione produttiva si è fondata tutta la civiltà, la sua abolizione non porterebbe ad altro che a un ritorno della primitività del sottosviluppo. Il giudizio che ciò a cui si giunge per questa via, altro non può essere che una delle forme di catastrofe irrazionalistica dell’idea rivoluzionaria, non è certo peregrino: quel che importerebbe mostrare è che la catastrofe irrazionalistica sia inscritta in qualche modo come suo destino nell’idea di rivoluzione.
 Onde la contestazione cosiddetta “globale” diventa l’assurda rivolta contro ciò che è; diventa una forma di attivismo astorico, che non può distinguere nell’esistente il positivo e il negativo; e che si trova a questo bivio: o cercare una forma di evasione al reale, praticamente confondendosi con le forze beat e hippy; oppure allearsi con forme già esistenti nel sistema che combatte, magari presentandosi in posizione di avanguardia e di stimolo, e in realtà in funzione di strumento.
Onde la contestazione cosiddetta “globale” diventa l’assurda rivolta contro ciò che è; diventa una forma di attivismo astorico, che non può distinguere nell’esistente il positivo e il negativo; e che si trova a questo bivio: o cercare una forma di evasione al reale, praticamente confondendosi con le forze beat e hippy; oppure allearsi con forme già esistenti nel sistema che combatte, magari presentandosi in posizione di avanguardia e di stimolo, e in realtà in funzione di strumento.
L’esaurirsi dunque così del pensiero rivoluzionario marxista come dell’ideologia del progresso dai Turgot e dai Condorcet ai Saint-Simon e ai Comte, al positivismo allo scientismo nuovo, e insieme il ritrovamento obbligato nella critica della società presente di temi essenziali al sistema dei valori permanenti dovrebbe portare a una veduta della storia contemporanea, rispetto a cui le categorie abituali dei tradizionalisti e dei progressivi risultano del tutto inadeguate. Insisto un momento su questo rilievo: perché la prima conseguenza del rifiuto dei valori permanenti è stata quella della sostituzione della diade “vero-falso” con quella “progresso-reazione”.
 Il discorso potrebbe prendere varie vie: si porrebbe dimostrare che gli storici dell’età contemporanea tendano oggi a riconoscere che l’applicazione delle categorie consuete e consunte di “reazione”, “tradizione” e “conservazione” costituisce un ostacolo che rende sovente impossibile la comprensione.
Il discorso potrebbe prendere varie vie: si porrebbe dimostrare che gli storici dell’età contemporanea tendano oggi a riconoscere che l’applicazione delle categorie consuete e consunte di “reazione”, “tradizione” e “conservazione” costituisce un ostacolo che rende sovente impossibile la comprensione.
Ma soprattutto, mi è grato qui richiamarmi alle idee di Eric Voegelin, è da notare come la crisi delle idee di rivoluzione e di progresso coinvolga quella dell’idolo maggiore che si oppone alla riaffermazione dei valori permanenti, quella dell’idea di modernità assunta come valore.
Perché, notiamo: è in dipendenza di questa idea di modernità che si contesta appunto l’unità del pensiero greco e del pensiero cristiano, in varie forme, che tutte però concordano di fatto nel sostituire alla trascendenza e normatività dei valori assoluti, il movimento intramondano di trascendenza.
Il Voegelin ha mostrato con esemplare efficacia il carattere neognostico dell’idea di modernità, come dipendente dalla secolarizzazione di quella veduta gioachimita della storia che  si sostituì progressivamente all’opposta veduta agostiniana; e che negli ultimi secoli è diventata talmente incontrastata da permeare in forma diretta, come il modernismo, o rovesciata, come il pensiero reazionario, lo stesso pensiero religioso; ha messo in luce il carattere di scelta pratica che c’è alla base di ciò che è la sostanza dell’immanentizzazione dell’eschaton cristiano.
si sostituì progressivamente all’opposta veduta agostiniana; e che negli ultimi secoli è diventata talmente incontrastata da permeare in forma diretta, come il modernismo, o rovesciata, come il pensiero reazionario, lo stesso pensiero religioso; ha messo in luce il carattere di scelta pratica che c’è alla base di ciò che è la sostanza dell’immanentizzazione dell’eschaton cristiano.
Non è lecito quanto meno chiedersi se oggi, in un momento che sembra il compimento di un così lungo processo storico, questa scelta non manifesta il suo carattere non razionale? Ci si può domandare, insomma, se effettivamente il disvelamento della falsa coscienza non sia valido proprio per le forme di pensiero che intendono negare l’idea dei valori permanenti, in quanto metterebbe in luce il loro carattere ideologico, il loro essere orientali non già verso la verità, ma verso la potenza.
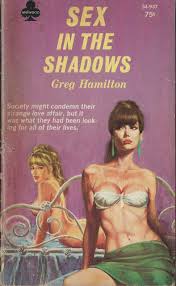 Il momento presente è quello in cui le affermazioni dipendenti dall’idea di modernità si sono realizzate nella pratica, ma dando luogo ad una serie di evidenti contraddizioni. Nonostante il diverso orientamento dei giudizi correnti, si deve riconoscere che quel che oggi è in crisi non è l’idea della permanenza dei valori, ma esattamente il principio opposto, quello che sta alla base della critica della permanenza; e lo è non già per resistenze antistoriche o moralistiche, ma proprio perché smentito da quel risultato storico a cui affidava la sua verifica.
Il momento presente è quello in cui le affermazioni dipendenti dall’idea di modernità si sono realizzate nella pratica, ma dando luogo ad una serie di evidenti contraddizioni. Nonostante il diverso orientamento dei giudizi correnti, si deve riconoscere che quel che oggi è in crisi non è l’idea della permanenza dei valori, ma esattamente il principio opposto, quello che sta alla base della critica della permanenza; e lo è non già per resistenze antistoriche o moralistiche, ma proprio perché smentito da quel risultato storico a cui affidava la sua verifica.
Note
(1) MARCUSE, L’uomo a una dimensione, Einaudi, Torino, 1967, p. 240.
(2) MARCUSE, Ragione e rivoluzione, 1941, p. 118.
(3) MARCUSE, op. ult. cit., p. 52.




