Storia Libera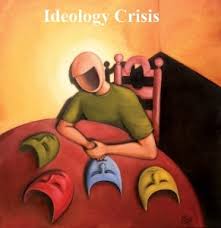 anno IV (2018) n. 7
anno IV (2018) n. 7
di Clemente Sparaco
Crisi delle ideologie e fine della modernità
Il 1989 ha segnato la fine dell’epoca dei grandi contrasti ideologici, della guerra fredda e del mondo diviso in blocchi contrapposti. In un senso più lato ha segnato la fine delle ideologie. Ma la fine delle ideologie era stata già teorizzata.
È sintomatico, infatti, che dalla fine degli anni Sessanta si cominciassero ad usare definizioni accomunate dal prefisso post: “società post-industriale”, “società post-capitalistica”, “ordine post-borghese” (1) . Nel ‘79 Lyotard in La condizione postmoderna (2) scrisse che il presente era contraddistinto dalla molteplicità dei discorsi in contrapposizione all’uniformità moderna. «Semplificando al massimo – affermava –, possiamo considerare “postmoderna” l’incredulità nei confronti delle metanarrazioni» (3).
Qualche anno dopo, Vattimo nella crisi dell’idea di progresso, riscontrabile tanto nelle arti, quanto nelle scienze e nella filosofia, individuò quella che definì come fine della modernità (4).
In tale contesto, l’espressione “fine delle ideologie” si riferisce al declinare delle visioni universali ed omologanti. Ancora più in profondità indica l’epoca del tramonto degli assoluti morali, politici e religiosi, e quindi di tutti quei discorsi aventi la presunzione di valere al di là dei contesti e delle differenze. Ne consegue che il termine ideologia è inteso come sinonimo di sapere forte, piantato nell’autoconsapevolezza dell’uomo circa le proprie capacità e possibilità. Indica il modello di sapere a fondamento tanto del sapere etico-politico, quanto del sapere scientifico, tanto della visione della storia lineare e progressiva, quanto della pretesa teorica della scienza di disegnare un quadro di certezze assolute ed incontrovertibili.
Quanto alla post-modernità, essa coinciderebbe col compimento del nichilismo (5), con il venir meno dei punti di riferimento.
 In effetti, nel crollo di un modello di sapere e di una visione della storia qualcosa di epocale effettivamente era accaduto. Era venuta meno non tanto, o soltanto, un’ideologia, ma la stessa matrice illuministica a fondamento di tutte le ideologie, quel modo di vedere la storia come segnata da un necessario ed indefettibile progresso, che era proprio del marxismo. Si era entrati in un’epoca ancora indefinita, ma che comunque era avvertita come situantesi al tramonto della modernità (6).
In effetti, nel crollo di un modello di sapere e di una visione della storia qualcosa di epocale effettivamente era accaduto. Era venuta meno non tanto, o soltanto, un’ideologia, ma la stessa matrice illuministica a fondamento di tutte le ideologie, quel modo di vedere la storia come segnata da un necessario ed indefettibile progresso, che era proprio del marxismo. Si era entrati in un’epoca ancora indefinita, ma che comunque era avvertita come situantesi al tramonto della modernità (6).
Scriveva Marcello Pera: «molti insistono nel dire che siamo entrati nel “post-moderno”, che siamo “dopo la filosofia”, “dopo la virtù”, “dopo l’obiettività”, “dopo le ideologie”, “dopo la perdita del mondo”. E così il nichilismo, il pensiero negativo, il decostruttivismo sarebbero le guide migliori per accompagnarci nel terzo millennio» (7).
Ma, prima ancora di indicare la crisi di una visione della storia o del mondo, il post-moderno denunciava la crisi di una visione dell’uomo. All’origine della modernità non c’era, infatti, solo un’idea di sapere o di storia, ma un’idea di uomo, che aveva cominciato a delinearsi con l’Umanesimo e si era affermata definitivamente con l’Illuminismo. Ora, nella misura in cui la modernità era dominata dall’idea di un soggetto forte, a sua volta portatore di una ragione forte, la post-modernità, sembrava andare incontro ad un soggettivismo relativistico negante ogni fondamento e valore. Si profilava, conseguentemente, un’incredulità verso tutti i progetti teorici, pratici o tecnici basantesi sulla pregiudiziale fiducia nell’uomo e nella sua ragione. L’uomo non pareva più capace di dare ordine al mondo né di dirigere la storia. Il suo procedere lungo il corso storico somigliava ormai ad un addentrarsi in un intrico di vie rapido e frenetico (8), ma senza meta (9) , qualcosa di simile alla “ragnatela” del web.
La condizione post-moderna era quella di chi si trova a convivere con le angustie e le idiosincrasie del presente, in un orizzonte di tramonto, senza entusiasmi e senza speranza: «per chi viva il presente come postmoderno la questione primaria sta dunque nel fatto che egli vive nel presente, ma allo stesso tempo, dal punto di vista spazio-temporale, viene dopo» (10).
Le radici remote della crisi
La crisi ha radici remote e radici più prossime.
 Le radici remote sono da ricercarsi nell’esperienza della guerra, del terrore nucleare, dei campi di sterminio, che hanno segnato nel senso di un’interruzione il corso storico, facendo avvertire una negatività insopprimibile ed insuperabile, al di là e fuori del progetto moderno di emancipare l’uomo e razionalizzare la storia.
Le radici remote sono da ricercarsi nell’esperienza della guerra, del terrore nucleare, dei campi di sterminio, che hanno segnato nel senso di un’interruzione il corso storico, facendo avvertire una negatività insopprimibile ed insuperabile, al di là e fuori del progetto moderno di emancipare l’uomo e razionalizzare la storia.
Scrivendo appena dopo la fine della seconda guerra mondiale, Romano Guardini esprimeva così queste inquietudini: «lo spirito dell’uomo è libero di fare il bene ed il male, di costruire e di distruggere. E gli elementi negativi non sono antitesi necessarie nel processo generale, ma sono negativi in senso proprio: sono ciò che si fa sebbene non sia necessario farlo sebbene si abbia la possibilità di far diversamente, di far ciò che è giusto. Ed è proprio quello che e avvenuto nelle cose essenziali e su vastissima scala. Le cose hanno seguito un cammino sbagliato ed i fatti lo dimostrano. Il nostro tempo lo avverte e ne è inquieto nella sua intima profondità» (11).
Gli elementi negativi della storia si sono dimostrati negativi in senso assoluto. C’è un male radicale dentro l’uomo che attende una redenzione che non può venire dall’uomo, male che i filosofi della scuola di Francoforte avevano individuato nell’olocausto. Esso era il punto di non ritorno, che marcava la fine dell’illuminismo e del suo modo ottimistico di guardare alla storia (12): «Auschwitz ha dimostrato inconfutabilmente il fallimento della cultura. Il fatto che potesse succedere in mezzo a tutta la tradizione della filosofia, dell’arte e delle scienze illuministiche, dice molto di più che essa, lo spirito, non sia riuscito a raggiungere e modificare gli uomini» (13).
 Nessuna conciliazione fra realtà e ragione: ad Auschwitz, nell’Europa della ragione e della civiltà, l’irrazionalità ha trionfato e le pretese plasmatrici della cultura si sono rivelate false. Ad Auschwitz sono morti la fiducia e l’autocompiacimento dell’uomo, la fede nel progresso e nella storia.
Nessuna conciliazione fra realtà e ragione: ad Auschwitz, nell’Europa della ragione e della civiltà, l’irrazionalità ha trionfato e le pretese plasmatrici della cultura si sono rivelate false. Ad Auschwitz sono morti la fiducia e l’autocompiacimento dell’uomo, la fede nel progresso e nella storia.
D’altra parte, Auschwitz non può essere interpretata come puro e semplice ritorno delle barbarie nel bel mezzo di un’Europa culturalmente raffinata. La barbarie che ritorna lo fa nelle forme e nei modi della scienza e della tecnica. Lo sterminio degli ebrei non è stato frutto, infatti, di una violenza cieca ed impulsiva, ma è stato pianificato, calcolato e messo in atto con consequenziale lucidità. Non un caso o un’anomalia, dunque, ma il frutto nefasto di una cultura. E ciò dimostra che la scienza non solo non ha migliorato l’uomo, ma gli ha fornito una nuova ed inaudita potenza distruttiva. I moderni strumenti di morte hanno prodotto, quindi, le camere a gas, le armi chimiche e le armi nucleari. Non è l’assenza di progresso, dunque, ma «lo sviluppo scientifico, artistico, economico e politico che ha reso possibili le guerre totali, i totalitarismi» (14)
La scienza non mette al riparo dal male. La crudeltà può, al contrario, essere esercitata in modo scientifico e la distruzione essere spinta fino all’autodistruzione. Pertanto, come scrisse Romano Guardini: «il problema centrale attorno a cui dovrà aggirarsi il lavoro della cultura futura e dalla cui soluzione dipenderà non solo il benessere o la miseria, ma la vita o la morte, è la potenza. Non il suo aumento, ché questo avviene da sé, ma la via di domarla e di farne un retto uso. Le forze selvagge nella loro forma primitiva sono vinte: la natura immediata è resa obbediente. Ma quelle forze riappaiono nel seno della cultura ed il loro elemento è appunto quello che ha vinto la primitività selvaggia: la potenza stessa» (15).
Le radici prossime della crisi
 Le radici prossime della crisi sono da ricercare negli avvenimenti che hanno contraddistinto gli anni della protesta giovanile, in particolare nel Sessantotto, negli ideali che l’animarono e nelle delusioni che alla fine ne seguirono.
Le radici prossime della crisi sono da ricercare negli avvenimenti che hanno contraddistinto gli anni della protesta giovanile, in particolare nel Sessantotto, negli ideali che l’animarono e nelle delusioni che alla fine ne seguirono.
L’ideologia nazifascista era già stata sepolta dalla miseria e dall’orrore dei campi di sterminio, ma i giovani di quegli anni credettero ancora all’ideologia. Il marxismo, in particolare, rappresentò per molti di essi un ideale di libertà e di uguaglianza capace di realizzare un mondo nuovo.
Esso, come le ideologie che lo avevano preceduto, custodiva un progetto antropologico. Prometteva di forgiare un uomo nuovo, libero in un senso diverso da come il liberalismo intendeva. Vedeva, infatti, la libertà come indissolubilmente legata al collettivismo, un’impresa comunitaria più che una conquista individuale.
Lo sfruttamento senza scrupoli sopravvive incontrastato e il senso di ingiustizia derivante dal sussistere di grandi sperequazioni sociali è forte. La sensazione dell’inutilità, della superfluità, angoscia le persone non meno della povertà materiale. Ora, rispetto a tutto questo, il marxismo prometteva di coniugare libertà e giustizia sociale (16).
La generazione del Sessantotto non aveva conosciuto la guerra e nemmeno l’indigenza. Piuttosto aveva sperimentato il boom economico «con l’allargamento delle possibilità sociali che aveva comportato». Ma «proprio perché aveva profondamente assorbito l’ideologia dell’abbondanza, questa generazione si ribellava contro l’autocompiacimento del progresso industriale e dell’opulenza, rivendicando un senso e un significato per la propria vita» (17).
 Questa insofferenza, mossa inizialmente da desiderio di giustizia, fu però presto sviata e la contestazione sfociò in un conformismo di nuovo genere. Ha scritto Emmanuel Lévinas: «nel bagliore di alcuni istanti privilegiati del 1968 ‒ subito spenti in un linguaggio non meno conformista e parolaio di quello che esso avrebbe sostituito ‒ la giovinezza è consistita nel contestare un mondo denunziato da tempo» (18).
Questa insofferenza, mossa inizialmente da desiderio di giustizia, fu però presto sviata e la contestazione sfociò in un conformismo di nuovo genere. Ha scritto Emmanuel Lévinas: «nel bagliore di alcuni istanti privilegiati del 1968 ‒ subito spenti in un linguaggio non meno conformista e parolaio di quello che esso avrebbe sostituito ‒ la giovinezza è consistita nel contestare un mondo denunziato da tempo» (18).
La denunzia del vecchio non servì a costruire il nuovo. Il movimento fu critico, ma non seppe poi indicare un nuovo ordine. L’immaginazione non bastò.
In particolare, di fronte al degradare delle istanze ideali in politica reale del terrore (il comunismo reale) e al fallimento dei progetti antropologici di un’umanità nuova, si evidenziò che le ideologie sono capaci di offrire risposte, ma a partire da posizioni intolleranti e violente. Pretendono, infatti, in nome di principi astratti, imposti come capestro alla realtà, di omologare tutto e tutti, azzerando diversità e differenze. Predicano il rinnovamento e la libertà, ma impongono l’uniformità. Non tollerano il dissenso e soffocano le libertà fondamentali. Così, il marxismo si rivelò un grande sistema di schiavitù, in cui la distruzione di ogni forma di libertà procede insieme alla distruzione dell’uomo come tale (19).
Nel 1989, col crollo del comunismo, l’esperienza della fine delle ideologie è divenuta, quindi, acquisizione condivisa e sembra indicare anche storiograficamente uno spartiacque fra due epoche. Ormai nella società e nella cultura «la grande narrazione» ideologica, portatrice della convinzione che «il mondo, tutto il mondo, potesse essere permeato (e vincolato) da un ideale processo di formazione unitario» (20). «Nella società e nella cultura contemporanee, la grande narrazione ha perso credibilità – scriveva Lyotard –, indipendentemente dalle modalità di unificazione che le vengono attribuite: sia che si tratti di racconto speculativo, sia di racconto emancipativo» (21).
In questa disillusione, inscritta nel periodo segnato da due anni, il Sessantotto e l’Ottantanove, si disegna quella che può definirsi come la parabola delle ideologie. Ha scritto a tal proposito Joseph Ratzinger: «il 1968 è legato all’emergere di una nuova generazione, che non solo giudicò inadeguata, piena di ingiustizia, piena di egoismo e di brama di possesso, l’opera di ricostruzione del dopoguerra, ma che guardò all’intero svolgimento della storia, a partire dall’epoca del trionfo del cristianesimo, come a un errore e a un insuccesso. Desiderosi di migliorare la storia, di creare un mondo di libertà, di uguaglianza e di giustizia, questi giovani si convinsero di aver trovato la strada migliore nella grande corrente del pensiero marxista. L’anno 1989 segnò il sorprendente crollo dei regimi socialisti in Europa, che lasciarono dietro di sé un triste strascico di terre distrutte e di anime distrutte» (22).
Post-moderno e fine della storia
Al fondo della crisi dell’ideologia si individua una più generale crisi di fiducia nell’uomo e nella storia. È venuta meno la matrice narrativa e progressiva delle ideologie, che dava ad esse la certezza di sé e delle proprie possibilità. Questa matrice fa da sfondo a tutto il sapere moderno, costituendo l’autoconsapevolezza presente nella Rinascenza, come nell’Illuminismo, nell’Idealismo come nel Positivismo. In funzione di essa la modernità si è connotata come trionfo della razionalità sul pregiudizio, come trionfo del nuovo ordine sul vecchio.
 Quell’idea oggi – come ha scritto Alain Touraine – «ha perso la propria forza di liberazione e di creazione» (23). Siamo ormai alla fine delle illusioni illuministiche, delle presunzioni e delle supponenze, dell’autocompiacimento dell’uomo e dei suoi propositi di indirizzare il corso storico.
Quell’idea oggi – come ha scritto Alain Touraine – «ha perso la propria forza di liberazione e di creazione» (23). Siamo ormai alla fine delle illusioni illuministiche, delle presunzioni e delle supponenze, dell’autocompiacimento dell’uomo e dei suoi propositi di indirizzare il corso storico.
Tramontati i grandi racconti che avevano per protagonisti i partiti, le masse, lo Spirito, è tramontata non solo l’attesa messianica di una trasformazione rivoluzionaria, ma anche la fiducia nel nuovo (24). È tramontata la storia stessa, intendendo col termine storia qualcosa di collegato ad un progresso necessario ed inderogabile. In relazione a questo, il post-moderno si caratterizza «come esperienza di “fine della storia”» (25).
Di conseguenza, l’uomo postmoderno sente di venire «dopo la totalità della storia, con le sue origini sacre e mitologiche, la sua stretta causalità, la teleologia segreta, il narratore onnisciente e trascendente e la promessa di un lieto fine, in chiave cosmica o storica» (26). Non presume più di sapere quale sia la direzione della storia né di sapere se essa abbia una direzione unitaria, lineare, razionale. Non crede più nel nuovo né lo desidera, perché lo ha sostituito con un desiderio di novità inessenziale e superficiale (27).
Sono del pari venute meno le antropologie totali di cui erano portatrici le ideologie. Perché le ideologie, prima ancora di proporre una visione della storia, proponevano una visione dell’uomo. E questa era una visione totale ed uniformante. Prendeva, come è avvenuto nell’educazione fascista, nazista, comunista, l’uomo dalla culla e lo inquadrava all’interno delle sue organizzazioni, per forgiarlo, per ammaestrarlo, per uniformarlo. Antropologie esclusiviste le si potrebbero anche definire, perché nell’indicazione di un modello di uomo c’era anche l’esclusione del diverso, del differente, per razza, religione, classe.

Aleksandr Isaevič Solženicyn
Erano forme di umanesimo del soggetto, intendendo per soggetto qualcosa di marcatamente identitario, ma non dell’altro uomo, dell’escluso, del diverso, di colui che non si confaceva al modello. Potremmo pensare al personaggio dello scroccone di Divisione cancro di Solženicyn (28), che non si uniforma al pensiero unico. In questo la modernità con i suoi miti della ragione, dell’autodeterminazione, della scienza, della storia, etc., rivelava il suo lato oscuro, distruttivo, violento. In questo l’umanesimo progressista sfociava nel totalitarismo violento, che conculcava gli stessi valori fondamentali che aveva propalato.
Forme di antropologie totali le ideologie sono anche perché hanno escluso di principio la trascendenza dall’ordine dell’umano. Hanno inteso che l’uomo vivesse di solo pane, ossia nella sola dimensione del sociale, del politico, etc., e hanno escluso dalla storia la dimensione religiosa, giudicandola secondaria, se non irrilevante. Ciò si è tradotto in una stretta ancor più soffocante, che ha schiacciato gli uomini su un orizzonte di immanenza senza residui, senza speranze ultraterrene e senza rimandi. Hanno prodotto, quindi, una «devastazione delle coscienze» (29), un’oppressione che è andata ad intaccare qualcosa di profondo, una violenza ancora più disumanizzante della stessa violenza fisica.
Il nuovo disordine mondiale e la globalizzazione
Il crollo del comunismo si è realizzato in modo sorprendente e repentino. Alla fine degli anni Ottanta le economie socialiste si sono dimostrate incapaci di creare sviluppo e di reggere il passo delle economie capitaliste. Nel contempo i sistemi di potere del socialismo reale sono apparsi irrimediabilmente oppressivi e totalitari. Perciò, il marxismoleninismo non è sembrato più capace di offrire una valida alternativa al modello di sviluppo delle società democratiche.
Caduto nel 1989 il muro di Berlino, è crollato tutto un ordine internazionale ed un’epoca è finita. Questo ha fatto sorgere la convinzione che anche i grandi conflitti internazionali sarebbero finiti e che si sarebbe instaurato un mondo più armonioso e pacifico. Col tramonto dei blocchi e con la fine della divisione in due del mondo, in Occidente si è creduto che la democrazia liberale avesse definitivamente trionfato e che di lì a poco si sarebbe diffusa dappertutto. È in questo clima che Francis Fukuyama ha formulato l’ipotesi suggestiva di fine della storia. Scrisse allora: «è possibile che siamo giunti […] alla fine della storia in quanto tale; vale a dire al capolinea dell’evoluzione ideologica dell’umanità e all’universalizzazione della democrazia liberale occidentale quale forma ultima di governo dell’umanità» (30).
 Alcuni fatti sembravano suffragare tale tesi. La scienza e la tecnica avevano reso ormai omogenee molte società, quanto a stili di vita, e parallelamente le democrazie liberali si erano estese in tutto il mondo. Il capitalismo appariva ormai come l’assetto economico prevalente e la democrazia il regime politico meglio compatibile con esso. La loro diffusione su scala globale sembrava l’unico scenario possibile per il futuro.
Alcuni fatti sembravano suffragare tale tesi. La scienza e la tecnica avevano reso ormai omogenee molte società, quanto a stili di vita, e parallelamente le democrazie liberali si erano estese in tutto il mondo. Il capitalismo appariva ormai come l’assetto economico prevalente e la democrazia il regime politico meglio compatibile con esso. La loro diffusione su scala globale sembrava l’unico scenario possibile per il futuro.
Dietro questa tesi, senz’altro semplicistica, si nascondeva quello che Samuel Huntinghton ha definito il «sofisma dell’unica alternativa», e cioè la convinzione, generatasi storicamente nell’epoca della guerra fredda, che «l’unica alternativa al comunismo sia la democrazia liberale e che la scomparsa del primo comporti automaticamente la diffusione su scala universale della seconda» (31).
L’ipotesi Fukuyama è stata drammaticamente smentita nei fatti già negli anni Novanta. Una spirale tragica di guerre e di odio, di rivalse e di contrasti insanabili, ha impresso agli avvenimenti un’accelerazione imprevista. Al posto di un mondo rimasto stabile per mezzo secolo è subentrato un mondo privo di una struttura ben definibile, non ancora inquadrabile in una logica coerente, ma proprio per questo più sinistro.
Oggi il mondo non è più diviso in blocchi contrapposti, ma non per questo appare più unito ed armonico. Oggi l’eventualità di una conflagrazione mondiale fra potenze nucleari non si pone più nei termini dell’epoca della guerra fredda, ma non per questo sono scomparse le contrapposizioni e i pericoli nucleari. Questi, anzi si ripresentano in forme ancora più insidiose. L’imprevedibilità di ciò che può accadere, nell’epoca che viene dopo l’11 settembre, configura, quindi, un «nuovo disordine mondiale» (32).
Fattori di civiltà e rinascita religiosa
Proprio il fattore civiltà sembra diventato l’elemento chiave del quadro geopolitico. Nel mondo post guerra fredda le principali contrapposizioni non paiono, infatti, di carattere ideologico, ma di civiltà: «la fine della guerra fredda non ha posto fine alla conflittualità, ma ha piuttosto fatto emergere nuove identità radicate nella cultura e nuovi canoni di conflittualità tra gruppi di culture diverse e, a livello più generale, di civiltà diverse» (33).
 Le civiltà e le identità culturali si sono dimostrate qualcosa di più radicato e sedimentato delle differenze economiche o ideologiche. Ed è a questo punto che si inserisce la tesi di Huntington in Lo scontro delle civiltà (34): «la tesi di fondo di questo saggio è che la cultura e le identità culturali siano alla base dei processi di coesione, integrazione e conflittualità che caratterizzano il mondo post guerra fredda…» (35). Sono questi fattori, più che quelli economici, a muovere gli odierni processi di integrazione e conflittualità mondiale. In tempi di sconvolgenti mutamenti sociali, economici, di abitudini di vita, le questioni di identità assumono, sostiene Huntington, priorità rispetto a quelle di interesse. Gli uomini sentono il bisogno di rispondere alle basilari domande di appartenenza. Lo fanno nel modo tradizionale, facendo riferimento cioè alle cose che per loro hanno maggior significato: progenie, religione, lingua, storia, valori, costumi. Lo fanno identificandosi con gruppi culturali, etnici, tribù, comunità religiose, etc..
Le civiltà e le identità culturali si sono dimostrate qualcosa di più radicato e sedimentato delle differenze economiche o ideologiche. Ed è a questo punto che si inserisce la tesi di Huntington in Lo scontro delle civiltà (34): «la tesi di fondo di questo saggio è che la cultura e le identità culturali siano alla base dei processi di coesione, integrazione e conflittualità che caratterizzano il mondo post guerra fredda…» (35). Sono questi fattori, più che quelli economici, a muovere gli odierni processi di integrazione e conflittualità mondiale. In tempi di sconvolgenti mutamenti sociali, economici, di abitudini di vita, le questioni di identità assumono, sostiene Huntington, priorità rispetto a quelle di interesse. Gli uomini sentono il bisogno di rispondere alle basilari domande di appartenenza. Lo fanno nel modo tradizionale, facendo riferimento cioè alle cose che per loro hanno maggior significato: progenie, religione, lingua, storia, valori, costumi. Lo fanno identificandosi con gruppi culturali, etnici, tribù, comunità religiose, etc..
La religione, in particolare, si rivela la più possente arma di resistenza all’omologazione culturale. Essa, infatti, offre risposte soddisfacenti ai problemi di identità assediate. Spesso veste i panni di una protesta contro il laicismo relativista e della sua pervasiva influenza culturale. La religione, sia quella tradizionale che quella fondamentalista, ritorna con i suoi simboli e con i suoi riti.
Croci, mezzelune tornano a contare. Si dimostrano capaci di motivare e mobilitare masse. Suscitano sentimenti profondi e reazioni radicali. La religione «penetra probabilmente in misura sempre maggiore negli affari internazionali» (36). Va a riempire lo spazio lasciato libero dalla crisi delle ideologie, dimostrandosi tutt’altro che una forza in declino. Lo scontro fra identità religiose diverse alimenta la lotta politica in luogo di quello che, nell’epoca della divisione del mondo in blocchi, era lo scontro ideologico.
A tal proposito, si è parlato di ritorno del sacro, di desecolarizzazione del mondo o, con suggestione maggiore, di rivincita di Dio (37). Sta di fatto che «il fallimento della profezia della privatizzazione del religioso è sotto gli occhi di tutti» (38).
La rinascita religiosa appare particolarmente forte nel mondo musulmano, dove il richiamo alla religione corre di pari passo con il rifiuto di valori, istituzioni e modelli di sviluppo occidentali. Al fondo s’individua il problema di armonizzare Islam e modernità. Il mondo islamico, rinnovando l’adesione all’islam quale unica guida culturale, religiosa, sociale e politica, sembra, quindi, riaffermare orgogliosamente la propria identità (39).
La rivincita di Dio

Samuel P. Huntington
La tesi di Huntington è in controtendenza rispetto ad un modo ideologico di leggere i fatti, pregiudizialmente teso a misconoscere il peso dei fattori di civiltà nei processi storici. Rompe con una sorta di sclerosi culturale laicista, che è il prodotto della ragione illuminista, per la quale il progresso della storia coincideva con l’emancipazione dai miti del passato, e fra questi miti c’era innanzitutto quello religioso. Sancisce il venir meno di una visione dell’uomo, quella dell’uomo adulto, che è tale perché si è emancipato dalle autorità, e tra queste la più importante è la religiosa.
La visione illuministica della storia aveva, infatti, il suo cardine nella secolarizzazione, nell’estromissione cioè della religione dalle vicende degli uomini e nel suo relegamento alle coscienze dei singoli.
Per capirne la portata, bisogna considerare che ancora negli anni Sessanta e Settanta le élite intellettuali occidentali erano convinte che la modernizzazione avrebbe comportato inevitabilmente la marginalizzazione ed estinzione della religione. Per i laicisti sembrava, di conseguenza, indubbio che la scienza, il razionalismo e il pragmatismo avrebbero spazzato via le superstizioni e i rituali alla base delle religioni. «La società del futuro sarebbe stata tollerante, razionale, pragmatica, progressista, umanistica e laica» (40).
Ciò che è avvenuto dagli anni Settanta in poi ha dimostrato l’infondatezza di quelle analisi. Un fenomeno inverso ed imprevisto si sta profilando: la modernizzazione sta stimolando un ritorno alle radici religiose. Il mondo si sta modernizzando economicamente, socialmente e quanto a diffusione della tecnologia, ma sta anche riscoprendo radici religiose e identità culturali. Ma la modernizzazione, mettendo in discussione antiche regole e certezze ha ingenerato una reazione di segno opposto: l’arroccamento sulle proprie radici identitarie.
Ora, in questo contesto, il ritorno della religione significa un richiamo alla fonte stessa di identificazione di una civiltà. Essa risponde al bisogno di appartenenza, offrendo punti saldi e valori di riferimento. Dimostra, nel contempo, quanto l’identità culturale sia importante sia a livello di folle che di individui. Dimostra quanto era falsa la pretesa illuministica di aver capito la direzione della storia. Dimostra la fragilità di un progresso imperniato sulla secolarizzazione e il fallimento dell’idea che all’uomo basti un benessere meramente materiale per estirparne dal cuore il desiderio di trascendenza.
____________________
(*) Clemente Sparaco (1963), dopo la laurea in Filosofia presso l’Università degli Studi di Napoli, ha iniziato ad insegnare nei Licei, diventando docente di ruolo nel 1987. Dal 1994 ha collaborato come cultore presso la Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Salerno, cattedra di Filosofia Teoretica, e dal 2000 al 2001 con contratto di collaborazione didattica. Nel 2012 ha conseguito il dottorato in Etica. Ha fatto parte della redazione della rivista «Scienza e Sapienza» e scrive per diverse riviste e quotidiani on line. Dopo gli studi giovanili su Agostino, cui ha dedicato due volumi, ha approfondito lo studio del pensiero postmoderno (La fine della postmodernità, Edisud, Salerno 2003) e della filosofia dialogica (Oltre la solitudine dell’Io, Aracne, Roma 2013).
1) L’epoca tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta «è l’età del “post”. Daniel Bell configura la società postindustriale (1973), Ralf Dahrendorf la società post-capitalistica, George Lichtheim un ordine post-borghese, un seguace di Marshall McLuhan annuncia la nascita della “post-Literature Culture” e Sidney Ahlstrom “cerca di cogliere il cambiamento della scena religiosa come una trilogia di ‘post’: post-puritana, post-protestante, post-cristiana” ‒ una vera sparatoria!» (Livio SICHIROLLO, La fine di tutte le cose, in «Belfagor», anno 49 (1994), fasc. III, pag. 325). «Nel momento in cui ci definiamo postmoderni, il nostro primo dilemma, politico e culturale, riguarda l’indeterminatezza dello stesso termine “post”. Il pensiero contemporaneo abbonda di categorie la cui differentia specifica è fornita da questo prefisso. Abbiamo, ad esempio, un “post-strutturalismo”, società “post-industriali” e “postrivoluzionarie”, perfino una “post-histoire”» (Agnes HELLER – Ferenc FEHÉR, La condizione politica postmoderna, Marietti, Genova 1992, p. 7).
2) Jean François LYOTARD, La condizione post-moderna. Rapporto sul sapere, Feltrinelli, Milano 1981. Sulla questione si vedano: Tomás MALDONADO, Il futuro della modernità, Feltrinelli, Milano 1987, p. 15-20 e Michela NACCI, Postmoderno, in Paolo ROSSI (diretta da), La filosofia, vol. IV, Stili e modelli teorici del Novecento, UTET, Torino 1995, p. 361-363.
3) LYOTARD, La condizione post-moderna. Rapporto sul sapere, cit., p. 6. 4 ) Gianni VATTIMO, La fine della modernità. Nichilismo ed ermeneutica nella cultura postmoderna, Garzanti, Milano 1985.
5) Con l’annuncio della morte di Dio, Nietzsche afferma non solo la fine della credenza in Dio, ma anche il declinare di tutti gli assoluti. Ne consegue il vertiginoso senso di un’assenza totale di riferimenti in quello che configura come eterno precipitare: «Che mai facemmo, a sciogliere questa terra dalla catena del suo sole? Dov’è che si muove ora? Dov’è che ci muoviamo noi ora? Via da tutti i soli? Non è il nostro un eterno precipitare? E all’indietro, di fianco, in avanti, da tutti i lati? Non stiamo forse vagando come attraverso un infinito nulla?» (Friedrich NIETZSCHE, La gaia scienza, in Opere, a cura di Giorgio Colli e Mazzino Montinari, vol. V, tomo II, Adelphi, Milano 1991, p. 150-151 [aforisma 125]).
6) «Il destino della nostra generazione è di trovarsi fra i tempi. Noi non siamo mai appartenuti al tempo che oggi volge alla fine. Forse apparterremo una volta al tempo che verrà? e anche ammesso che da parte nostra si sia in grado di appartenergli, esso verrà tanto presto? Così ci troviamo nel mezzo. In uno spazio vuoto […]. Noi ci troviamo fra i tempi» (Friedrich GOGARTEN, Fra i tempi, in Le origini della teologia dialettica, a cura di Jürgen Moltmann, Morcelliana, Brescia 1976, p. 502.508).
7) Marcello PERA, Il mondo incerto, Laterza, Roma – Bari 1994, p. XI.
8) «L’accelerazione dei processi storici, che caratterizza il nostro secolo, acutizza questo senso del divenire e sembra mettere in discussione ogni appiglio sicuro. La seduzione del nuovo, connessa al ritmo frenetico della vita, sembra rendere inconcepibile ogni idea di verità eterne ed immutabili» (Bruno FORTE, Gesù di Nazaret. Storia di Dio, Dio della storia, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo (Milano) 1985, p. 46). 9) Cfr. Gaetano CHIURAZZI, Il postmoderno, Bruno Mondadori, Milano 2002, p. 10.
10) HELLER – FEHÉR, La condizione politica postmoderna, cit., p. 7.
11) Romano GUARDINI, La fine dell’epoca moderna, Morcelliana, Brescia 1999, p. 77-78
12) Con Illuminismo Adorno e Horkheimer intendono un «pensiero in continuo progresso» (Theodor W. ADORNO – Max HORKHEIMER, Dialettica dell’Illuminismo, Einaudi, Torino 1966, p.
11). Perciò, essi estendono la portata del termine oltre i limiti storici dell’Illuminismo, intendendo con esso la critica rivolta dalla ragione alla fede e alla superstizione, che ha lo scopo di rendere gli uomini padroni di sé e della natura, togliendo loro la paura dell’ignoto e dell’irrazionale.
13) Theodor W. ADORNO, Dialettica negativa, Einaudi, Torino 1982, p. 330-331.
14) Jean François LYOTARD, Il Postmoderno spiegato ai bambini, Feltrinelli, Milano 1987, p. 95-96.
15) GUARDINI, La fine dell’epoca moderna, Morcelliana, Brescia 1954, p. 89. Sul problema della potenza dell’uso politico della scienza così si è espresso Lyotard: «…per il discorso dei finanziatori contemporanei, esiste un solo gioco credibile, quello della potenza. Non si assumono scienziati e tecnici, né si acquistano apparecchiature per sapere la verità, ma per accrescere la potenza» (La condizione post-moderna. Rapporto sul sapere, cit., p. 84).
16) Cfr. Joseph RATZINGER, La via della fede, Ares, Milano 2005, p. 15.
17) Heller – FEHÉR, La condizione politica postmoderna, cit., p. 152. 18) Emmanuel LÉVINAS, Umanesimo dell’altro uomo, Il Melangolo, Genova 1998, p. 156.
18) Emmanuel LÉVINAS, Umanesimo dell’altro uomo, Il Melangolo, Genova 1998, p. 156.
19) «Nondimeno, che il sistema marxista non funzionasse come era stato promesso, è evidente. Che questo presunto movimento di liberazione fosse, accanto al nazionalsocialismo, il più grande sistema di schiavitù della storia contemporanea, nessuno può in realtà negarlo: le dimensioni della cinica distruzione dell’uomo e del mondo vengono invero spesso vergognosamente taciute, ma nessuno può più contestarle» (RATZINGER, La via della fede, cit., p. 15).
20) MALDONADO, Il futuro della modernità, cit., p. 57.
21) LYOTARD, La condizione postmoderna, cit., p. 69. Riflessioni analoghe possiamo rinvenire in Heller e Fehér: «la “crisi del marxismo”, dibattuta a lungo e in modo sempre più sterile, le controversie successive, e peraltro assai più stimolanti, circa la pluralità dei “microdiscorsi”, la percezione di un revival religioso per frammenti, la comprensione dell’esigenza di una concezione incompleta della giustizia etico-politica tutti questi nuovi sviluppi ci indicavano la «fine della grande narrazione» (HELLER – FEHÉR, La condizione politica postmoderna, cit., p. 17).
22) Joseph RATZINGER, Introduzione al Cristianesimo, Queriniana, Brescia 1974, p. 7.
23) «Dalla sua forma più dura alla sua forma più debole, più modesta, l’idea di modernità, quando è definita mediante la distruzione degli antichi ordini e mediante il trionfo della razionalità oggettiva o strumentale, ha perso la propria forza di liberazione e di creazione. Essa stenta a resistere alle forze avverse almeno quanto il generoso richiamo ai diritti dell’uomo fatica a resistere all’ascesa del differenzialismo e del razzismo» (Alain TOURAINE, Critica della modernità, Il Mulino, Bologna 1993, pag. 14).
24) «Dall’architettura al romanzo alla poesia alle arti figurative, il post-moderno mostra come suo tratto comune e più imponente lo sforzo di sottrarsi alla logica del superamento, dello sviluppo e dell’innovazione» (VATTIMO, La fine della modernità, cit., p. 114).
25) «Il postmoderno si caratterizza non solo come novità rispetto al moderno, ma anche come dissoluzione della categoria del nuovo, come esperienza di “fine della storia”, piuttosto che come presentarsi di uno stadio diverso, più progredito o più regredito, non importa, della storia stessa» (Ibidem, p. 12). Secondo Vattimo, bisogna prendere atto che non esiste più un unico tempo storico, lineare e progressivo e che l’idea che il tempo sia una freccia che dal passato va verso il futuro passando attraverso il presente va abbandonata. Se «non c’è una storia unitaria, portante, e ci sono solo le diverse storie, i diversi livelli e modi di ricostruzione del passato nella coscienza e nell’immaginario collettivo, è difficile vedere fino a che punto la dissoluzione della storia come disseminazione delle “storie” non sia anche una vera e propria fine della storia come tale» (Ibidem, p. 17). Il post-moderno, quindi, non sarebbe uno stadio diverso, più progredito della storia, ma l’esperienza della dissoluzione della storia, o almeno di ciò che la modernità aveva inteso per storia. Da questo punto di vista il post di post-moderno è presa di congedo dalla modernità innanzitutto perché è un sottrarsi alle sue logiche di sviluppo (cfr. ibidem, p. 11).
26) HELLER – FEHÉR, La condizione politica postmoderna, cit., p. 8.
27) Cfr. VATTIMO, La fine della modernità, cit., p. 110. Osserva Marramao che il «venir meno delle grandi ideologie trasformazioniste (e del concetto enfatico di Storia a esse correlato) non dà luogo, per i postmoderni, a una istituzionalizzazione adattiva e fredda del processo innovativo, ma piuttosto a una nuova apertura del pensiero e delle pratiche alla dimensione del possibile e del contingente: a una disponibilità a contemplare la fluttuazione, la discontinuità e il coup innovativo dentro una sorta di antimodello del sistema stabile» (Giacomo MARRAMAO, Cielo e terra. Genealogia della secolarizzazione, Laterza, Roma – Bari 1994, p. 156-157).
28) Aleksandr Isaevi SOLŽENICYN, Padiglione cancro, Newton Compton Editori, Roma 2005.
29) Karol WOJTYLA, Memoria e identità, Rizzoli, Milano 2004, p. 147.
30) Francis FUKUYAMA, The End of History, in «The National Interest», n. 16, Summer 1989, p. 4.
31) Samuel HUNTINGHTON, Lo scontro delle civiltà, Garzanti, Milano 1997, p. 16.
32) Di vedano in particolare le considerazioni fatte a tal proposito da Zygmunt BAUMAN, Il disagio della postmodernità, Bruno Mondadori, Milano 2002, p. 27-28.
33) HUNTINGHTON, Lo scontro delle civiltà, cit., p. 184. 34) Il libro di S. Huntington Lo scontro delle civiltà è stato accusato di fomentare lo scontro fra le civiltà. Si è detto che esso è vittima di un’ossessione di fondo: l’urgenza di mobilitare il “mondo occidentale” contro le nazioni di un fantomatico asse confucianoislamico (la Cina, l’Iran, l’India, la Turchia, ec.) per stabilire il controllo sull’immensa regione euro-asiatica in cui sono stanziati tre quarti della popolazione mondiale.
34) Il libro di S. Huntington Lo scontro delle civiltà è stato accusato di fomentare lo scontro fra le civiltà. Si è detto che esso è vittima di un’ossessione di fondo: l’urgenza di mobilitare il “mondo occidentale” contro le nazioni di un fantomatico asse confucianoislamico (la Cina, l’Iran, l’India, la Turchia, ec.) per stabilire il controllo sull’immensa regione euro-asiatica in cui sono stanziati tre quarti della popolazione mondiale.
35) HUNTINGHTON, Lo scontro delle civiltà, cit., p. 14.
36) Edward MORTIMER, Christianity and Islam, in «International Affaire», n. 67, January 1991, p. 7.
37) Con revanche de Dieu si è indicato l’inversione di tendenza verificatasi a metà degli anni Settanta rispetto al laicismo. In particolare, Kepel sostiene che allora sia venuto alla luce un nuovo approccio religioso, non più volto ad un adeguamento ai valori laici, ma al recupero della sacralità come fondamento dell’organizzazione della società (cfr. Gilles KEPEL, La rivincita di Dio, Rizzoli, Milano 1991).
38) «Per una parte della cultura europea d’oggi, lo spazio pubblico deve essere impermeabile al fatto cristiano. E questo deve essere reciso dall’insieme della civiltà europea in cui ha le sue radici e a cui dà linfa. Invece, è proprio il contrario che accade oggi nel mondo, Europa compresa: ovunque c’è un impetuoso ritorno del religioso nello spazio pubblico. Dove per religioso si intendono le corpose Chiese storiche: la cattolica, rinvigorita dalla politicità carismatica di papa Karol Wojtyla e dalla guida teologica di Benedetto XVI; le protestanti d’impronta americana evangelica; le ortodosse, con il loro modello bizantino di congiunzione fra trono e altare. Più l’ebraismo intrecciato al destino concretissimo di Israele, un popolo, una terra, uno Stato. Più l’islam, in cui fede, politica e legge sacra tendono a fare tutt’uno e, dovunque oggi si voti, il consenso va a partiti fortemente ispirati dalla legge coranica, ultimo caso eclatante quello della Palestina. Il fallimento della profezia della privatizzazione del religioso è sotto gli occhi di tutti. […] L’esistenza di ordinamenti politici con qualificazione religiosa non appartiene solo al passato, ma è il presente e il futuro delle società mondiali» (Sandro MAGISTER, I cristiani, l’islam e il futuro dell’Europa, in www.chiesa.espressonline.it , 20.2.2006).
39) Lo slogan degli islamisti è semplice e diretto: “la soluzione è l’islam”. Ciò vuole significare di fronte alla complessità e molteplicità del mondo moderno un richiamo alla religione quale fonte unica di orientamento, stabilità e legittimità. Il risveglio del mondo islamico è pensato, conseguentemente, prima di tutto come risveglio religioso, purificazione dell’islam da pericolose contaminazioni provenienti dall’esterno. Questo risveglio, come ha scritto Al-Turabi, «non riguarda solo la fede individuale, non è solo intellettuale e culturale, o solo politico. È tutte queste cose insieme: una ricostruzione generale, da cima a fondo, della società» (Hassan AL-TURABI, The Islamic Awakening’s Second Wave, in «New Perspectives Quarterly», n. 9, Summer 1992, p. 52). Presenta poi uno politico verso la ricostituzione di una comunità islamica universale (Louis GARDET, La cité musulmane, Vrin, Paris 1981, p. 27-29).
40) HUNTINGTON, Lo scontro delle civiltà, cit., p. 131.




