Abstract: due saggi di Roberto Pertici di taglio diverso da raccomandare a chiunque si occupi di storia della cultura novecentesca e in cui c’è in entrambi, pur nella poca simpatia nei confronti dell’età corrente, una disponibilità a capirla, a vederne le ragioni anche contro i propri convincimenti che sembra provenire dallo spirito equanime non solo dell’autentico storico ma dell’autentico scrittore
Snaporaz.online 28 Dicembre 2022
Dopo la Storia: su due libri di Roberto Pertici
di Claudio Giunta
Qualche tempo fa mi è capitato di occuparmi di un filosofo celebre negli anni dell’entre-deux-guerres ma oggi ricordato da pochi, Adriano Tilgher, e colleghi storici mi hanno suggerito di rivolgermi, per consigli (io mi occupo di letteratura), a Roberto Pertici, che «su queste figure minori sa tutto».
 Tilgher, in realtà, non è per niente una figura minore, e mi pare che il suo Diario politico, che poi ho ripubblicato per le Edizioni della Normale, meriterebbe qualche lettore in più rispetto ai pochissimi che ha avuto; ma in effetti Pertici – che mi ha aiutato con grande generosità mentre procedevo a tentoni nella storia delle idee del primo Novecento – sa tutto, e non soltanto intorno ai minori, e non c’è una sua pagina, tra quelle che un po’ affrettatamente ho letto in questi ultimi anni, che non mi abbia insegnato cose che non sapevo e, ancora più rilevante, fatto riflettere su questioni che non mi ero posto, o non con la chiarezza con cui ha saputo porle, riformularle: e in questo sta poi il talento dello storico, non importa se della letteratura o delle idee o degli eventi, nella ridescrizione di problemi più e più volte troppo unilateralmente descritti.
Tilgher, in realtà, non è per niente una figura minore, e mi pare che il suo Diario politico, che poi ho ripubblicato per le Edizioni della Normale, meriterebbe qualche lettore in più rispetto ai pochissimi che ha avuto; ma in effetti Pertici – che mi ha aiutato con grande generosità mentre procedevo a tentoni nella storia delle idee del primo Novecento – sa tutto, e non soltanto intorno ai minori, e non c’è una sua pagina, tra quelle che un po’ affrettatamente ho letto in questi ultimi anni, che non mi abbia insegnato cose che non sapevo e, ancora più rilevante, fatto riflettere su questioni che non mi ero posto, o non con la chiarezza con cui ha saputo porle, riformularle: e in questo sta poi il talento dello storico, non importa se della letteratura o delle idee o degli eventi, nella ridescrizione di problemi più e più volte troppo unilateralmente descritti.
Il fatto è che la storia culturale si trova un po’ sacrificata nella gabbia dei raggruppamenti disciplinari, e chi vorrebbe occuparsene, all’università, viene scoraggiato dalla routine della pubblicazione: è un ibrido tra la storia e la filosofia, e l’ibridazione (alias interdisciplinarità: ma la parola è così usurata che non la si può più usare seriamente), oltre a poter essere letale per la carriera, richiede il doppio dello studio.
 Quest’anno Pertici ha pubblicato a distanza di pochi mesi due raccolte di saggi di taglio diverso che vorrei raccomandare a chiunque si occupi di storia della cultura novecentesca: Dall’Ottocento alla “Dopostoria” (Studium Edizioni) che raccoglie articoli usciti per lo più sull’«Osservatore Romano», articoli, come si dice, di alta divulgazione dei quali sarebbe difficile indicare l’analogo, per qualità e per ampiezza, in altri giornali italiani; e È inutile avere ragione. La cultura “antitotalitaria” nell’Italia della prima Repubblica (Viella), che raccoglie invece contributi scientifici più ampi e meditati, pubblicati su riviste accademiche o in atti di convegno nel corso degli ultimi vent’anni. Il taglio è diverso, non l’ispirazione: si tratta di ripensare, di ridescrivere appunto, alcuni aspetti della storia culturale italiana del ventesimo secolo, e alcune figure esemplari che la storiografia non ha valorizzato a dovere (molti semisconosciuti, per il lettore non specialista: Piero Bargellini, Giuseppe Ricciotti, Gabrio Lombardi) o non ha messo adeguatamente a fuoco.
Quest’anno Pertici ha pubblicato a distanza di pochi mesi due raccolte di saggi di taglio diverso che vorrei raccomandare a chiunque si occupi di storia della cultura novecentesca: Dall’Ottocento alla “Dopostoria” (Studium Edizioni) che raccoglie articoli usciti per lo più sull’«Osservatore Romano», articoli, come si dice, di alta divulgazione dei quali sarebbe difficile indicare l’analogo, per qualità e per ampiezza, in altri giornali italiani; e È inutile avere ragione. La cultura “antitotalitaria” nell’Italia della prima Repubblica (Viella), che raccoglie invece contributi scientifici più ampi e meditati, pubblicati su riviste accademiche o in atti di convegno nel corso degli ultimi vent’anni. Il taglio è diverso, non l’ispirazione: si tratta di ripensare, di ridescrivere appunto, alcuni aspetti della storia culturale italiana del ventesimo secolo, e alcune figure esemplari che la storiografia non ha valorizzato a dovere (molti semisconosciuti, per il lettore non specialista: Piero Bargellini, Giuseppe Ricciotti, Gabrio Lombardi) o non ha messo adeguatamente a fuoco.

©Archivio Cicconi/Getty Images
Questa ridescrizione è fatta dal punto di vista di un liberale che s’ispira al pensiero di figure come De Gasperi, Einaudi, Croce, e prima a Cavour. In questo solco, gli uomini di cui Pertici si occupa in questi libri hanno avuto ragione nel senso che hanno pensato o agito allo scopo di difendere posizioni antitotalitarie sia durante gli anni del fascismo sia nel secondo dopoguerra, quando le idee liberal-democratiche si sono trovate sotto l’attacco di intellettuali devoti non alla famiglia liberale cara a Pertici bensì a Marx, Lenin, Mao. In uno dei suoi ultimi libri, Ralf Dahrendorf ha parlato di un’attitudine erasmiana di pensare e di stare al mondo, l’attitudine di chi, come gli studiosi che egli descrive ed elogia (Berlin, Popper, Aron), non ha mai prestato orecchio alle sirene dell’ideologia, e anche in anni ferrei ha difeso con metodo e raziocinio i princìpi liberali che aveva assorbito dai libri degli illuministi francesi e anglosassoni.

©Vittoriano Rastelli/Corbis via Getty Images
È l’attitudine di chi ha fiducia nella forza delle idee ma diffida delle opinionated opinions contro le quali metteva in guardia Hirschman; di chi non ha valori forti a cui fare appello nel momento del dubbio (e per alcuni di costoro il momento del dubbio è durato una vita) ma tiene ferme alcune idee-guida che informano non solo le cose che scrive ma anche il modo in cui si comporta, parla, vive: la diffidenza nei confronti dei sistemi che pretendono di riassumere la vita umana in una formula, e che anziché cercare tante soluzioni provvisorie a quanti sono i problemi, cercano la soluzione che permetterebbe di risolverli tutti; l’insofferenza per le sette, i cartelli, le conventicole; l’idea che di libertà sia meglio averne magari troppa che troppo poca; la fiducia nella libera iniziativa delle persone più che nelle direttive emanate da un’autorità.
 Dahrendorf parlava soprattutto di intellettuali anglosassoni, o che trascorsero un pezzo della loro vita in Gran Bretagna o negli Stati Uniti, il che non è sorprendente, dal momento che è in quei paesi che, nel corso degli ultimi due secoli, questi ideali hanno conservato più forza. Ma, come documenta Pertici, anche in Italia, a volte scorrendo in superficie, a volte sottotraccia, questa tradizione di pensiero ha avuto un suo rilievo, e una relativa continuità di svolgimento: si pensi, a parte Croce ed Einaudi, a riviste come «Il Mondo» o «il Mulino» o «Tempo Presente», tutte voci che hanno
Dahrendorf parlava soprattutto di intellettuali anglosassoni, o che trascorsero un pezzo della loro vita in Gran Bretagna o negli Stati Uniti, il che non è sorprendente, dal momento che è in quei paesi che, nel corso degli ultimi due secoli, questi ideali hanno conservato più forza. Ma, come documenta Pertici, anche in Italia, a volte scorrendo in superficie, a volte sottotraccia, questa tradizione di pensiero ha avuto un suo rilievo, e una relativa continuità di svolgimento: si pensi, a parte Croce ed Einaudi, a riviste come «Il Mondo» o «il Mulino» o «Tempo Presente», tutte voci che hanno 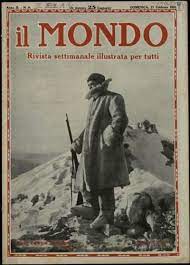 alleviato la solitudine di chi non si trovava a suo agio in un paese – secondo la famosa battuta di Salvemini – «di clericali mezzo comunisti e di comunisti mezzo clericali, nel quale esprimere una franca opinione è diventata roba da manicomio» (che poi nell’Italia di quegli anni, parafrasando il motto di Brancati che soleva citare Sciascia, «per essere veramente liberali occorresse essere almeno comunisti», dal momento che la politica dei liberali era spesso retriva quanto e più di quella dei democristiani, è un altro interessante e non secondario discorso che, esulando dalla sua storia della cultura, Pertici non tocca).
alleviato la solitudine di chi non si trovava a suo agio in un paese – secondo la famosa battuta di Salvemini – «di clericali mezzo comunisti e di comunisti mezzo clericali, nel quale esprimere una franca opinione è diventata roba da manicomio» (che poi nell’Italia di quegli anni, parafrasando il motto di Brancati che soleva citare Sciascia, «per essere veramente liberali occorresse essere almeno comunisti», dal momento che la politica dei liberali era spesso retriva quanto e più di quella dei democristiani, è un altro interessante e non secondario discorso che, esulando dalla sua storia della cultura, Pertici non tocca).
 Dopo la caduta del Muro di Berlino e la dissoluzione dell’Unione Sovietica e del blocco comunista, osserva Pertici, non era forse «giunto il momento di […] rivedere giudizi consolidati e diventati senso comune? Di riscoprire figure in qualche modo “profetiche”, che si erano sottratte al mainstream, pagando spesso le loro scelte con l’emarginazione: ma che, a ben vedere, avevano avuto ragione? Fu in questa prospettiva che m’inoltrai nella storia italiana del secondo Novecento. E siccome è bene che ognuno faccia quel che sa fare e il sottoscritto era stato fino ad allora prevalentemente uno storico dei gruppi intellettuali e della produzione culturale, mi dedicai ad approfondire la conoscenza di una galassia politico-culturale, per decenni decisamente in disgrazia, che potremmo definire “antitotalitaria”».
Dopo la caduta del Muro di Berlino e la dissoluzione dell’Unione Sovietica e del blocco comunista, osserva Pertici, non era forse «giunto il momento di […] rivedere giudizi consolidati e diventati senso comune? Di riscoprire figure in qualche modo “profetiche”, che si erano sottratte al mainstream, pagando spesso le loro scelte con l’emarginazione: ma che, a ben vedere, avevano avuto ragione? Fu in questa prospettiva che m’inoltrai nella storia italiana del secondo Novecento. E siccome è bene che ognuno faccia quel che sa fare e il sottoscritto era stato fino ad allora prevalentemente uno storico dei gruppi intellettuali e della produzione culturale, mi dedicai ad approfondire la conoscenza di una galassia politico-culturale, per decenni decisamente in disgrazia, che potremmo definire “antitotalitaria”».
A parte questa unità del punto di vista, mi pare che due dei temi che più stanno a cuore a Pertici coincidano con le due più grosse cesure della vita pubblica italiana del Novecento, l’una nel secondo l’altra nel terzo quarto del secolo, ovvero il fascismo e l’accelerata modernizzazione del paese.

Giuseppe Dossetti
Quanto al primo tema, Pertici s’interessa al fascismo non tanto nella sua articolazione storica quanto nei suoi riflessi sulla vita e sulle idee di chi ci è passato attraverso: i capitoli più interessanti di Dall’Ottocento alla “Dopostoria” mi paiono quelli in cui riflette sulla reazione al fascismo di figure di primo piano come Orlando, Jemolo, Nitti, Matteotti, Dossetti; o di intellettuali e studiosi meno noti, come appunto Gabrio Lombardi, ma il cui atteggiamento di fronte al regime, alla guerra e alla catastrofe del ’43 rispecchia orientamenti ideali a cui la storiografia repubblicana non ha  dato il giusto rilievo. («La sua Resistenza fu quella dell’esercito regolare sbandatosi nelle varie zone d’occupazione, dei militari internati in Germania, dell’esercito che riuscì a ricostituirsi nel Regno del Sud: ad essa – per mezzo secolo trascurata dalla storiografia accademica a favore di quella più politicizzata delle formazioni partigiane – egli avrebbe poi dedicato alcuni lavori di ricostruzione assolutamente pionieristici»).
dato il giusto rilievo. («La sua Resistenza fu quella dell’esercito regolare sbandatosi nelle varie zone d’occupazione, dei militari internati in Germania, dell’esercito che riuscì a ricostituirsi nel Regno del Sud: ad essa – per mezzo secolo trascurata dalla storiografia accademica a favore di quella più politicizzata delle formazioni partigiane – egli avrebbe poi dedicato alcuni lavori di ricostruzione assolutamente pionieristici»).
Il secondo tema riecheggia nel titolo che Pertici ha voluto dare al più militante dei due libri. “Dopostoria” è una parola di Pasolini: «Guardo i crepuscoli, le mattine / su Roma, sulla Ciociaria, sul mondo, / come i primi atti della Dopostoria, / cui io sussisto, per privilegio d’anagrafe, / dall’orlo estremo di qualche età / sepolta». E pasoliniano è ovviamente anche il tema della modernizzazione violenta e repentina che ha cambiato il volto dell’Italia, e più in generale il senso di una cesura che nei decenni centrali del secolo ha obliterato i costumi e i valori del mondo di ieri: e l’angoscia che deriva da una simile presa di coscienza a chi «per privilegio d’anagrafe», nonché per studi, al mondo di ieri si sente ancora intimamente legato.

Benedetto Croce
Di qui, nella prospettiva di storia culturale che è quella di Pertici, un sottotema che gli è particolarmente caro, quello dei rapporti tra laici e cattolici. Si tratta, per Pertici, di un’occasione mancata, di una collaborazione che avrebbe potuto dare frutti migliori, e qualche chance in più al pensiero liberale, se negli assetti ideologici del secondo Novecento avessero avuto più campo e influenza le posizioni di «cattolici non integralisti, [di] liberali non laicisti», come Croce, e di «socialisti non massimalisti».
Le cose andarono diversamente per un concorso di colpe, e di diffidenze, che Pertici descrive con efficacia: «Si è detto che tale laicismo “liberale” (che in Italia fu proprio anche della componente hegeliana della Destra storica) rispondeva all’oltranzismo ecclesiastico, all’irrigidimento del magistero negli anni intorno al 1870. È vero: ma è anche vero che, in queste componenti, la religione (quella cattolica, in particolare) era di per sé giudicata come un fattore di arretratezza rispetto alle esigenze della modernità, per cui si riteneva necessaria una gigantesca opera di acculturazione per ridurne la presenza. E di tale opera lo Stato diventava l’operatore privilegiato».
 Nella minoranza dei liberali non laicisti alla quale Pertici guarda come a un’occasione mancata, un caso di studio particolarmente inessante è quello di Einaudi. Pertici recupera infatti la sua introduzione a un volumetto del 1945 di monsignor Pietro Barbieri intitolato L’ora presente alla luce del Vangelo: un testo che può sorprendere, scrive Pertici, e di fatto sorprende chi è «legato a una certa idea del liberale Einaudi», perché rivela in lui un profondo senso della tradizione e, ancor più che rispetto, vero e proprio amore per la religione semplice, schiettamente comunicata al popolo:
Nella minoranza dei liberali non laicisti alla quale Pertici guarda come a un’occasione mancata, un caso di studio particolarmente inessante è quello di Einaudi. Pertici recupera infatti la sua introduzione a un volumetto del 1945 di monsignor Pietro Barbieri intitolato L’ora presente alla luce del Vangelo: un testo che può sorprendere, scrive Pertici, e di fatto sorprende chi è «legato a una certa idea del liberale Einaudi», perché rivela in lui un profondo senso della tradizione e, ancor più che rispetto, vero e proprio amore per la religione semplice, schiettamente comunicata al popolo:
La comunità dei credenti non è composta dei soli uomini viventi oggi. Essa vive nelle generazioni che si sono succedute da Cristo in poi. Ognuna di quelle generazioni ha trasmesso quella parola alle generazioni successive; ed ogni generazione ha sentito quella parola e vi ha creduto perché essa era stata sentita e in essa avevano creduto i suoi avi […]. La spiegazione delle parole scritte nei vangeli, la esposizione, anzi, del significato di ognuno dei riti e dei canti che si leggono nei breviari è il primo dovere del sacerdote; è un dovere interpretato dai sacerdoti nel modo più diverso. Confesso di apprezzare scarsamente la maniera dotta e quella polemica […]. L’uomo semplice e la donna umile chiedono al sacerdote: dimmi come dobbiamo vivere ogni giorno, come dobbiamo interpretare alla luce del Vangelo gli avvenimenti quotidiani, quale è la legge morale alla quale dobbiamo conformarci, quali, fra i comandi ricevuti dai potenti della terra, da coloro che oggi imperano su di noi e sui nostri fratelli viventi nelle più diverse parti del mondo, siano quelli ai quali dobbiamo ubbidire.
 E rivela anche, in chi come Einaudi aveva fatto esperienza dell’invasività dei media in epoca fascista, una diffidenza, quasi una ripugnanza nei confronti della comunicazione di massa non mediata dalla parola scritta:
E rivela anche, in chi come Einaudi aveva fatto esperienza dell’invasività dei media in epoca fascista, una diffidenza, quasi una ripugnanza nei confronti della comunicazione di massa non mediata dalla parola scritta:
Non sono un ammiratore della radio. Da molti anni, da quando sullo orizzonte salì la maligna stella del conformismo politico, che è necessariamente altresì conformismo o totalitarismo spirituale morale religioso ed economico, pensai che la radio era un’invenzione del demonio, intento a trovare il mezzo di abbrutire l’uomo […]. Quella parola entra come uno stillicidio nel cervello dell’ascoltatore ed a poco a poco lo rende incapace di ragionare e lo inebetisce. Nessuna invenzione è più spaventosamente atta, quando sia maneggiata dallo spirito del male, a rendere l’uomo un numero, un automa. Per nessuna invenzione si deve, perciò, avere altrettanta cura, affinché essa sia adoperata nello spirito del bene.
 Un liberale che rimpiange la ferma direzione delle anime da parte dei sacerdoti; e che diffida della circolazione delle idee attraverso i media di massa: non è effettivamente l’Einaudi a cui il lettore non specialista è abituato a pensare. E scoperte analoghe si fanno quasi a ogni capitolo.
Un liberale che rimpiange la ferma direzione delle anime da parte dei sacerdoti; e che diffida della circolazione delle idee attraverso i media di massa: non è effettivamente l’Einaudi a cui il lettore non specialista è abituato a pensare. E scoperte analoghe si fanno quasi a ogni capitolo.
«Coloro che vivono in un certo momento sulla terra» osserva Pertici «non possono decidere unilateralmente di disfarsi del retaggio che proviene dagli uomini e dalle donne che non ci sono più, ma che è stato trasmesso loro perché, a loro volta, se ne facessero tramite». È un commento alle parole di Einaudi che ho appena trascritto; ma è anche una dichiarazione che illumina la posizione dello stesso Pertici, il cui profilo, la cui fisionomia intellettuale s’intravede spesso in filigrana nei ritratti che compongono questi due volumi: allarmato di fronte alla crisi che investe l’universo culturale, sociale e politico all’interno del quale la sua (e la mia) generazione è cresciuta, tutto ciò che era solido – la Chiesa, la democrazia rappresentativa, il legame culturale e affettivo con la classicità, il sapere storico – si dissolve nell’aria; e allarmato di fronte a un’invadenza dei media che fa apparire le lontane parole di Einaudi insieme ingenue e profetiche.
«Ci sentiamo di continuo» scrive Pertici commentando la poesia di Pasolini che chiude il volume «come sull’orlo estremo di qualche età sepolta ad assistere all’avvento di un’età nuova e inedita di cui stentiamo a rintracciare i contorni». Il lettore non deve pensare però a un piagnisteo sul tempo che passa e la civiltà che tramonta (come spesso, invece, in Pasolini).

©Vittoriano Rastelli/Corbis via Getty Images
C’è in tutti questi saggi, pur nella poca simpatia nei confronti dell’età corrente, una disponibilità a capirla, a vederne le ragioni anche contro i propri convincimenti e le proprie inclinazioni che sembra provenire dallo spirito equanime non solo dell’autentico storico ma dell’autentico scrittore (ciò che Pertici è senz’altro, se si guarda alla qualità anche formale delle sue pagine). Leggendolo, mi è tornato in mente un passo di Vita e destino di Grossman che dedico volentieri ai liberali preoccupati come lui (e come me) un po’ come diagnosi, un po’ come augurio, un po’ anche come invito a non drammatizzare troppo (ma a restare vivi e operosi!): «Da giovane, tra amici che la pensavano come lui, era facile capirsi, sentirsi vicini. E ogni idea, ogni opinione del nemico era estranea, mostruosa.
Adesso, invece, gli capitava di cogliere, nei giudizi di chi la pensava diversamente da lui, idee che gli erano state care decenni prima, o di sentire estranee le considerazioni e le parole degli amici. Mah, forse è perché sono al mondo da troppo tempo, pensava Mostovskoj».
_________________________________________
Su Roberto Pertici leggi anche:
Intervista a Roberto Pertici: La cultura “antitotaliaria” nell’Italia della prima Repubblica
L’Italia dei vinti nell’analisi di Roberto Pertici
«L’Italia ha perso il passato Ormai siamo diventati consumatori del presente»





