Strumenti culturali di Litterae Communionis n.7
I GRANDI DELLA CULTURA MODERNA RIVISITATI
«Un tempo non capivo perché non ricevessi risposta alla mia domanda, oggi non capisco come potessi illudermi di fare domande. Ma mm non è che mi illudessi. Interrogavo soltanto»
Testo di Luca Doninelli
Premessa
Tracciare il corso della vita di un uomo — di noi stessi come di chiunque altro — è sempre un’impresa difficile. Non solo, infatti, è mutevole il modo in cui ci percepiamo e in cui gli altri percepiscono noi, ma è sovente impossibile (o affidato a un dono, a una rivelazione) comprendere di quale Problema siano un’eco tutti i nostri problemi particolari, di quale Dramma tutti i nostri drammi.
Spesso un certo motivo ci induce ad una certa scelta; anni dopo ci accade, riguardando a quella scelta, di scoprire, sotto quell’apparente motivo, un altro motivo, ben più reale, eppure allora ignoto. Ci può accadere ad esempio di innamorarci di una donna e di scorgere solo in seguito la ragione vera di quell’amore; ci accade di sposarci, e di scoprire, a poco a poco (in quel profondo rapporto con il Tempo che si chiama Fedeltà), che quel legame è tanto più vero quanto più trasparenza, decantazione di un altro Legame.
La nostra esistenza si disegna sulla Terra come una linea contorta — esattamente come le parole che l’inchiostro traccia sulla carta: la continuità di questa linea è l’immagine della decisione intorno alla totalità della vita (religiosità); le curve, le contorsioni, i ghirigori, sono invece l’immagine e la somma di tutte le nostre scelte, di tutti i nostri sentimenti, dei dolori e delle gioie, dei momenti di chiarezza intorno al senso della nostra vita e dei momenti di oscurità.
Risulta arduo, perciò, tracciare una biografia — proprio perché il punto di vista attraverso cui selezionare i fatti importanti e quelli meno importanti non può mai essere fissato. Una biografia, insomma, anche qualora la si voglia limitare alla pura e semplice registrazione di fatti esteriori (e già sotto questa apparente oggettività si cela la parzialità della scelta), costituisce un’impresa limitata e piena di rischi.
Parlando di uno scrittore, poi, sembra imporsi un punto di vista d’obbligo, e Kafka in particolare è tra quegli autori che danno l’impressione di imperlo con maggiore autorità: è il punto di vista della scrittura, dell’attività letteraria; esistono autori, cioè, la cui vita pare totalmente determinata, assorbita nell’attività letteraria, e questo non nel senso che, nella vita, non abbiano fatto altro che scrivere — tentazione peraltro documentabile in Kafka come in altri —, ma nel senso che ogni avvenimento della loro vita, per quanto estraneo alla letteratura, reca su di sé il peso di un’esistenza votata ad essa.
E’ questo il punto di vista che adotterò ed è questo, di conseguenza, il motivo per cui preferisco considerare il capitolo biografico su Kafka non come un’introduzione, bensì come un esito — precario! — dell’indagine sulla sua opera.
Esito precario, dicevo: infatti, quello che pare un punto di vista (l’attività letteraria) è, in realtà, l’opposto di un punto dì vista. Non un’altura da cui è possibile dominare un panorama, bensì un abisso buio: chi può stabilire, cioè, qual è l’origine delle nostre parole, e quale ne sia il significato ultimo e definitivo.
__________________________________________________________________________
Davanti alla legge (1914)
Davanti alla legge c’è un guardiano. Davanti a fui viene un uomo di campagna e chiede di entrare nella legge. Ma il guardiano dice che ora non gli può concedere di entrare. L’uomo riflette e chiede se almeno potrà entrare più tardi. «Può darsi» risponde il guardiano, «ma per ora no». Siccome la porta che conduce alla legge è aperta come sempre e il custode si fa da parte, l’uomo si china per dare un’occhiata, dalla porta, nell’interno. Quando se ne accorge, il guardiano si mette a ridere: «Se ne hai tanta voglia prova pure a entrare nonostante la mia proibizione. Bada, però: io sono potente, e sono soltanto l’infimo dei guardiani. Davanti a ogni sala sta un guardiano, uno più potente dell’altro. Già la vista del terzo non riesco a sopportarla nemmeno io».
L’uomo di campagna non si aspettava tali difficoltà; la legge, pensa, dovrebbe pur essere accessibile a tutti e sempre, ma a guardar bene il guardiano avvolto nel cappotto di pelliccia, il suo lungo naso a punta, la lunga barba tartara, nera e rada, decide di attendere piuttosto finché non abbia ottenuto il permesso di entrare. Il guardiano gli da uno sgabello e lo fa sedere di fianco alla porta. Là rimane seduto per giorni e anni. Fa numerosi tentativi per passare e stanca il guardiano con le sue richieste.
Il guardiano istituisce più volte brevi interrogatori, gli chiede notizie della sua patria e di molte altre cose, ma sono domande prive di interesse come le fanno i gran signori, e alla fine gli ripete sempre che ancora non Io può far entrare. L’uomo che per il viaggio si è provveduto di molte cose da fondo a tutto per quanto prezioso sia, tentando di corrompere il guardiano. Questi accetta ogni cosa, ma osserva: «Lo accetto soltanto perché tu non creda di aver trascurato qualcosa».
Durante tutti quegli anni l’uomo osserva il guardiano quasi senza interruzione. Dimentica gli altri guardiani e solo il primo gli sembra l’unico ostacolo all’ingresso della legge. Egli maledice il caso disgraziato, nei primi anni ad alta voce, poi quando invecchia si limita a brontolare tra sé. Rimbambisce e siccome studiando per anni il guardiano conosce ormai anche le pulci del suo bavero di pelliccia, implora anche queste di aiutarlo e di far cambiare opinione al guardiano. Infine il lume degli occhi gli si indebolisce ed egli non sa se veramente fa più buio intorno a lui o se soltanto gli occhi lo ingannano. Ma ancora distingue nell’oscurità uno splendore che erompe inestinguibile dalla porta della legge.
Ormai non vive più a lungo. Prima di morire tutte le esperienze di quel tempo si condensano nella sua testa in una domanda che finora non ha rivolto al guardiano. Gli fa un cenno poiché non può ergere il corpo che si sta irrigidendo. Il guardiano è costretto a piegarsi profondamente verso di lui, poiché la differenza di statura è mutata molto a sfavore dell’uomo di campagna. Che cosa vuoi sapere ancora?» chiede il guardiano, «sei insaziabile». L’uomo risponde: tutti tendono verso la legge, come mai in tutti questi anni nessun altro ha chiesto di entrare?».
Il guardiano i rende conto che l’uomo è giunto alla fine e per arsi intendere ancora da quelle orecchie che sanno per diventare insensibili, grida: «Nessun altro poteva entrare qui perché questo ingresso era destinato soltanto a te. Ora vado a chiuderlo ».
___________________________________________________________________________
La sua opera
«Non esiste l’avere, esiste solo l’essere: quell’essere che anela all’ultimo respiro, alla soffocazione».
1. La letteratura secondo Kafka
 Se si pone mano all’opera completa di Kafka, due sono le osservazioni che si impongono immediatamente, a causa della loro stessa evidenza. La prima è che si tratta di un insieme molto omogeneo e compatto che lascia intravedere dalle primissime prove (1904) alle ultime, appena precedenti la morte (1924), una linea di sviluppo logico assai nitida, sia dal punto di vista stilistico, sia da quello della tematica.
Se si pone mano all’opera completa di Kafka, due sono le osservazioni che si impongono immediatamente, a causa della loro stessa evidenza. La prima è che si tratta di un insieme molto omogeneo e compatto che lascia intravedere dalle primissime prove (1904) alle ultime, appena precedenti la morte (1924), una linea di sviluppo logico assai nitida, sia dal punto di vista stilistico, sia da quello della tematica.
La seconda osservazione è che questa unità reca il segno di un’immensa fatica — si ha l’impressione, in altri termini, che Kafka faticasse molto a scrivere, quasiché (è un’altra impressione unanime) ogni sua parola recasse significati insondabili: ogni racconto, per quanto breve, ogni nota, ogni frammento, hanno in sé qualcosa di titanico, di mastodontico — quasi i segni, le ferite di un’antica, gigantesca lotta. E questa è ciò che chiamo la fatica.
All’interno di queste osservazioni generalissime (che, in fondo, si potrebbero fare di quasi tutti i grandi scrittori), si presentano spunti inquietanti, nuove osservazioni che complicano un po’ il quadro: l’«insieme molto omogeneo e compatto» dell’opera Kafkiana, ad esempio, si presenta come un’infinita congerie di frammenti, quali più quali meno lunghi: se si eccettuano alcuni racconti, pochissimi, miracolosamente giunti a conclusione — si può annoverare il racconto La condanna (1912) e poche altre cose —, l’opera Kafkiana è composta totalmente di abbozzi mai giunti a conclusione: è così per i suoi racconti ed è così per i suoi tre romanzi, America (1912-14), Il Processo (iniziato nel 1914) e Il Castello (1922); occorre aggiungere che romanzi e racconti costituiscono meno della metà dell’intero Corpus Kafkiano, che comprende ancora: I Diari (1910-1923), dove non si registrano soltanto i fatti della vita quotidiana, ma si possono ammirare veri e propri abbozzi di racconti e romanzi, oltre a note profondissime sull’attività letteraria ed a considerazioni filosofiche; i Quaderni in ottavo e i Frammenti (la data è imprecisabile), vero e proprio intrico di note biografiche, brevi racconti — sempre interrotti d’improvviso — e sentenze morali (una parte delle quali Kafka tentò di sistemare organicamente sotto il titolo Considerazioni sul peccato, il dolore, la speranza e la vera via e da ultimo le numerose lettere, tra cui fanno spicco le Lettere a Felice (Felice – pron. Felìs – Bauer, con cui ebbe una tempestosa storia d’amore), le Lettere a Milena (Milena Jasenska, scrittrice boema, traduttrice dei suoi primi racconti), le Lettere a Ottla (sua sorella prediletta, una sorta di alter-ego) e la celeberrima Lettera al padre — anche di questa mi occuperò in uno dei prossimi paragrafi. Bisogna aggiungere, poi, un’altra caratteristica dei romanzi e dei racconti Kafkiani: l’enorme quantità di brani soppressi — di brani cioè sovente bellissimi, cui Kafka però non volle dare il «crisma dell’ufficialità».
Questo fatto è inquietante; è vero che anche i brani «ufficiali» sembrano sul punto di subire la medesima destituzione degli altri; è vero che anche di questi egli fu insoddisfatto; è vero che molti brani cancellati furono poi riabilitati e viceversa — ed è presumibile che molti altri avrebbero avuto una sorte analoga, se la tubercolosi non avesse stroncato l’Autore nel 1924, a soli 41 anni; è vero, insomma, che è sovente impossibile comprendere il motivo per cui alcuni passi furono tollerati ed altri no («tollerati» mi sembra la parola più adatta): questo, tuttavia, nulla toglie all’interrogativo che ne viene, e che, forse, è decisivo ai fini di una corretta interpretazione dell’opera del grande scrittore boemo: cosa spinse Kafka ad operare continuamente una simile distinzione? E — poiché le due cose, anche cronologicamente, proseguirono di pari passo — che rapporto esiste in Kafka, tra lo «scrivere» e il «cancellare»?
 A queste domande non mi propongo di dare una risposta, in quanto non ne sono ancora in grado. Con quel che segue, intendo, piuttosto, chiarirle, soppesarle e, se ne avrò la forza, offrire al lettore lo spunto attraverso il quale egli, a vivo contatto con l’opera Kafkiana, potrà tentare poi, personalmente, una risposta. A questo scopo, prendiamo in esame alcune tra le opere più famose di Kafka: i romanzi Il Processo e Il Castello ed il lungo racconto La metamorfosi.
A queste domande non mi propongo di dare una risposta, in quanto non ne sono ancora in grado. Con quel che segue, intendo, piuttosto, chiarirle, soppesarle e, se ne avrò la forza, offrire al lettore lo spunto attraverso il quale egli, a vivo contatto con l’opera Kafkiana, potrà tentare poi, personalmente, una risposta. A questo scopo, prendiamo in esame alcune tra le opere più famose di Kafka: i romanzi Il Processo e Il Castello ed il lungo racconto La metamorfosi.
Ne Il Processo si parla dell’arresto di un uomo, certo Josef K. Non si tratta però di un arresto vero e proprio — K. non viene messo in prigione — quanto, piuttosto, della comunicazione che è stato intentato un processo a suo carico. Chi siano gli accusatori e di quale delitto sia stato accusato non si sa né si saprà.
L’unica cosa di cui K. è certo è che c’è questo processo — che, cioè, in un qualche luogo, incartamenti riguardanti la sua persona passano sotto gli occhi di uomini potentissimi e ignoti; l’esito dei processi — di questo K. viene informato da numerose persone, seppur con un certo tatto — è sempre lo stesso: la condanna. Ciò non toglie, però, che K. sia in dovere di tentare tutto ciò che si può tentare (forse che fa parte anche questo delle regole del gioco?) al fine di conseguire la salvezza.
Tutto sembra poter essere utile a quest’uopo, anche le cose apparentemente più banali — per esempio la facile seduzione della giovane domestica di un avvocatucolo malato —; anzi: forse basterebbe una sciocchezza per salvare K. Il guaio è che, non sapendo di cosa lo si accusi, né chi siano gli accusatori, né chi siano i giudici, ogni sua mossa, per quanto oculata, risulta essere sempre casuale; esiste un universo ordinato, in cui ogni cosa ha, probabilmente, il suo posto, del quale però K. mostra di non sapere nulla. Sugli aspetti politici, religiosi, morali di questo rapporto tra l’individuo e il tutto si potrebbe dilungarsi.
 Quel che qui importa è che i giudici, dall’alto del loro luogo inaccessibile, non hanno modo di apprezzare un comportamento così disordinato; ciò che egli fa tentando di piacer loro, non fa che aggravare la sua posizione. Inoltre egli è convinto di essere innocente (il romanzo infatti comincia con queste parole: «Qualcuno doveva aver calunniato Josef K. perché senza che avesse fatto nulla di male, una bella mattina lo arrestarono»); e lo è; l’Autore non lascia dubbi in proposito, infatti dice esplicitamente che K. non aveva fatto «nulla di male»; tuttavia, questa convinzione si scontra con un’altra realtà, quella della legge, e dei giudici, che della legge sono i custodi.
Quel che qui importa è che i giudici, dall’alto del loro luogo inaccessibile, non hanno modo di apprezzare un comportamento così disordinato; ciò che egli fa tentando di piacer loro, non fa che aggravare la sua posizione. Inoltre egli è convinto di essere innocente (il romanzo infatti comincia con queste parole: «Qualcuno doveva aver calunniato Josef K. perché senza che avesse fatto nulla di male, una bella mattina lo arrestarono»); e lo è; l’Autore non lascia dubbi in proposito, infatti dice esplicitamente che K. non aveva fatto «nulla di male»; tuttavia, questa convinzione si scontra con un’altra realtà, quella della legge, e dei giudici, che della legge sono i custodi.
Anche sull’esistenza (seppur invisibile) di questo Ordine, Kafka non lascia dubbi. Il conflitto ha luogo tra due parti ognuna delle quali sembra avere ragioni inoppugnabili. Di fronte alla legge, la presunta e non ancor provata colpevolezza di K. (il processo è, infatti, ancora in corso, perciò circa la colpa iniziale di K.
Il giudizio è tutt’altro che pronunciato) si trasforma in torto patente: ogni gesto di K. viene interpretato in modo diverso dai giudici, e si badi: K. non viene frainteso; molto più profondamente, le sue parole e le sue azioni stanno in due ordini, in due universi del tutto differenti, ognuno reale e sorretto da saldi principi e diritti: quello della persona e quello extrapersonale, e per l’uno egli E’ innocente, per l’altro egli E’ (non sembra, è) colpevole. In quanto innocente, egli deve — cioè: è in dovere di — mostrare e provare questa innocenza. In quanto colpevole, parimenti egli deve essere condannato, e così sarà.
Il Castello, forse la più grande fatica di Kafka, presenta ancora il personaggio K. (stavolta il nome Josef non c’è più): è un agrimensore — un geometra — che, ricevuto da un Castello l’ordine di presentarsi, poiché è stato assunto, lascia la propria vita precedente, la propria città, i propri affetti per recarvisi.
Giunto, però, al misero villaggio che giace ai piedi del Castello, mille difficoltà gliene impediscono l’accesso. Quasi subito, inoltre, viene a sapere che, pur essendo regolarmente assunto, in realtà non può lavorare per il semplice motivo che lì non c’è alcun bisogno di un agrimensore; al tempo stesso viene a sapere un’altra cosa, che, forse, aveva già sospettata: che al Castello non è possibile giungere, e che, per ogni questione (ma quali questioni? Non certo di lavoro, visto che della sua opera non c’è — né ci sarà — alcun bisogno) egli deve rivolgersi esclusivamente ai funzionari del Castello presenti nel villaggio: in primis il sindaco.
Poniamo mente, ora, alla situazione in cui K. si trova: egli si trova nel villaggio, e il villaggio è nel territorio del Castello ed appartiene, quindi, al Castello stesso. K., perciò, in un certo senso, si trova dentro il Castello — così dentro che, se da un lato è impossibile giungere al Castello, dall’altro è parimenti impossibile uscire, dal suo territorio, e questo perché egli è legato al Castello da regolare contratto e ne è, perciò — e a tutti gli effetti —, alle dipendenze. Egli è dunque, a un tempo, radicalmente dentro il Castello e radicalmente fuori.
La sua estraneità viene, poi, sottolineata ad ogni pie’ sospinto; pensiamo, ad esempio, alle circostanze della sua assunzione: la sua assunzione è dovuta ad un errore burocratico: la pratica relativa al suo impiego fu smarrita ai tempi in cui di lui c’era bisogno, ed egli ricevette la comunicazione parecchi anni più tardi, allorché la pratica fu ritrovata.
A questo punto K. potrebbe pretendere che l’equivoco sia chiarito, in modo che egli possa essere congedato; ma le cose non sono così semplici: infatti il Castello stesso si basa sul presupposto che il suo funzionamento è perfetto; il grande potere del Castello sta, anche e soprattutto, in questa sovrumana (davvero sovrumana!) perfezione; ora, che un piccolo, rarissimo errore venga commesso, è un fatto reale — lo prova l’assunzione tardiva di K. —, ma non possibile. Se, infatti, se ne ammettesse la possibilità, il Castello stesso smetterebbe, per così dire, di esistere — perderebbe la sua ragion d’essere.
 Il ragionamento è meno assurdo di quanto possa apparire: un avvenimento, benché reale, può essere accidentale, casuale. Se un fatto è casuale, era sì possibile che accadesse (ciò che è reale è anche possibile), ma, proprio perché casuale, esime — prima che sia accaduto — dal ritenerlo possibile. In altri termini, la sua possibilità s’impone dopo che è accaduto, non prima, e, in ogni modo, il sindaco del villaggio s’appiglia ad un ragionamento non troppo distante per far vedere a K. che, sì, un errore è stato commesso, ma che questo non può intaccare la perfezione della burocrazia del Castello.
Il ragionamento è meno assurdo di quanto possa apparire: un avvenimento, benché reale, può essere accidentale, casuale. Se un fatto è casuale, era sì possibile che accadesse (ciò che è reale è anche possibile), ma, proprio perché casuale, esime — prima che sia accaduto — dal ritenerlo possibile. In altri termini, la sua possibilità s’impone dopo che è accaduto, non prima, e, in ogni modo, il sindaco del villaggio s’appiglia ad un ragionamento non troppo distante per far vedere a K. che, sì, un errore è stato commesso, ma che questo non può intaccare la perfezione della burocrazia del Castello.
Ciò posto, risulta ridicola la proposta di K. di riprendere in mano la pratica e «regolarizzare» la sua situazione. In definitiva: egli non può giungere al Castello, ma nemmeno andarsene; egli non ha un posto nella vita del Castello (in quanto non c’è bisogno di un agrimensore), ma, al tempo stesso, ne è legato, poiché il Castello lo ha assunto. Risulta perciò ad un tempo legittima ed illegittima la sua richiesta di essere ammesso al Castello.
Come ne Il Processo tutti gli accusati devono difendersi, eppure saranno condannati, così qui egli deve — per ricevere giustizia — essere ammesso lassù, ma al tempo stesso la sua risulta essere una pretesa assurda, in quanto, a parte il fatto che per il Castello non può che apparire incomprensibile, essa infastidisce i grandi personaggi che là vivono; è, inoltre, ingiusto che egli reclami giustizia, poiché, dal punto di vista del Castello, giustizia gli è già stata fatta.
Ne consegue che egli tenta reiteratamente di arrivare lassù, ma che, conseguentemente, i suoi motivi si fanno sempre più pretestuosi, ed egli passa dalla ragione al torto — o, per meglio dire, dalla propria ragione alla ragione del Castello.
La Metamorfosi è, forse, l’opera più nota di Kafka. Parla di un certo Gregor Samsa, il quale si sveglia una mattina, nel proprio letto, trasformato «in un enorme insetto immondo». Non mi dilungo in riassunti (d’altra parte nemmeno delle opere precedenti ho fatto il riassunto). Ciò che, qui, più mi sembra interessante è il progressivo adattamento dello stesso Samsa ad una situazione evidentemente assurda: all’inizio egli crede che si tratti di un sogno, più tardi egli crede sia una malattia.
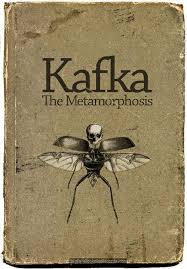 L’eccezionalità di una simile metamorfosi non sfiora mai né la sua né le altrui anticamere del cervello. La famiglia non prova dolore: dopo una debole sorpresa, la pervade un senso di sconvenienza e di vergogna — tantoché, alla morte dell’insetto, tutti i famigliari si sentiranno sollevati, liberati. Dal canto suo, Samsa finisce per adattarsi definitivamente alla propria condizione, e rimbambisce progressivamente. Quando muore egli è, a tutti gli effetti, soltanto un insetto — vale a dire: muore come un condannato, la cui colpa è indiscutibile.
L’eccezionalità di una simile metamorfosi non sfiora mai né la sua né le altrui anticamere del cervello. La famiglia non prova dolore: dopo una debole sorpresa, la pervade un senso di sconvenienza e di vergogna — tantoché, alla morte dell’insetto, tutti i famigliari si sentiranno sollevati, liberati. Dal canto suo, Samsa finisce per adattarsi definitivamente alla propria condizione, e rimbambisce progressivamente. Quando muore egli è, a tutti gli effetti, soltanto un insetto — vale a dire: muore come un condannato, la cui colpa è indiscutibile.
Ora, a queste tre situazioni almeno un punto (in realtà sono ben più di uno) è comune. Tutti e tre i protagonisti vivono una condizione di estraneità: alle leggi ne Il Processo; al Castello nel romanzo omonimo; alla famiglia ne La Metamorfosi. Sono tutti e tre fuori legge, tutti e tre innocenti.
Ma, nello stesso tempo, tutti e tre sono condannati. Un’altra caratteristica comune è questa, che, in un certo senso, la sentenza di condanna è già stata pronunciata. Perché «in un certo senso»? Perché, in realtà, la condanna non è stata pronunciata, la sentenza è in sospeso, e tuttavia, benché la possibilità della salvezza esista, all’uomo non è dato di conoscerla.
Particolarmente significativa mi sembra una conversazione che Max Brod, il miglior amico di Kafka, riferisce di aver avuto con Kafka stesso: «”Mi ricordo” dice Brod “di una conversazione con Kafka, che partiva dall’Europa attuale e dalla decadenza dell’umanità. ‘Noi siamo’ egli disse ‘pensieri nichilisti, pensieri di suicidio, che affiorano nella mente di Dio’.
Ciò, dapprima, mi fece pensare alla visione del mondo della gnosi: Dio come cattivo demiurgo, il mondo il suo peccato originale: ‘Oh no!’ egli disse, ‘il nostro mondo è solo un cattivo umore di Dio, una cattiva giornata’. ‘Al di fuori di questa manifestazione, di questo mondo che noi conosciamo, ci sarebbe quindi speranza’. Egli sorrise: ‘Oh, certo, molta speranza, infinita speranza. Ma non per noi’ “».
In questo consiste la condanna, che, nelle opere sopra citate, costituisce il dato di partenza: all’inizio de Il Processo egli, subito, viene arrestato; all’inizio de // Castello, già si trova nel villaggio; all’inizio de La Metamorfosi egli è già diventato un insetto (come si vedrà, ho distrattamente riunito in uno i tre protagonisti).
C’è forse un racconto che parla di questa condanna, che ci parla del «prima» di questa condanna: esso è intitolato, appunto, La condanna, e Kafka (a mio parere non del tutto a torto) lo considerò sempre il proprio capolavoro. Vi si parla di un giovane, di suo padre malato, di un amico lontano e di una ditta da mandare avanti. Il giovane deve prendere in mano la ditta, il vecchio padre è debole.
Finita di scrivere una lettera all’amico, il giovane mette il padre a letto — e fin qui il racconto procede con placidità. Ma, d’un tratto, il padre si toglie di dosso le coperte e s’alza in piedi sul letto; i rapporti di forza s’invertono, il giovane diviene debolissimo, mentre il padre si mostra a lui in tutta la sua terrificante potenza: «Ora sai dunque» dice il padre, in conclusione di un lungo discorso «ciò che esiste fuori di te, finora non conoscevi che te stesso. Eri davvero un bambino innocente, ma ancor più un essere diabolico! E perciò sappi: ti condanno a morire affogato!». Potremmo definire l’opera di Kafka come il racconto di questo affogamento, il suo resoconto.
// Processo, II Castello e La Metamorfosi raccontano l’intervallo fra la condanna e la fine. Bisogna aggiungere che la morte non sarebbe la logica conseguenza della condanna (le possibilità di salvezza sono, infatti, innumerevoli), se ciò non accadesse a causa della condizione fattuale dell’uomo; come il funzionamento burocratico del Castello è perfetto, così anche l’Universo è pieno di bontà e di giustizia, ma un fattore astratto, accidentale (in questi casi: l’ignoranza dell’uomo), rende tale bontà e tale giustizia praticamente irraggiungibili. Inoltre, tale condizione sembra essere quella dell’uomo cosciente, di colui che sa quel che esiste fuori di sé.
Nell’infanzia tutto è possibile perché, in realtà, non si è ancor sperimentata la possibilità di qualcosa «… finora non conoscevi che te stesso». L’uomo, è, dunque, colui che scopre, contemporaneamente, la possibilità e l’impossibilità della salvezza. Ecco perché i protagonisti delle opere di Kafka sono sempre in bilico tra l’appartenenza e l’estraneità, tra la speranza e la disperazione — e si noti: Kafka non pone nulla in dubbio, è l’autore della certezza!
Cerchiamo, ora, di mettere in luce il legame tra il problema che ci siamo posti all’inizio e le osservazioni testé compiute. Che c’entra tutto quel che siam venuti dicendo fin qui con il problema del rapporto «scrivere » — «cancellare»? (forse qualcuno — o molti, a seconda che la mia spiegazione vi sia apparsa più o meno convincente — non avrà ancora ben compreso cosa ci sia d’importanza in un simile problema, o forse non troverà neppure utile un capitolo sulla scrittura — perché che uno scrittore scriva è evidente, com’è evidente che quando al bar chiediamo un caffè, esso ci verrà servito in un qualunque contenitore, ma che la forma del contenitore e i disegni sullo smalto non avranno molto a che vedere con la bontà del caffè.
 E’ vero: il contenitore può essere sudicio, e questo avrebbe a che vedere, eccome! Allo stesso modo un libro potrebbe essere così mal scritto, da invalidare qualsiasi splendore vi fosse contenuto; ma allora, si direbbe, non è sufficiente stabilire se la prosa è buona o no, se lo stile è «elegante» o «ricco» o «essenziale» o «barocco» o « scarno» eccetera eccetera? E una simile indagine non è più opportuna alla fine — cioè dopo che si è presa in esame l’opera?
E’ vero: il contenitore può essere sudicio, e questo avrebbe a che vedere, eccome! Allo stesso modo un libro potrebbe essere così mal scritto, da invalidare qualsiasi splendore vi fosse contenuto; ma allora, si direbbe, non è sufficiente stabilire se la prosa è buona o no, se lo stile è «elegante» o «ricco» o «essenziale» o «barocco» o « scarno» eccetera eccetera? E una simile indagine non è più opportuna alla fine — cioè dopo che si è presa in esame l’opera?
La risposta a queste obiezioni non è semplice e spero vivamente di poterla dare nel corso del lavoro — che le scelte compiute si giustifichino man mano che l’indagine procede. Per il momento mi limito ad osservare che l’affermazione «lo scrittore scrive» esprime un contenuto della vita, un’azione che definisce chi la compie; già questa osservazione limita un po’ l’idea che la prosa, lo stile, sia equiparabile ad un recipiente: se, infatti, lo scrivere è un contenuto della vita che consiste in un determinato rapporto con la parola, l’indagine intorno al modo in cui un autore concepisce il proprio rapporto con la parola verrà a dirci qualcosa di più sulla sua persona — che è come dire illuminare una parte, se la parte è concepita in rapporto al tutto, servirà ad illuminare meglio il tutto. E con questo domando scusa per la lunga parentesi).
Per riprendere la questione circa il rapporto «scrivere» — «cancellare» — che è poi il problema della parola —, mi permetto di formulare un’ipotesi: che al di là dei testi dei quali si mostrò contento, tutta l’opera di Kafka (compresi in ultima analisi, questi stessi testi) appare destinata alla non ufficialità, alla cancellatura.
Forse così si può spiegare la disposizione testamentaria, con la quale Kafka ordinò che i suoi scritti fossero bruciati dopo la sua morte — disposizione che, naturalmente, non fu rispettata. Non penso che un simile desiderio riguardasse solo una eventuale pubblicazione; anzi, allorché redasse il testamento, è pensabile che egli non si preoccupasse troppo di questo; del resto, egli pubblicò alcune cose mentre era in vita e non sembra che questo avesse per lui troppa importanza, né in senso negativo, né in senso positivo.
Non è perciò il timore del pubblico, o la sfiducia nel prossimo, o l’idea di non riuscire a dare un’immagine adeguata di sé — non è questo ciò che si deve leggere, innanzitutto, dietro quella disposizione. Occorre scendere più in profondità, scendere al livello del rapporto dell’Autore con le parole.
E, qui, vale riprendere l’osservazione che veniva dall’esame, sia pur sommario, di alcune opere Kafkiane: che, cioè, i protagonisti di tali opere vivono una duplice condizione, di prigionia e di estraneità (prigionieri della legge eppure estromessi da questa; prigionieri della famiglia eppure tanto estranei ad essa quanto lo è uno scarafaggio da un uomo); si può dire che, forse, è proprio di questa estraneità che essi sono prigionieri; essi sono stati estromessi, pur essendo innocenti, ed ora il loro supplizio consiste nel rimprovero di questa estromissione, vista, giustamente, come un torto subito.
Ma proprio questo rimprovero, questa recriminazione, si trasforma in colpa ed è destinata alla condanna. Ne fa eco un testo di Kafka: «La colpa originaria, l’antico torto commesso dall’uomo, consiste nel rimprovero che egli fa, e da cui non desiste, che gli è stato fatto un torto, che la colpa originaria (l’arresto, o la trasformazione in insetto, n.d.r.) è stata commessa contro di lui».
Ora, se consideriamo la struttura dell’opera Kafkiana, la logica, la trama, i personaggi, e, più generalmente, le vie (tantissime!) attraverso cui il racconto si dipana, non tarderemo a ravvisare uno stretto rapporto tra l’estraneità di cui sopra e la concezione Kafkiana della parola; in altri termini, potremmo chiederci: qual è, per Kafka, la parola che conta? La risposta è semplice: la parola che conta è quella che esprime la regola del mondo, vale a dire la legge, oppure Dio medesimo.
La parola vera è quella che vive del rapporto con la verità. Tuttavia questa verità è inconoscibile (sarà interessante, a questo proposito, ravvisare nell’ebraismo le radici di tale posizione); leggiamo, a tale riguardo, un passo suggestivo, che si trova all’inizio de Il Castello. Dall’osteria del villaggio, K. telefona al Castello: «Dal ricevitore uscì un sussurro che K. non aveva mai udito telefonando.
Pareva che il brusìo di innumerevoli voci infantili — ma non era un brusìo, era un canto di voci lontane, lontanissime — che questo brusìo si fondesse in modo inesplicabile, e formasse una voce sola, acuta ma forte, che colpiva il timpano come chiedendo di penetrare assai più profondamente », vale a dire di scendere alla radice dell’uomo, a ciò che fa sì che egli sia quel che è; è la parola di Dio che chiama l’uomo, che gli da l’esistenza. Tuttavia, tale parola è un’eco indistinta: in quanto la ode, l’uomo le è legato; in quanto non ne comprende il significato, l’uomo le è estraneo.
Questa è, press’a poco, l’immagine di Kafka scrittore. Scrivere per Kafka, è essere contemporaneamente prigionieri di questa parola ed estranei ad essa. Questo spiega perché, nei suoi diari, egli subisca oscillazioni così evidenti nella considerazione della propria opera. Solo in un’occasione egli fu pienamente cosciente di essere uno scrittore: accadde nella notte tra il 22 e il 23 settembre 1912, quand’egli scrisse La Condanna: «Non riuscivo quasi a ritirare di sotto la scrivania le gambe irrigidite dallo star seduto» annota egli stesso. «Sforzo spaventevole e gioia di veder svolgersi davanti a me la narrazione …».
A parte questo momento eccezionale, egli non fu mai confortato da una simile certezza: tuttavia nelle note degli anni ’12 – ’15 la letteratura occupa una parte importante nella sua considerazione: «Devo riconoscere in me un’ottima concentrazione nell’attività letteraria» (1912). «Dal punto di vista della letteratura, il mio destino è semplice… nient’altro potrà mai soddisfarmi» (6 agosto 1914).
Altre volte lo prende lo sconforto: «Non posso più continuare a scrivere. Sono arrivato al limite definitivo, davanti al quale devo forse restare di nuovo per anni, prima di poter ricominciare un nuovo racconto, che di nuovo resterà incompiuto. Questo destino mi perseguita» (30 novembre 1914).
Nel ’22, addirittura, gli accadrà di enumerare i progetti della sua vita per constatare altrettante sconfitte, e la letteratura viene posta sullo stesso piano del giardinaggio. Si noti che il ’22 rappresenta l’anno forse più intenso e ricco di tutta la produzione letteraria di Kafka: Il Castello, ad esempio, è di questo periodo.
«Da che cosa deriva questa differenza?» si domanda Maurice Blanchot, uno dei più acuti esegeti dell’opera di Kafka. «Dirlo sarebbe impadronirsi della vita interiore di un uomo infinitamente riservato, segreto persine ai suoi amici e d’altronde poco accessibile anche a se stesso. Nessuno può pretendere di ridurre ad un certo numero di affermazioni precise ciò che non poteva per lui giungere alla trasparenza di una parola comprensibile».
Verissimo. Anzi: forse questo è già uno dei motivi di tale oscillazione: l’impossibilità di giungere a detta trasparenza. Kafka lavora con una parola oscura, la cui essenza gli sfugge; tale parola sembra carica di significati, e lo è. Ma, per esserlo, deve mantenersi opaca. Le parole hanno un’origine, un senso, un luogo, un orizzonte, ma lo scrittore, pur legato ad essa dall’intuizione dalla verità che esse celano, tuttavia ne è estromesso, ne è al di fuori.
Così, da un lato la «tecnica» narrativa si sviluppa a dismisura (basti pensare all’incredibile capacità che ebbe Kafka di tradurre il concetto in gesto e in immagine, tantoché, persine in osservazioni apparentemente banali, può nascondersi una chiave interpretativa); d’altra parte, attraverso questa «tecnica», lo scrittore non fa che rendersi sempre più cosciente della propria lontananza dalla Parola vera, fino a scrivere Il Castello e, contemporaneamente, considerare la scrittura una sorta di tentativo maldestro, e nulla più.
 Man mano, infatti, che la scrittura si fa più rigorosa, si fa luce un’idea di insipienza, di banalità. Le parole appaiono stupide, oscillanti, come sono, tra la terribilità e l’insensatezza; soprattutto appaiono inutili, perché irraggiungibile appare il loro scopo.
Man mano, infatti, che la scrittura si fa più rigorosa, si fa luce un’idea di insipienza, di banalità. Le parole appaiono stupide, oscillanti, come sono, tra la terribilità e l’insensatezza; soprattutto appaiono inutili, perché irraggiungibile appare il loro scopo.
La cancellatura ha qualcosa a che vedere con questo senso di inutilità. I personaggi di Kafka vogliono raggiungere un certo obiettivo, ma, se non lo raggiungono, è anche perché sono incapaci di inquadrarlo, e questo rende la loro fatica mille volte più vana e più tremenda.
Lo stesso si potrebbe dire della scrittura Kafkiana — faticosa e tremenda, mastodontica eppure futile, fuorviante, labirintica e perciò mortale. Kafka cancellava, aboliva, sopprimeva per essere più essenziale, per meglio inquadrare il proprio obiettivo di scrittore. Ma proprio questo gli era impossibile, e proprio per questo, in fondo, percepì l’Opera essenziale di là da venire, e le sue opere come orribili frivolezze, stupide caricature di quell’opera.
D’altra parte, però, la cancellatura Kafkiana non equivale ad un annichilimento; egli non ridusse a nulla ciò che tolse, ma, appunto, lo tolse — lo mise da parte sanzionando la vera natura delle sue parole, le quali sono parole messe da parte, parole il cui luogo è «da parte».
Questo mi pare trasformi la cancellatura (linea tracciata «sopra» la parola) in sottolineatura (linea tracciata «sotto»), o, meglio, faccia vedere come il cancellare non fosse un movimento opposto allo scrivere, ma le due fossero, in realtà, una stessa cosa.
Non solo; questo mette in mostra un ulteriore aspetto: la sfiducia di Kafka rispetto alla propria opera, la sua convinzione di non essere scrittore — e, dunque la continua cancellatura — rivelano paradossalmente, la sua natura letteraria più profonda, e contribuiscono ancor di più alla sua definizione di scrittore. Chi crede di essere scrittore, infatti, indica, con questa stessa convinzione, la propria pochezza. Chi sa di non esserlo e perciò opera continue (e di per sé vane) sottrazioni, in realtà, così facendo, da un luogo alle parole
2. La questione ebraica
 Finora abbiamo descritto l’opera di Kafka così come si presenta sotto gli occhi. Abbiamo rilevato la concezione della parola — e della realtà stessa — che sta al fondo della sua letteratura. Resta da vedere perché le cose stiano così: perché, ad esempio, l’uomo viva una condizione tale quale Il Processo la descrive; perché lo scrittore intrattenga un simile rapporto con le parole — perché a Kafka lo scrivere apparisse immotivato quanto i tentativi dell’agrimensore K. di entrare nel Castello, e perché tanto Kafka quanto K. fossero condannati a tale insensatezza.
Finora abbiamo descritto l’opera di Kafka così come si presenta sotto gli occhi. Abbiamo rilevato la concezione della parola — e della realtà stessa — che sta al fondo della sua letteratura. Resta da vedere perché le cose stiano così: perché, ad esempio, l’uomo viva una condizione tale quale Il Processo la descrive; perché lo scrittore intrattenga un simile rapporto con le parole — perché a Kafka lo scrivere apparisse immotivato quanto i tentativi dell’agrimensore K. di entrare nel Castello, e perché tanto Kafka quanto K. fossero condannati a tale insensatezza.
Torniamo a questo proposito ad un tema poc’anzi accennato: quello della traduzione. Kafka, s’era detto, scrive traducendo, vale a dire trasponendo un determinato contenuto da una lingua originale ad un’altra lingua. Di questo lavoro, evidentemente, non ci sarebbe bisogno, se si fosse capaci di comprendere e di comunicare nella lingua originale, ossia di stabilire l’originario rapporto tra una cosa e la sua parola — di stabilire, in altri termini, il nome vero della cosa.
Ma dove le cose riacquistano il loro vero nome, il loro significato? E’ questa la domanda cui Kafka sa di non poter rispondere, ed è questo, dunque, il motivo per cui sostituisce la Parola vera con altre parole, altri suoni.
Molto interessante è l’inizio di un racconto poco noto (ritenuto da molti critici una semplice burla, una stramberia refrattaria a qualsiasi interpretazione), Il cruccio del padre di famiglia: «C’è chi dice che la parola Odradek derivi dallo slavo e cerca, in conseguenza, di spiegarne l’etimologia. Altri invece pensano che la parola provenga dal tedesco, e sia solo influenzata dallo slavo. L’incertezza delle sue interpretazioni consente, con ragione, di concludere che nessuna delle due da nel segno, tanto più che né coll’una né con l’altra si riesce a dare senso preciso alla parola». La parola sostituita entra a far parte del linguaggio umano, ma il suo significato rimane precluso.
«Naturalmente» prosegue il racconto «nessuno si darebbe la pena di studiare la questione, se un essere di nome Odradek non esistesse realmente» se cioè non esistesse la traccia, il presagio di un senso — per quanto insensato, quest’essere è infatti, «a suo modo, completo» e, comunque, esiste. Il fatto che sia «completo» indica, se non altro, che questa insensatezza è totale, e questo è già, in certo modo, un senso.
Entriamo, con queste considerazioni, che potrebbero apparire oziose, nel centro di tutto il nostro lavoro — del mio lavoro di scrivente come del tuo di lettore —: la cosiddetta «questione ebraica». Se Kafka traduce (ossia sostituisce, fittiziamente, uno dei due termini del rapporto), è perché è come se fosse assente un luogo sul quale sia possibile fondare un rapporto di verità tra le cose ed il loro significato, espresso dal nome (ogni scrittore, in quanto tale, si pone questo problema di verità — ed è questo che differenzia il poeta dal giornalista o dal politico che tiene un comizio elettorale).
«Dove abiti?» domanda qualcuno a Odradek. «Non ho fissa dimora», è la risposta, ovvia, perché, se avesse dimora, cesserebbe di essere insensato, e la sua fisionomia e il suo nome comparirebbero, si renderebbero manifesti — comparirebbe la lingua vera. Ma la lingua vera è nascosta, la parola vera è impronunciabile. (Di qui si potrebbe trarre la conclusione che essa non esiste, ma sarebbe una conclusione arbitraria, visto che, se non esistesse, non esisterebbero scrittori e poeti, ma solo tecnici legati alla lingua da un rapporto puramente convenzionale).
Ora, l’Ebraismo consiste appunto nell’impronunciabilità della parola vera — prego il lettore di non spaventarsi! Le considerazioni che seguono renderanno comprensibile questa affermazione. Tali considerazioni, tese a rispondere alla domanda «Che cos’è l’Ebraismo?» debbono tener conto di un duplice ordine di problemi: da un lato la Parola di Dio — l’Antico Testamento —, sulla quale la civiltà ebraica si fonda; dall’altro la Diaspora, la disgregazione del popolo d’Israele.
 Per quanto riguarda il primo ordine di problemi, metto da subito le mani avanti — e così farò anche per il secondo —: non è mia intenzione, né ne avrei la capacità, di fare l’esegeta biblico. Quel che mi propongo di fare è mettere in luce alcuni caratteri dell’ebraismo, così come emergono dal rapporto tra Dio e il suo popolo, descritto nelle Sacre Scritture.
Per quanto riguarda il primo ordine di problemi, metto da subito le mani avanti — e così farò anche per il secondo —: non è mia intenzione, né ne avrei la capacità, di fare l’esegeta biblico. Quel che mi propongo di fare è mettere in luce alcuni caratteri dell’ebraismo, così come emergono dal rapporto tra Dio e il suo popolo, descritto nelle Sacre Scritture.
La prima osservazione potrebbe essere questa: l’Ebreo non si muove in un mondo di oggetti già definiti da un valore che è loro proprio. E’, questa, una tendenza spiccatamente ellenica: senza volerci addentrare in un problema filosofico così importante (anzi: il più importante) e, anzi, volendo rimanere sul piano strettamente «culturale», si deve notare che la domanda sull’essenza (ciò per cui una cosa è quella che è e non altro; ciò per cui un libro è uri libro e non un tavolo) e, di conseguenza, la figura del sapiente come di colui che conosce, o cerca di conoscere, l’essenza delle cose, entrano in ambiente ebraico relativamente tardi.
Si potrebbe dire, addirittura, che l’Ebreo è ebreo proprio perché sottratto a questo mondo di essenze e di valori. Si tenga presente, ad esempio, la chiamata di Abramo, con la quale ha inizio la storia di Israele.
«Abramo!».
«Eccomi».
In questo dialogo, Abramo non viene trasposto da un luogo all’altro, al vecchio mondo di valori non se ne sostituisce uno nuovo. Molto più radicalmente, infatti, questo dialogo trae l’uomo dal nulla. «Abramo!», la chiamata, è ciò attraverso cui questa creazione avviene. Il nome «Abramo» è il nome dell’essere creato. «Eccomi», la risposta, è il riconoscimento, la coscienza della creaturalità. In altri termini, è possibile dire che ciò che da il nome all’uomo — e poi a tutte le cose — è un rapporto, un dialogo creatore-creatura. Il nome è nome di questo dialogo.
Ora, questa osservazione (su cui metterebbe conto di soffermarsi per molte pagine) può aiutarci a comprendere la differenza — una delle differenze — tra il nome ebraico e il «concetto» ellenico. La differenza è questa: che il concetto ellenico è concetto di una essenza (v. sopra), vale a dire è una parola con la quale si designa qualcosa nella sua specificità, nel suo «esser-ciò-che-é-e-non-altro»; ad esempio, il concetto di «uomo» indica un essere appartenente al regno animale e, in più, dotato di ragione, per cui l’essere animale razionale è ciò che costituisce il concetto di «uomo» ed è ciò che fa sì che l’uomo sia uomo e non albero, o Icone, o tavolo; il nome ebraico, invece, designa sì ciò che una cosa è, ma questo essere, a sua volta, è fondato e, per così dire, nascosto, nel Dialogo di cui parlavo poc’anzi.
Il nome «Abramo» non definisce tanto i caratteri «interni» del personaggio in questione, quanto assai più profondamente, la sua creaturalità.
In parole povere, mentre per i Greci il senso delle cose risiede (almeno inizialmente) nelle cose stesse, per l’Ebreo il senso delle cose risiede in Dio, ogni cosa — e innanzitutto l’uomo, che sarà poi concreatore — acquista il proprio nome nel momento in cui riconosce il proprio esser-creato, il proprio esser fondato in un dialogo.
Anzi, questo riconoscimento è il compito specifico dell’uomo, il quale parteciperà poi alla creazione, così ci insegnano le sacre scritture, dando alle cose il loro nome, la parola, cioè, che le designa in quanto create. La differenza tra l’uomo e tutte le altre creature è che l’uomo ha in sé la coscienza di essere creato, mentre le cose non l’hanno in sé, e perciò debbono ricevere il nome da chi di tale coscienza è in possesso.
Tuttavia il nome che l’uomo da alle cose può significare solo questo, che esse sono create, né può stabilire che cosa esse siano in se stesse, poiché la loro essenza è nascosta in Dio, è tratta verso Dio. L’uomo stesso, innanzitutto, è tratto in questo vortice («Noi siamo un dialogo» dice Holderlin), la sua essenza gli è radicalmente sottratta. La condizione umana è «stare in faccia all’Insondabile », al Mistero.
Non è una condizione di armonia, di familiarità: infatti, con il Peccato Originale, l’uomo è stato cacciato dal Paradiso, Dio appare terribile e il peso della vita terrena è il peso della Sua ira. «Perché siamo travolti dalla Tua ira, siamo atterriti dal Tuo furore» (Ps. 89). Il contenuto dell’esistenza è la chiamata di Dio, eppure, al tempo stesso, il peccato getta Dio nella lontananza; in moltissimi testi biblici è narrata l’esperienza di questa separazione, primo fra tutti, come è ovvio, il racconto della Passione del Signore (Cfr. Hans Urs von Balthasar, Nuovo Patto, in Gloria, ed. Jaca Book).
Questa contraddizione in cui vive il popolo d’Israele potrà essere sanata solo con l’Avvento di Gesù Cristo, il quale opererà la Riconciliazione, creando per l’uomo la possibilità di iniziare a vivere, da subito, la pienezza della propria vocazione. Cristo, in altri termini, rivela l’uomo all’uomo stesso, come dice il Papa. Senza questa Rivelazione, il significato rimane invece nascosto, e la parola non ha corpo, in quanto le è sottratta la dimensione del legame con la cosa. La parola esprime un senso, un’«essenza» che chi parla non è in grado di misurare.
 Veniamo ora al secondo grande tema, che è quello della Diaspora. La parola «diaspora» significa «dispersione», e la si usa generalmente per indicare la sorte del popolo ebraico dopo l’entrata in Gerusalemme e la distruzione del Tempio da parte dell’imperatore Tito (79 d.C.). A partire da tale data, gli Ebrei si dispersero — lasciarono, cioè le loro sedi d’origine e cominciarono a vagare per il mondo.
Veniamo ora al secondo grande tema, che è quello della Diaspora. La parola «diaspora» significa «dispersione», e la si usa generalmente per indicare la sorte del popolo ebraico dopo l’entrata in Gerusalemme e la distruzione del Tempio da parte dell’imperatore Tito (79 d.C.). A partire da tale data, gli Ebrei si dispersero — lasciarono, cioè le loro sedi d’origine e cominciarono a vagare per il mondo.
La cosa che maggiormente sorprende il profano è che tanti secoli di peregrinazioni (che l’istituzione, nell’ultimo dopoguerra, di uno Stato d’Israele, non ha fatto cessare) non hanno modificato sostanzialmente l’identità di questo popolo; gli Ebrei, cioè, una volta dispersi, non si confusero con gli altri popoli, ma mantennero viva, in ogni circostanza, la loro specificità etnica, culturale e religiosa — tre termini, questi, che nel caso degli Ebrei significavano press’a poco la stessa cosa.
Le strutture fondamentali della vita nella diaspora furono la comunità, che s’insediava in luoghi precisi all’interno di una città (Ghetti), e il tribunale rabbinico, che stava a capo alla comunità e che era presieduto dal rabbino, il quale aveva (ed ha) il compito di dirimere ogni questione, fisica o spirituale che fosse, che sorgesse all’interno della comunità: dai matrimoni ai litigi per questioni d’interesse, dalle rappacificazioni tra fidanzati che avevano litigato a questioni concernenti la macellazione delle carni. (Si legga, in proposito, il mirabile volume Alla corte di mio padre di Isaac Bashevis Singer, edito in Italia da Longanesi).
Dopo le purghe naziste e l’ondata di antisemitismo sorta nella prima metà del nostro secolo, le comunità ebraiche sono pressoché scomparse dall’Europa; ne rimangono molte, invece, negli Stati Uniti.
A questa struttura basilare si aggiungono i numerosi movimenti interni di carattere mistico-spirituale, volti a rinnovare e a ridar freschezza alla tradizione: tale è, ad esempio, il movimento chassidico. Funzione dei movimenti spirituali, così come della teologia mistica (la Gabbala), era un continuo approfondimento delle verità fondamentali, espresse dalla parola di Dio e dalla legge (Torà).
Queste osservazioni possono forse far comprendere il motivo dell’incredibile forza con cui l’identità ebraica si mantenne viva attraverso i secoli: essere ebreo non è solo un fatto di nascita e non è nemmeno il frutto di un rituale; essere ebreo è un compito che, con la nascita e con determinati rituali — qual è, ad esempio, la circoncisione —, si inscrive nella persona, ma che è dovere della persona mantenere.
Ne è testimonianza un episodio narrato nei Racconti dei Chassidim di Martin Buber: «Lo Jehudi disse una volta: «Essere un taumaturgo non è gran cosa; un uomo che ha raggiunto un grado spirituale può capovolgere cielo e terra; ma essere un ebreo è difficile!». Comunità, tribunali rabbinici, movimenti spirituali, Gabbala, ecc., tutto esiste in vista del compito supremo: essere Ebrei — compito che richiede la libertà e la fatica personali, cui nessun tribunale può sostituirsi.
Potremmo definire la Diaspora come la traduzione fisica dell’ebraismo, la sua manifestazione più evidente. Essa esprime fisicamente quella lontananza che il peccato originale e la rottura dell’Antica Alleanza rappresentavano nelle epoche precedenti l’invasione di Tito. La lontananza da Dio viene simbolicamente rappresentata dalle peregrinazioni di questo popolo lontano da Sion, ove il Tempio — luogo della presenza di Dio — attende di essere ricostruito.
Con la Diaspora, quella che era una condizione esistenziale (il Peccato originale) diviene il contenuto della vita, il contenuto del pane e del lavoro, della nascita e della morte. La Gerusalemme perduta diviene il centro gravitazionale dell’esistenza, e tutta l’esistenza si fa, a sua volta, simbolo di quella distanza.
L’Ebreo è totalmente immerso in una concezione simbolica della vita. Ogni gesto, per quanto profano, non può avere senso se non in rapporto con Sion; il corpo stesso, con le sue funzioni, è simbolo di Altro, è luogo del rapporto con Dio — un Dio perduto eppure presente, lontano eppure sempre riconosciuto come consistenza di tutto —, e fuori da questo rapporto è nulla, è pura apparenza.
Caratteristica lampante di questa concezione simbolica della vita è, senza dubbio, l’idea di «tempo», così com’è espressa nella cultura ebraica. Se l’Ebreo è colui che riconosce il proprio fondamento nel dialogo con Dio, nella Chiamata che trae le cose dal nulla; e se, d’altra parte, questo dialogo è stato interrotto con il Peccato originale al punto da gettare Dio nella totale oscurità, nel totale nascondimento; se, dunque, essere Ebreo (il compito della vita) è mantenere desta la memoria del proprio fondamento; ne consegue che l’esistenza nel tempo è concepita come attesa — attesa del ritorno alla presenza di Dio, che non è solo ritorno a Sion (come una certa corrente del sionismo pensava), ma che è attesa della Nuova Alleanza, della venuta del Messia, di cui parlano i Profeti.
Si può dire che ciò che mantiene viva l’ebraicità è questa immagine della vita nel tempo; ogni Ebreo, in fondo, è profeta, poiché la sua esistenza è definita dall’attesa ed è proiettata, perciò, nel futuro; come Abramo, egli vive sulla promessa del prossimo evento del Messia, del Redentore, di Colui che finalmente rivelerà Dio agli uomini, restituendo loro la piena conoscenza delle cose — il loro. «nome», cioè, sarà aperto, chiaro, e non più chiuso come un riccio sopra il mistero; esso manifesterà la pienezza di ogni cosa, non la occulterà più.
Alla fine di questa lunga panoramica ci è possibile chiarire quel che, a proposito di Kafka, avevamo lasciato in sospeso. Perché, dunque, il modo di scrivere di Kafka è spiegabile solo attraverso un’analisi della cosiddetta «Questione ebraica»? La risposta (o, forse, un inizio di risposta) è questa, che l’ebraismo consiste nell’attesa che la realtà delle cose e delle parole si manifesti; essere Ebrei è stare sull’orlo di un abisso buio — anzi: è esser dentro questo abisso, e attendere che una luce lo illumini.
Tutte le cose sono come tratte in un gorgo, e le parole, nelle quali è racchiuso il mistero stesso della Creazione, sono dure come pietre, impenetrabili. Da tramiti della presenza divina, esse si sono trasformate in intercapedini, ostacoli. La lingua vera — quella attraverso cui era comunicabile la verità del creato — si è perduta, della parola vera non rimangono che residui, indefinitamente storpiati, abbrutiti, smangiati.
Questo è, appunto, la parola Kafkiana: parola residua, insensata, con la quale si tenta incessantemente di tradurre un significato che è sottratto, che è nascosto (di qui l’impressione, di cui parlavo all’inizio, che dietro ogni parola di Kafka si celino significati nascosti, misteriosi — ed è vero: si celano «dietro », appunto perché la parola li nasconde); parola senza fissa dimora, come Odradek, eppure ostica, dura come lo stesso Odradek, il quale «se ne sta silenzioso come il legno di cui sembra fatto».
3. Il corpo
Quanto s’è detto va ora spiegato e mostrato «in azione» nell’opera di Kafka. Non solo: occorre fare un passo molto importante. Fin qui è come se si fosse detto: «II modo di far letteratura in Kafka deriva dall’Ebraismo». In realtà, però, non «deriva», bensì E’. Kafka, cioè, non deduce il suo modo di scrivere a partire dalla questione ebraica. Molto più profondamente, la sua scrittura coincide con la questione ebraica stessa. Vediamo ora perché.
Per ottenere lo scopo, prenderò brevemente in esame l’esperienza mistica, così come si presenta nel mondo ebraico. Prima, però, è forse utile riassumere brevissimamente quanto sono venuto dicendo fin qui sul tema dell’Ebraismo: per l’Ebreo, la parola è il nome della creatura; il nome, cioè, rivela la cosa come creata da Dio, tratta dal nulla all’Essere dalla Potenza di Dio. L’uomo è il luogo in cui questa creaturalità si fa coscienza; l’io è la risposta ad un «Tu» creatore (non è un caso che la filosofia del più «ebreo» tra i filosofi ebrei del nostro secolo, Martin Buber, sia denominata «La filosofia del Tu»).
 Al tempo stesso, però. Dio si è allontanato dall’uomo a causa del Peccato Originale, Egli è adirato con il suo popolo. Ciò naturalmente rischierebbe di far cadere il popolo nella disperazione e nell’anonimato, se non sorgessero i profeti (dal greco «pro-femì», «parlare innanzi») a leggere nella storia del popolo i segni della Presenza di Dio. Dio è fedele al suo popolo ed invierà il Messia, il quale ristabilirà l’Alleanza.
Al tempo stesso, però. Dio si è allontanato dall’uomo a causa del Peccato Originale, Egli è adirato con il suo popolo. Ciò naturalmente rischierebbe di far cadere il popolo nella disperazione e nell’anonimato, se non sorgessero i profeti (dal greco «pro-femì», «parlare innanzi») a leggere nella storia del popolo i segni della Presenza di Dio. Dio è fedele al suo popolo ed invierà il Messia, il quale ristabilirà l’Alleanza.
La fedeltà al Signore è, per l’Ebreo pio, la fedeltà ad un Evento situato nel futuro — ho dimenticato di dire che la credenza nella sopravvivenza dell’anima dopo la morte è estranea al mondo ebraico —; mentre il presente è, come dice Claudio Magris, «esilio…, simbolo dell’esilio umano in generale (io, però, non generalizzerei), e dice la scissione, la lacerazione, la schizofrenia, la negatività e il nulla dell’esilio…».
L’esperienza religiosa, per l’Ebreo, consiste, dunque, nel ricordo delle meraviglie compiute da Dio, in passato da una parte, e dall’altra nell’attesa della venuta del Messia. Il presente è totalmente assorbito da questi due poli. Ora, il misticismo — questo, se si eccettua, per alcuni aspetti, il Cristianesimo, è un dato comune a quasi tutte le grandi Religioni — consiste grosso modo, nel movimento opposto, per il quale, dunque, passato e futuro saranno riassorbiti nell’esperienza presente.
Si tratta di un’esperienza religiosa un po’ eccezionale, assolutamente fuori dalla norma eppure, contemporaneamente, radicata nella tradizione (si veda, a questo proposito, il bel volume La Kabbalah e il suo simbolismo di Gershom Scholem, Einaudi, 1980).
Nell’ambito di una religione profondamente «disarmonica» qual è quella ebraica, l’esistenza di una profonda tradizione mistica potrebbe addirittura apparire contraddittoria: la religione ebraica è, sostanzialmente, una religione della lontananza da Dio, una religione dell’esilio, mentre il misticismo esprime, essenzialmente, una prossimità e, nel suo grado più elevato — la cosiddetta «estasi mistica» —, addirittura una sorta di «contatto fisico» (l’espressione è tutt’altro che esatta, ma, d’altra parte, non c’è di meglio: ogni definizione, a questo livello la cui essenza è nascosta nell’Ineffabile, può essere soltanto simbolica).
Eppure, la distanza — che, indubbiamente, esiste, tanto che in ogni tempo si verificarono screzi tra mistici e autorità religiosa — non impedisce di rilevare alcuni punti in comune — mi limiterò, com’è naturale, a quelli che interessano la letteratura Kafkiana.
Se ci domandiamo in cosa consista l’esperienza mistica, e la mistica ebraica in special modo, la nostra risposta non dovrà comunque dimenticare un punto molto importante, che è il rapporto con i Testi Sacri: il mistico, cioè, è una persona che, attraverso il personale rapporto con la Divinità, riscopre nelle Sacre Scritture nuovi «strati di senso», in parole povere: nuovi significati. Il misticismo è, in altri termini, una sorta di chiave atta ad aprire lo scrigno della parola.
Riporto, a titolo di esempio, un bellissimo passo del libro di Scholem sopra citato: «Nel suo commento ai Salmi, Origene racconta che un dotto ebreo, probabilmente un membro dell’accademia rabbinica di Cesarea, gli ha detto che le Sacre Scritture sono come una grande casa con molte, moltissime stanze, e davanti ad ogni stanza c’è una chiave — ma non è quella giusta.
Le chiavi di tutte le stanze sono cambiate e confuse: trovare le chiavi giuste che aprono le porte è il compito grande e difficile insieme», il compito, appunto, della mistica. Non occorre un ingegno d’aquila per scorgere, in questa similitudine, un’analogia con tanta parte dell’opera Kafkiana. Ora, le considerazioni che seguono non vogliono tanto mostrare le ragioni di tale analogia, quanto far vedere che analogia non è, bensì, piuttosto, identità.
Se si eccettua la mistica cristiana — che è, anzitutto, la partecipazione all’esperienza mistica di Cristo —, ogni esperienza mistica (e in special modo quella sorta in seno all’ebraismo, dove Ciò che è assente è Ciò che fa la peculiarità del cristianesimo) ha un preciso limite. Tanto per cominciare, per quanto rivoluzionaria possa essere, un’esperienza non potrà mai stravolgere del tutto il senso delle Sacre Scritture, se non a patto di cadere nell’eresia; potrà, al massimo, modificare di molto l’interpretazione di un passo, o fornire una chiave di lettura «accanto» ad altre possibili chiavi.
 La mistica, di conseguenza, non potendo invertire la struttura della religione in cui s’iscrive, né tanto meno i testi sui quali tale religione si fonda, non potrà neppure avere una percezione del proprio oggetto (Dio) opposta o, comunque, molto diversa rispetto a quella della religione. Questa osseryazione si accorda con le tendenze dell’ebraismo e, insieme, della mistica ebraica. La mistica è un’esperienza «a forma di scala ascendente», tanto per esprimerci con un’immagine; l’estasi rappresenta il gradino supremo.
La mistica, di conseguenza, non potendo invertire la struttura della religione in cui s’iscrive, né tanto meno i testi sui quali tale religione si fonda, non potrà neppure avere una percezione del proprio oggetto (Dio) opposta o, comunque, molto diversa rispetto a quella della religione. Questa osseryazione si accorda con le tendenze dell’ebraismo e, insieme, della mistica ebraica. La mistica è un’esperienza «a forma di scala ascendente», tanto per esprimerci con un’immagine; l’estasi rappresenta il gradino supremo.
Nella mistica ebraica (sulle altre sono poco informato), l’estasi non corrisponde ad un contatto con la Divinità; tale contatto non è possibile, infatti, se non a livello simbolico: nella scala che conduce all’estasi, il mistico risale i diversi gradini della creazione, ed entra in contatto con le «emanazioni divine», con gli «attributi divini» — che sarebbero, filosoficamente parlando, le qualità che competono all’Essenza divina (Eternità, Infinitudine, Semplicità, ecc….); il mistico, in altri termini, potrà fare esperienza dei diversi «aspetti» sotto i quali si presenta la Divinità — la cui Natura profonda rimarrà, comunque, nascosta.
L’esperienza mistica è un fatto sensibile, non intellettuale, eppure (in analogia con l’esperienza intellettuale); essa esprime un contatto con un mondo simbolico — persino il mondo dei numeri fu oggetto, negli ambienti pitagorici (VI – VII sec. a.C.), di qualcosa di simile ad un’esperienza mistica.
In quanto sensibile, è un fatto Corporale, legato al nostro corpo. Non per nulla tra le pratiche per raggiungere l’estasi i digiuni avevano tanta importanza; tra l’altro il termine «ascesi» ha un significato non lontanissimo da «ginnastica». Ne deriva che il corpo si riveste di un significato simbolico, che non solo da ogni parola, ma da ogni gesto, da tutte le membra dovrà trasparire la presenza Divina. Il santo dovrà testimoniare attraverso tutto il proprio essere: «II sapore che sentite del pane non è ancora il vero sapore del pane», dice un aneddoto chassidico, riportato da Buber.
«Solo gli Zaddikim (i maestri delle comunità chassidiche, n.d.r.), che hanno purificato tutte le loro membra, gustano il vero sapore del pane, come Dio l’ha creato».
Queste parole ci aiutano ad individuare meglio il limite del misticismo, la sua contraddizione interna; da un lato, infatti, il corpo perviene alla percezione del vero significato delle cose, al loro rapporto con Dio — e questa è, in qualche modo, una esperienza messianica; dall’altro lato, però, questa esperienza è relegata in un corpo mortale, nel corpo di un uomo che non è il Messia e che potrà vivere «meglio» dentro le contraddizioni della vita, ma non potrà in alcun modo vivere da «redento».
L’uomo continua ad essere solo, poiché la possibilità di entrare in contatto con Dio è lasciata alle sue sole forze. Una situazione messianica si avrebbe realmente se l’estasi mistica coincidesse con la vita quotidiana, se, cioè, la vita non fosse una «traduzione», ma si identificasse con l’estasi. Ma questo è possibile se la vita è Già redenta, se già una Grazia ha avuto luogo, se il significato del corpo mortale fosse già presente.
Invece, nella mistica ebraica, si parte da una condizione di non-redenzione e si cerca, attraverso precise tecniche, di ristabilire il contatto tra le cose ed il loro significato. Il corpo caduco sarebbe il luogo dell’Alleanza ristabilita; in realtà, le cose non stanno affatto così: il corpo può essere, semmai, profezia, simbolo, ma non luogo di un avvenimento.
Il corpo non è la presenza di un significato; semmai, simboleggiando tale significato, esso ne mostrerà l’assenza: essere simbolo di qualche cosa vuoi dire sostituirsi a qualcosa che non è presente, poiché se la cosa fosse presente non ci sarebbe più alcun bisogno di simboli. Il corpo è, dunque, una traduzione e — nel momento in cui ascriva a sé la presenza del significato — una mistificazione (si noti che «mistificare», «mistico e «mistero» hanno la stessa radice).
Se ho speso molte parole sul misticismo, è perché mi sembra che considerazioni come queste servano ad illustrare la letteratura Kafkiana, la sua conformazione, il suo senso. Quella di Kafka è, infatti, per molti aspetti, un’esperienza mistica — diversa, forse, nei particolari e nell’ordine degli elementi, rispetto alla mistica tradizionale, ma identica a questa nella struttura.
La letteratura è, per Kafka, una variante del misticismo; come Ebreo, Kafka si trova nella condizione di un uomo cui il significato delle parole è stato sottratto. Gli stessi Testi Sacri sono, sì, Parola di Dio, ma la comprensione piena di questa Parola è tolta all’uomo. Come i mistici, egli compie un’esperienza simbolica, e perviene all’individuazione di diversi «strati (o livelli) di senso» all’interno della parola. Come i mistici, infine, egli compie un’esperienza fisica, un’esperienza cioè, il cui centro è il corpo.
La conseguenza è pressoché matematica: sviscerando la parola e i suoi livelli simbolici, Kafka non può fare a meno di sperimentare l’Assenza del significato originario, l’assenza di un centro gravitazionale. Ciò che manca è il corpo della parola, e questo determina ciò che dissi nel capitolo precedente, ossia che lo scrittore è costretto a «tradurre» (allo stesso modo, potremmo dire che il contatto del mistico con gli «attributi divini» non è il contatto con l’Essenza di Dio, ma con una sorta di «traduzione» di quest’Essenza — e la traduzione è sempre una sostituzione, una parola che sta al posto di un’altra parola e perciò indica l’assenza di questa parola…).
 La parola Kafkiana è, insomma, un nascondimento dell’essere, e non una sua rivelazione, e il rapporto mistico con essa non fa che scoprire, in tutta la sua enormità, l’abisso di questo nascondimento; parola dura, dunque, e, ad un tempo, evanescente: dura perché impedisce di cogliere il significato creaturale che sta al di sotto, evanescente perché essa stessa è separata, strappata da tale significato. Anche qui, come nel misticismo tradizionale, la parola troverà nel corpo il suo luogo simbolico — profetico, se vogliamo, ma non reale.
La parola Kafkiana è, insomma, un nascondimento dell’essere, e non una sua rivelazione, e il rapporto mistico con essa non fa che scoprire, in tutta la sua enormità, l’abisso di questo nascondimento; parola dura, dunque, e, ad un tempo, evanescente: dura perché impedisce di cogliere il significato creaturale che sta al di sotto, evanescente perché essa stessa è separata, strappata da tale significato. Anche qui, come nel misticismo tradizionale, la parola troverà nel corpo il suo luogo simbolico — profetico, se vogliamo, ma non reale.
E’ il corpo che fa l’esperienza mistica, al corpo questa esperienza si indirizzerà. Il racconto Kafkiano — in strettissima analogia con il racconto chassidico (cfr. Martin Buber, Racconti dei Chassidim, Garzanti 1979) — è, perciò, racconto del corpo (questa mi pare, ad esempio, una legittima chiave di lettura de La Metamorfosi — racconto che ripete, sostanzialmente, il processo parola-corpo or ora tratteggiato).
Si notino, ad esempio, le descrizioni dei corpi, le loro posizioni; si tratta sempre di stati che «traducono» pensieri, percezioni: tenere, ad esempio, i gomiti appoggiati al tavolo ha un certo significato «X» — significato di cui l’autore non parlerà, limitando si a descrivere i gomiti appoggiati al tavolo, e nient’altro.
Esistono testi, però, in cui è possibile sorprendere questo atteggiamento. Prendiamo, ad esempio, il finale del racconto Risoluzioni, del 1912: «… Perciò la miglior soluzione è di accettare tutto, contenersi come una massa pesante, e, anche se ci si sente come soffiati via, non lasciarsi trascinare a compiere un passo non necessario, guardare il prossimo con occhio animalesco, non provar pentimenti, insomma soffocare con la propria mano quel che ancora resta della vita come fantasma, e cioè aumentare ancora l’ultima pace sepolcrale e non lasciar sussistere nient’altro. Un movimento caratteristico di un simile stato d’animo è il passarsi il mignolo sulle sopracciglia».
Dai mignoli sulle sopracciglia, il salto in alcuni tra i simboli più profondi della mitologia ebraica è relativamente breve; contrariamente (stavolta) al chassidismo — dove un ambito fortemente sensibile alla religione tradizionale si fa sapiente traduttore di questa presso gli adepti —, che innalza il corpo, Kafka lo degrada. Il corpo è simbolo, ma è anche inganno, mistificazione, trafugamento.
Si considerino, a titolo esemplificativo, le donne Kafkiane (Leni de Il Processo, o Frieda de Il Castello), tutte piccole, mai belle, quasi animalesche: non è la bellezza dell’anima a risplendere nella bellezza del corpo; esse sono strani oggetti erotici, si comportano come bestie. Si legga la famosa sequenza del coito tra K. e Frieda nella birreria, ne Il Castello: la prima cosa che colpisce è la totale assenza, in questa descrizione, di timbri «umani». Tutto è ferino; la donna è un animale. Esistono, poi, gli animali veri e propri (vedasi La Metamorfosi), per cui questo discorso è, a maggior ragione, ripetibile.
Sono, insomma, gli accenti mistificatori, quelli su cui Kafka insiste. Anche gli atteggiamenti più apparentemente ingenui dei suoi personaggi devono tenere all’erta. Saltare non è più saltare, stringere la mano non è più stringere la mano, amare non è più amare. Il corpo è inganno, nascondimento: occorre diffidare di esso.
Quanto all’amore, una volta accertata l’assenza del significato — ma diciamo pure: l’assenza del Padre —, esso potrà ridursi solo ad un diabolico, illusorio intreccio di corpi. Il corpo, insomma, non è il luogo della riconciliazione delle parole con il loro significato più profondo, ma il luogo sostitutivo di una redenzione ancora di là da venire. Se ho tanto insistito su questo punto, e sull’ebraismo in generale, tralasciando molti altri aspetti (ad esempio la questione psicanalitica, così come emerge in maniera netta nella Lettera al padre), è perché questo mi sembra il punto-chiave.
La letteratura Kafkiana, nella sua intima connessione con tutta la civiltà ebraica, ha, quale tema principale, lo smarrimento del legame col Padre, la rottura dell’Antica Alleanza; di questa rottura, che fa le parole opache, impedendo loro di spalancarsi sul significato che racchiudono in sé, è residuo il corpo, luogo di una fittizia riconciliazione, spoglia mortale, posseduta dalla morte — denuncia dell’assenza del Padre e, a un tempo, scimmiottamento grottesco del Padre stesso. Quella che Kafka descrive è, esattamente, l’umanità privata di Cristo — privata, cioè, della conoscenza del Disegno che da un luogo a tutte le cose e che, anzi, grazie alla nostra adesione, ha già cominciato quest’opera di riconciliazione.
Solo nella partecipazione al Corpo Mistico del Signore è possibile un’esperienza mistica sottratta alla dualità prima descritta: è Dio, infatti, che, per mezzo di Cristo, ci ha dato il potere di essere «suoi famigliari e concittadini dei santi». Senza questa partecipazione, l’uomo è impotente a penetrare nella casa della legge (che è, a un tempo, la legge dei codici, la legge della Torà e la legge della vita): la porta è stata preparata apposta per lui, ma lui non riceverà mai il permesso di entrare.
Come il racconto Davanti alla legge, qui riportato, fa capire, l’uomo potrebbe forse tentare ugualmente di entrare, nonostante il divieto. Ma il guardiano lo minaccia «Se ne hai tanta voglia, prova pure ad entrare … Bada, però: io sono potente, e sono soltanto l’infimo dei guardiani. Davanti ad ogni sala sta un guardiano, uno più potente dell’altro. Già la vista de! terzo non riesco a sopportarla nemmeno io».
La forza di un uomo, in altri termini, è irrisoria perché si possa solo immaginare di passare la porta della legge — o la porta della parola, se vogliamo. Quel che occorre è il permesso, e questo permesso deve venire dall’interno della legge stessa; non può in alcun modo — contrariamente a quanto ritiene ogni misticismo non cristiano — venire dall’uomo, poiché è proprio l’uomo a dover essere salvato — sono le nostre ineluttabili domande ad aver bisogno di una risposta.
____________________________________________________________________________
II prossimo villaggio (1916-1917)
Mio nonno soleva dire: «La vita è straordinariamente corta. Ora, nel ricordo, mi si contrae a tal punto che, per esempio, non riesco quasi a comprendere come un giovane possa decidersi ad andare a cavallo sino al prossimo villaggio senza temere (prescindendo da una disgrazia) che perfino lo spazio di tempo, in cui si svolge felicemente e comunemente una vita, possa bastar anche lontanamente a una simile cavalcata»
___________________________________________________________________________
II cruccio del padre di famiglia (1917)
C’è chi dice che la parola Odradek derivi dallo slavo e cerca, in conseguenza, di spiegarne l’etimologia. Altri invece pensano che la parola provenga dal tedesco, e sia solo influenzata dallo slavo. L’incertezza delle due interpretazion! consente, con ragione, di concludere che nessuna delle due da nel segno, tanto più che né coll’una né coll’altra si riesce a dare un senso preciso alla parola.
Naturalmente nessuno si darebbe la pena di studiare la questione, se non esistesse davvero un essere che si chiama Odradek. Sembra, dapprima, una specie di rocchetto da refe piatto, a forma di stella, e infatti par rivestito di filo; si tratta però soltanto di frammenti, sfilacciati, vecchi, annodati, ma anche ingarbugliati fra di loro e di qualità e colore più diversi. Non è soltanto un rocchetto, perché dal centro della stella sporge in fuori e di traverso una bacchettina, a cui se ne aggiunge poi ad angolo retto un’altra. Per mezzo di quest’ultima, da una parte, e di uno de! raggi della stella dall’altra, quest’arnese riesce a stare in piedi, come su due gambe.
Si sarebbe tentati di credere che quest’oggetto abbia avuto un tempo una qualche forma razionale e che ora si sia rotto. Ma non sembra che sia così; almeno non se ne ha alcun indizio; in nessun punto si vedono aggiunte o rotture, che dian appiglio a una simile supposizione; l’insieme appare privo di senso ma, a suo modo, completo. E non c’è del resto da aggiungere qualche notizia più precisa, poiché l’Odradek è mobilissimo e non si lascia prendere.
Si trattiene a volta a volta nei solai, per le scale, nei corridoi o nell’atrio. A volte scompare per mesi interi; probabilmente si è trasferito in altre case; ma ritorna poi infallibilmente in casa nostra. A volte, uscendo di casa, a vederlo così appoggiato alla ringhiera delta scala, viene voglia di rivolgergli la parola. Naturalmente non gli si possono rivolgere domande difficili, lo si tratta piuttosto — e la sua minuscola consistenza ci spinge da sola a farlo — come un bambino. «Come ti chiami?» gli sì chiede. «Odradek» risponde lui. «E dove abiti?». «Non ho fissa dimora» dice allora ridendo; ma è una risata come la può emetter solo un essere privo di polmoni. E’ un suono simile al frusciar di foglie cadute. E qui la conversazione di solito è finita. Del resto anche queste risposte non sempre si ottengono; spesso se ne sta a lungo silenzioso, come il legno di cui sembra fatto.
E mi domando invano cosa avverrà di lui. Può morire? Tutto quel che muore ha avuto una volta una specie di meta, di attività e in conseguenza di ciò si è logorato; ma non è questo il caso di Odradek. Potrebbe dunque darsi che un giorno ruzzolasse ancora per le scale, trascinandosi dietro quei fili, fra i piedi dei miei figli e dei figli dei miei figli? Certo non nuoce a nessuno; ma l’idea ch’egli possa anche sopravvivermi quasi mi addolora.
___________________________________________________________________________
La sua vita
«La logica della legge è incrollabile, ma non resiste ad un uomo che vuole vivere».
E’, forse, possibile dire che la vita di Kafka è un aspetto della sua opera. La storia di questo boemo di Praga, nato il 3 luglio 1883 e morto un mese esatto prima di compiere quarantun anni non ci interesserebbe molto, forse, se non proponesse i temi che già l’esame della sua opera ha messi in luce — e su questo torneremo fra poco.
Il mondo in cui Kafka vive (Praga e non solo Praga: la grave malattia, che lo colpì ancor giovane e che avrebbe dovuto condurlo alla tomba, lo costrinse a numerosi spostamenti) è quello che gravita attorno alla Vienna di Cecco Beppe; se l’Impero agonizza, è proprio in questo momento che fiorisce la grande cultura che oggi si suoi chiamare «mitteleuropea». Basteranno alcuni nomi: Freud, Mahler, Shonberg, Berg, Webern, Kafka, Einstein, Walser, J. Roth, Canetti
Componenti fondamentali della cultura mitteleuropea sono, tra l’altro, il tardoromanticismo e l’ebraismo (uno studio che non è stato ancora approfondito a sufficienza è, a mio avviso, quello delle interazioni — ma occorre risalire almeno alla fine del 700 — tra ebraismo e romanticismo al sorgere di quest’ultimo), tant’è che i massimi esponenti di questa cultura, dal grande Freud a Kafka a Elias Canetti, sono in gran parte di origine ebrea.
Una vita, quella di Kafka, facile da raccontare: laurea in legge, impiego alle assicurazioni, continui viaggi per lavoro e, soprattutto, per motivi di salute, letteratura, fidanzamento, rottura del fidanzamento, difficili rapporti col padre, morte. Ogni libro di Kafka riporta un’esatta cronologia della vita e delle opere, e, dal momento che questo mio lavoro non avrebbe senso se poi qualcuno non andasse a leggersi le opere di Kafka, a questa cronologia rimando.
Per finire, vorrei soffermarmi brevemente su un aspetto della sua esistenza, il rapporto col padre. Di questo rapporto, Kafka ci lasciò una monumentale testimonianza nella splendida Lettera al padre, mentre gli psicanalisti ci assicurano, se mai ce ne fosse bisogno, che tutta l’opera Kafkiana è pervasa da questo tema. Poiché moltissimo è già stato scritto su questo tema e poiché, a dispetto della psicanalisi, io sono convintissimo che il problema di Kafka è quello ebraico e non quello psicanalitico, mi limito ad un piccolo ragionamento.
 Abbiamo detto che il corpo è una sostituzione, una traduzione, e, ultimamente, una mistificazione del rapporto assente con Dio. Tutto ciò porta a parlare di un Padre assente (per la verità è solo con la venuta di Cristo che l’uomo comincia a chiamare Dio «Padre»; l’Antico Testamento non parla di paternità, né potrebbe farlo, poiché nel mondo veterotestamentario ciò che manca è, appunto, l’esperienza di tale Paternità — e, anche qui, torniamo al clima Kafkiano).
Abbiamo detto che il corpo è una sostituzione, una traduzione, e, ultimamente, una mistificazione del rapporto assente con Dio. Tutto ciò porta a parlare di un Padre assente (per la verità è solo con la venuta di Cristo che l’uomo comincia a chiamare Dio «Padre»; l’Antico Testamento non parla di paternità, né potrebbe farlo, poiché nel mondo veterotestamentario ciò che manca è, appunto, l’esperienza di tale Paternità — e, anche qui, torniamo al clima Kafkiano).
Ora, il rapporto di Kafka con il proprio genitore è un rapporto rotto, fratturato. Se, infatti, il Padre è assente, come potrà quell’uomo lì, il genitore, svolgere il proprio compito fino in fondo, senza mai dare un’impressione di inganno, di frode? Il padre è, per Kafka, un sostituto, un Corpo in cui s’incarna, ma solo a livello mistificatorio, l’assenza che la parola stessa, «padre», rivela allo scrittore, al mistico, all’uomo Franz. «Bastava la tua Corposità ad opprimermi» dice Kafka, nella già citata Lettera. «Ricordo, ad esempio, che spesso ci spogliavamo nella stessa cabina. Io magro, sottile, esile (si noti ben tre aggettivi per esprimere un solo concetto! n.r.d.), Tu vigoroso, grande, grosso».
E’ proprio questa corposità ad apparire irreale, grottesca — a mettere in luce la falsità di questo genitore. «”Commediante!”, non potè trattenersi dall’esclamare Giorgio …”. Ma certo che ho recitato la commedia! Commedia! E’ la parola giusta!”», così si esprime Kafka, in una botta-risposta tra Giorgio Bendemann e il padre ne La condanna, e sono parole che potrebbero benissimo attagliarsi al rapporto tra Kafka stesso e il padre. La legge, il Tribunale, il Castello, questo — cioè il Padre vero — l’uomo non può raggiungere.
 Così, dietro queste parole, un’altra realtà si sostituisce, in maniera fraudolenta: un finto padre. Ed è questo finto padre, questo scimmiottamento del Padre, a condannare l’uomo — condanna ridicola, quasi una buffonata, eppure l’uomo è condannato davvero: senza che nessuno lo liberi, egli, infatti, è solo, e il peso stesso del suo corpo lo trascina verso il basso: «E’ pensabile che Alessandro Magno, nonostante i successi iniziali della sua giovinezza, nonostante l’ottimo esercito che si era addestrato, nonostante le energie tese alla trasformazione del mondo che sentiva in sé, si sia fermato sull’Ellesponto, sentendo la tentazione di non attraversarlo mai, e non già per timore né per indecisione né per debolezza di volontà, ma perché aggravato dal proprio peso terreno».
Così, dietro queste parole, un’altra realtà si sostituisce, in maniera fraudolenta: un finto padre. Ed è questo finto padre, questo scimmiottamento del Padre, a condannare l’uomo — condanna ridicola, quasi una buffonata, eppure l’uomo è condannato davvero: senza che nessuno lo liberi, egli, infatti, è solo, e il peso stesso del suo corpo lo trascina verso il basso: «E’ pensabile che Alessandro Magno, nonostante i successi iniziali della sua giovinezza, nonostante l’ottimo esercito che si era addestrato, nonostante le energie tese alla trasformazione del mondo che sentiva in sé, si sia fermato sull’Ellesponto, sentendo la tentazione di non attraversarlo mai, e non già per timore né per indecisione né per debolezza di volontà, ma perché aggravato dal proprio peso terreno».
____________________________________________________________________________
Un messaggio dell’imperatore (1917)
L’imperatore — così si racconta — ha inviato a te, a un singolo, a un misero suddito, minima ombra sperduta nella più lontana delle lontananze dal sole Imperiale, proprio a te l’Imperatore ha inviato un messaggio dal suo letto di morte. Ha fatto inginocchiare il messaggero al letto, sussurrandogli il messaggio all’orecchio; e gli premeva tanto che se l’è fatto ripetere all’orecchio.
Con un cenno del capo ha confermato l’esattezza di quel che gli veniva detto. E dinanzi a tutti coloro che assistevano alla sua morte (tutte le pareti che lo impediscono vengono abbattute e sugli scaloni che si levano alti ed ampi son disposti in cerchio i grandi del regno) dinanzi a tutti loro ha congedato il messaggero.
Questi s’è messo subito in moto; è un uomo robusto, instancabile; manovrando or con l’uno or con l’altro braccio si fa strada nella folla; se lo si ostacola, accenna al petto su cui è segnato il sole, e procede così più facilmente di chiunque altro. Ma la folla è così enorme; e le sue dimore non hanno fine.
Se avesse via libera, all’aperto, come volerebbe! e presto ascolteresti i magnifici colpi della sua mano alla tua porta. Ma invece come si stanca inutilmente! ancora cerca di farsi strada nelle stanze del palazzo più interno; non riuscirà mai a superarle; e anche se gli riuscisse non si sarebbe a nulla; dovrebbe aprirsi un varco scendendo tutte le scale; e anche se gli riuscisse, non si sarebbe a nulla: c’è ancora da attraversare tutti i cortili; e dietro a loro il secondo palazzo e così via per millenni; e anche se riuscisse a precipitarsi fuori dell’ultima porta — ma questo mai e poi mai potrà avvenire — c’è tutta la città imperiale davanti a lui, il centro del mondo, ripieno di tutti i suoi rifiuti.
Nessuno riesce a passare di lì e tanto meno col messaggio di un morto.
Ma tu stai alla finestra e ne sogni, quando giunge la sera.
___________________________________________________________________________
BIBLIOGRAFIA
FRANZ KAFKA, Il processo, Mondatori
FRANZ KAFKA, Il Castello, Mondatori o Adelphi
FRANZ KAFKA, Racconti, Mondatori
FRANZ KAFKA, I diari, Mondatori
FRANZ KAFKA, Lettera al padre, Il Saggiatore (si trova anche nel volume Confessioni e immagini, edito da Mondatori)
FRANZ KAFKA, Lettere a felice, Mondatori
* * *
WALTER BENJAMIN, «Franz Kafka», in Angelus Novus, Einaudi
MAURJCE BLANCHOT, Lo spazio letterario, Einaudi
Sulla questione ebraica:
CLAUDIO MAGRIS, Lontano da dove, Einaudi






