 Tempi 21 Luglio 2009
Tempi 21 Luglio 2009L’umanitarismo non riduce la povertà. Anzi. Ingrassa i corrotti, arricchisce i dittatori, abitua la gente a mendicare. Quando non allunga le guerre. Sono gli economisti africani a denunciarlo
di Anna de Bono
In mezzo secolo, a partire dalle indipendenze, l’Africa ha usufruito a vario titolo di aiuti finanziari per oltre mille miliardi di dollari senza che questo abbia portato a una riduzione della povertà. Al contrario, tra il 1970 e il 1998, periodo in cui sono affluiti nel continente i maggiori contributi dall’estero, la povertà è salita dall’11 al 66 per cento.
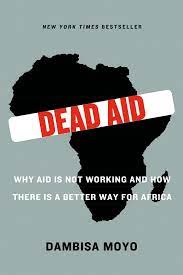 In un suo saggio intitolato Dead aid. Why aid is not working and how there is a better way for Africa, l’economista zambiana Dambisa Moyo riporta questi e altri dati a dimostrazione del fatto che la cooperazione allo sviluppo in Africa finora è stata un fallimento. Confutare la sua tesi è difficile.
In un suo saggio intitolato Dead aid. Why aid is not working and how there is a better way for Africa, l’economista zambiana Dambisa Moyo riporta questi e altri dati a dimostrazione del fatto che la cooperazione allo sviluppo in Africa finora è stata un fallimento. Confutare la sua tesi è difficile.
In effetti trent’anni fa paesi come il Burundi e il Burkina Faso, attualmente due degli Stati più poveri del mondo, avevano un Pil pro capite superiore a quello della Cina e, come ha ricordato l’11 luglio nel suo discorso di Accra il presidente americano Barack Obama, il Kenya nel 1961, quando ancora era colonia britannica, vantava un Pil pro capite maggiore di quello della Corea del Sud, ma da allora si è lasciato ampiamente sopravanzare.
Dove sono finiti tutti quei soldi?
 Sono fatti su cui riflettere, tanto più all’indomani di un G8, quello appena terminato a L’Aquila, che ha varato un nuovo programma triennale di aiuti all’Africa per un totale di 20 miliardi di dollari, che vanno ad aggiungersi ai già cospicui fondi destinati allo sviluppo, alle emergenze umanitarie e alla cancellazione del debito estero contratto dai paesi africani compresi nella categoria dei 27 Stati più poveri e più indebitati del mondo, come di-sposto dal G8 del 2005.
Sono fatti su cui riflettere, tanto più all’indomani di un G8, quello appena terminato a L’Aquila, che ha varato un nuovo programma triennale di aiuti all’Africa per un totale di 20 miliardi di dollari, che vanno ad aggiungersi ai già cospicui fondi destinati allo sviluppo, alle emergenze umanitarie e alla cancellazione del debito estero contratto dai paesi africani compresi nella categoria dei 27 Stati più poveri e più indebitati del mondo, come di-sposto dal G8 del 2005.
Il sostegno pubblico internazionale, spiega Moyo, «distrugge ogni slancio alle riforme, allo sviluppo, alla capacità di creare ricchezza nazionale e di esportarla. Alimenta la corruzione e i conflitti interni e favorisce il mantenimento di regimi pluriennali».Dello stesso parere è un altro economista africano, il kenyano James Shikwati: gli aiuti finanziano enormi burocrazie, contribuiscono a rendere dilagante la corruzione, soffocano la libera iniziativa, permettono ai leader politici di ignorare i bisogni dei loro connazionali.
 Ovunque hanno creato una mentalità pigra e hanno abituato gli africani a essere dipendenti e mendicanti. Tra gli esempi più clamorosi Shikwati cita la Nigeria e la Repubblica Democratica del Congo che, malgrado le loro immense ricchezze, non hanno fatto nulla per ridurre la povertà e premono per essere classificate tra le nazioni più bisognose per poter ricevere ulteriori aiuti.
Ovunque hanno creato una mentalità pigra e hanno abituato gli africani a essere dipendenti e mendicanti. Tra gli esempi più clamorosi Shikwati cita la Nigeria e la Repubblica Democratica del Congo che, malgrado le loro immense ricchezze, non hanno fatto nulla per ridurre la povertà e premono per essere classificate tra le nazioni più bisognose per poter ricevere ulteriori aiuti.
Proprio questo è il paradosso africano: più aumentano le risorse, più la povertà cresce. In Nigeria, per decenni primo produttore di petrolio dell’Africa subsahariana (nel 2008 scavalcato dall’Angola), il 70 per cento della popolazione tuttora vive con meno di un dollaro al giorno e il 92,8 per cento con meno di due.
La risposta all’inevitabile domanda (come mai?) l’ha data il già citato Barack Obama parlando ad Accra, Ghana, dove si è recato in visita subito dopo la fine del G8. In un memorabile discorso il presidente americano ha rivolto agli africani rimproveri che, prima di lui, soltanto papa Benedetto XVI, durante il suo viaggio in Africa di aprile, aveva osato formulare in occasioni ufficiali e con altrettanta fermezza.
 Tanto spreco di risorse va imputato al tribalismo, al malgoverno, alla corruzione di cui sono responsabili i governi africani. L’Occidente non ha colpa della bancarotta dello Zimbabwe, delle guerre in cui si fanno combattere i bambini e delle altre piaghe che affliggono il continente: «Nessun paese – ha detto Obama – può creare ricchezza se i suoi leader sfruttano l’economia per arricchirsi. Nessun imprenditore vuole investire in un paese il cui governo fa su tutto una cresta del 20 per cento. Nessuno ha voglia di vivere in un paese in cui regnano ferocia e corruzione. Questa non è democrazia, ma tirannia anche se qualche volta si va a votare. E deve finire».
Tanto spreco di risorse va imputato al tribalismo, al malgoverno, alla corruzione di cui sono responsabili i governi africani. L’Occidente non ha colpa della bancarotta dello Zimbabwe, delle guerre in cui si fanno combattere i bambini e delle altre piaghe che affliggono il continente: «Nessun paese – ha detto Obama – può creare ricchezza se i suoi leader sfruttano l’economia per arricchirsi. Nessun imprenditore vuole investire in un paese il cui governo fa su tutto una cresta del 20 per cento. Nessuno ha voglia di vivere in un paese in cui regnano ferocia e corruzione. Questa non è democrazia, ma tirannia anche se qualche volta si va a votare. E deve finire».
Il cimitero degli elefanti bianchi
 Il punto è come riuscire a indurre i governi africani a cambiare rotta. A questo proposito manca un’idea risolutiva. Ma almeno, dicono Moyo e Shikwati, possono incominciare a invertire la rotta i donatori, riducendo i programmi di cooperazione senza spaventarsi per le inevitabili critiche iniziali di chi, come Bob Geldof, è convinto che il difetto fondamentale degli aiuti internazionali è che non sono abbastanza.
Il punto è come riuscire a indurre i governi africani a cambiare rotta. A questo proposito manca un’idea risolutiva. Ma almeno, dicono Moyo e Shikwati, possono incominciare a invertire la rotta i donatori, riducendo i programmi di cooperazione senza spaventarsi per le inevitabili critiche iniziali di chi, come Bob Geldof, è convinto che il difetto fondamentale degli aiuti internazionali è che non sono abbastanza.
In realtà persino Bob Geldof si può convincere che è ora di smetterla con gli “elefanti bianchi” – così vengono chiamati nel mondo della cooperazione internazionale gli innumerevoli progetti troppo costosi e realizzati senza valutarne l’opportunità. In cima alla lista ci sono centinaia di chilometri di strade che collegano il nulla al nulla e attraversano regioni in cui quasi nessuno dispone di un’automobile.
 Ma sono “elefanti bianchi” anche le attrezzatissime strutture ospedaliere inutilizzabili perché costruite in paesi sprovvisti di medici, o gli edifici scolastici inaugurati con orgoglio e poi rimasti vuoti per mancanza di insegnanti, che sono così pochi in Africa da rendere le classi di 40-50 allievi la norma e frequenti quelle che superano il centinaio: nel 2005 in Burundi, con l’introduzione dell’istruzione primaria gratuita, i presidi si sono visti costretti a formare classi di 250 bambini.
Ma sono “elefanti bianchi” anche le attrezzatissime strutture ospedaliere inutilizzabili perché costruite in paesi sprovvisti di medici, o gli edifici scolastici inaugurati con orgoglio e poi rimasti vuoti per mancanza di insegnanti, che sono così pochi in Africa da rendere le classi di 40-50 allievi la norma e frequenti quelle che superano il centinaio: nel 2005 in Burundi, con l’introduzione dell’istruzione primaria gratuita, i presidi si sono visti costretti a formare classi di 250 bambini.
Invece si chiamano “cattedrali nel deserto” le fabbriche dalle quali non è mai uscito un prodotto finito o che hanno lavorato a regimi così bassi da fallire in breve tempo, come quella per la produzione del burro di karité costruita negli anni Novanta dalla cooperazione italiana in Burkina Faso, in una regione dove nessuno coltivava il karité e dove mancava l’acqua, necessaria in grandi quantità per l’indispensabile lavorazione a freddo dei semi.
Il genocidio assistito
 Ma, pur volendo dare ragione a Dambisa Moyo, c’è un settore della cooperazione internazionale la cui utilità sembra tanto evidente e indiscutibile da escludere l’eventualità di sospenderla o anche solo di riformularla: si tratta degli aiuti umanitari. Eppure anche qui qualcosa non funziona. E non si tratta solo di sprechi, di rapporti lacunosi su spese e risultati raggiunti e di cifre gonfiate sull’entità di una emergenza per ottenere più fondi.
Ma, pur volendo dare ragione a Dambisa Moyo, c’è un settore della cooperazione internazionale la cui utilità sembra tanto evidente e indiscutibile da escludere l’eventualità di sospenderla o anche solo di riformularla: si tratta degli aiuti umanitari. Eppure anche qui qualcosa non funziona. E non si tratta solo di sprechi, di rapporti lacunosi su spese e risultati raggiunti e di cifre gonfiate sull’entità di una emergenza per ottenere più fondi.
In un libro da poco pubblicato da Bruno Mondadori, L’industria della solidarietà, la giornalista olandese Linda Polman solleva seri interrogativi sull’esito delle attività umanitarie. Il principio mutuato dalla Croce Rossa Internazionale di soccorrere tutti coloro che ne hanno bisogno, siano essi vittime o aggressori, fa sì, ad esempio, che beneficino dell’assistenza fornita dalle Organizzazioni non governative i cosiddetti refugee warriors, i combattenti che si mescolano tra i civili nei campi profughi: «Secondo alcune stime – scrive Polman – tra il 15 e il 20 per cento degli abitanti dei campi profughi sono refugee warriors che tra un pasto e un trattamento medico portano avanti le loro guerre».
 È successo di peggio nel 1994 nei campi allestiti a Goma, Repubblica Democratica del Congo, per accogliere i profughi dal vicino Ruanda, trasformato in un mattatoio a cielo aperto dagli estremisti hutu decisi a sterminare i tutsi e gli hutu che non erano d’accordo con loro. A fuggire oltre confine, inseguiti dal Fronte patriottico ruandese a dominante tutsi, erano gli hutu, molti dei quali autori del tentato genocidio, inclusi i militari e l’intera classe politica, che continuarono per qualche tempo il massacro dei tutsi (e degli hutu che volevano rientrare in patria) tornando ogni sera nei campi trasformati in quartieri militari sotto gli occhi degli operatori. «Quando i princìpi umanitari cessano di essere etici?», si domanda Polman.
È successo di peggio nel 1994 nei campi allestiti a Goma, Repubblica Democratica del Congo, per accogliere i profughi dal vicino Ruanda, trasformato in un mattatoio a cielo aperto dagli estremisti hutu decisi a sterminare i tutsi e gli hutu che non erano d’accordo con loro. A fuggire oltre confine, inseguiti dal Fronte patriottico ruandese a dominante tutsi, erano gli hutu, molti dei quali autori del tentato genocidio, inclusi i militari e l’intera classe politica, che continuarono per qualche tempo il massacro dei tutsi (e degli hutu che volevano rientrare in patria) tornando ogni sera nei campi trasformati in quartieri militari sotto gli occhi degli operatori. «Quando i princìpi umanitari cessano di essere etici?», si domanda Polman.
Se le Ong trattano con i criminali
Ma ancora più grave è la quantità astronomica di denaro e di beni destinati alle popolazioni che, sotto forma di dazi per il transito dei convogli, estorsioni, percentuali consegnate alle autorità politiche e militari in cambio del permesso di operare in un dato territorio e via dicendo, passano dalle Ong nelle mani dei contendenti che dispongono così di sempre rinnovate risorse per continuare a combattere e a infierire sui civili.
«Grazie ai proventi delle trattative con le organizzazioni internazionali – sostiene Polman – i gruppi in lotta mangiano e si armano, oltre a pagare i loro seguaci» e questo influisce in maniera decisiva sull’intensità e sulla durata delle guerre. Nel gergo degli addetti ai lavori queste trattative vengono definite “shaking hands with the devil”. Patti con il diavolo.




