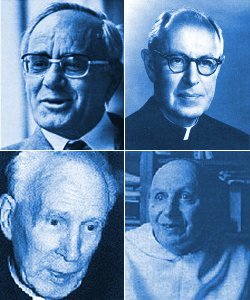Intervista a mons. Antonio Livi
a cura di Mario Faverzani
L’approccio è prettamente epistemologico, il tema trattato filosofico e teologico. Affronta questioni essenziali, benché oggi poco dibattute anche dagli “addetti ai lavori”. Eppure, si può già considerare un successo il corposo volume Vera e falsa teologia, scritto con grande competenza ed efficacia da mons. Antonio Livi, professore emerito di Filosofia della Conoscenza presso l’Università Lateranense e Presidente dell’ISCA, International Science and Commonsense Association. In poco tempo, infatti, questo testo, pubblicato dalla casa editrice “Leonardo da Vinci”, è giunto alla sua seconda edizione ed è già stato arricchito ed ampliato. Per questo vale la pena saperne di più. A partire dal titolo
Monsignore, cosa si deve intendere per “vera teologia” e cosa per ‘falsa teologia.”?
La teologia è vera solo se rispetta, nelle intenzioni e soprattutto nei fatti, lo statuto epistemologico di quella scienza che, dopo l’evento dell’Incarnazione, può dirsi “scienza della fede” e che consiste in una riflessione sistematica e metodologicamente coerente sulla verità rivelata. La teologia, dunque, ha per oggetto ciò che Dio ha detto di Sé. Come ha detto molto bene il teologo canadese Rene Latourelle, la teologia è la “scienza della Rivelazione” e logicamente possono praticare questo tipo di scienza solo quelli che alla rivelazione cristiana credono senza riserve. Chi la studia presupponendo il contrario — ossia che sia soltanto un’ipotesi filosofica o un mito religioso – fa “falsa teologia”.
Il primo esempio storico in tal senso è rappresentato dal pensiero di Hegel. Il filosofo tedesco si considerava il massimo teorico del Cristianesimo, ma per lui, luterano, il contenuto della dottrina cristiana non è una verità soprannaturale, bensì soltanto un’approssimazione alla verità, un’intuizione ancora imperfetta, una conquista della ragione umana al suo più alto grado di sviluppo dialettico.
Oggi, a quasi due secoli di distanza, vi sono ancora teologi cattolici che assumono Hegel quale paradigma del modo migliore di fare teologia: sono i pensatori di scuola razionalistica, che adottano acriticamente le premesse teoretiche e il metodo dialettico della filosofia di Emanuele Severino, pensatore cresciuto presso l’Università Cattolica di Milano alla scuola di Gustavo Bontadini e poi approdato a un sistema di pensiero neoidealistico, espressamente ateo.
Ma vi sono anche teologi cattolici, che si rifanno alla “filosofia religiosa” del danese Kierkegaard, pure luterano, presentando la fede in Cristo come un “salto nel buio”, come un’accettazione del paradosso e dell’assurdo, riducendo quindi l’atto di fede del cristiano a una scelta soggettiva, meramente volontaristica. È questo il paradigma del fideismo, che caratterizza gran parte del pensiero cattolico dei nostri giorni.
Ma tanto il razionalismo quanto il fideismo sono già stati formalmente condannati come errori teologici dal Magistero della Chiesa, anche in forma solenne, come è avvenuto con la costituzione dogmatica Dei Filius del Concilio Ecumenico Vaticano nel 1870.
Ma come questi concetti sono stati calati in un ambito quale quello del Concilio Vaticano II?
Purtroppo, alcuni teologi cattolici hanno abusivamente interpretato il Vaticano II come la consacrazione ufficiale della loro posizione ideologica, che alcuni chiamano “neo-modernismo”, altri “progressismo” o “storicismo” teologico. Non solo: hanno preteso di imporre la loro interpretazione del dogma e dello stesso evento conciliare come l’unica interpretazione valida, condannando tutte le altre come fuori dal tempo e dalla storia.
Addirittura si è arrivati a presentare la dottrina del Vaticano II non come un atto del Magistero della Chiesa (funzione che compete esclusivamente al collegio episcopale ossia ai vescovi con a capo il Papa), ma come la definitiva vittoria di una fazione politica (la cosiddetta “teologia conciliare”) su di un’altra fazione politica (la cosiddetta “teologia pre-conciliare”) attraverso un evento anch’esso politico come l’assemblea conciliare.
Da qui nasce la falsa ermeneutica del Concilio che Benedetto XVI ha denominato “ermeneutica della rottura”, quando l’unica ammissibile è quella della “riforma nella continuità”. Da qui dipendono anche tutti gli altri errori. La “falsa teologia”, teoreticamente povera e riduttiva, perde di vista l’essenza stessa del Cristianesimo, cioè il Vangelo.
Ciò che accomuna i vari “teologi della discontinuità” (quelli che vedono il Concilio Vaticano II come un momento di rottura con la Tradizione) è l’ideologia del progressismo storicistico: tutti i dogmi vengono “superati” e, in pratica, contraddetti, ma non esplicitamente, con una chiara e oggettiva negazione (come facevano gli eretici in altri tempi), bensì attraverso le forme più ambigue del linguaggio fenomenologico.
Così, conservando del messaggio evangelico solo ciò che sembra più conforme allo Zeitgeist [spirito del tempo, ndc], si elimina dalla catechesi tutto ciò che è propriamente dogmatico e quindi irreformabile. Vengono eliminate dalla pubblicistica teologica, dalla catechesi ordinaria e dall’omiletica proprio quelle verità di fede che consentono l’appartenenza alla Chiesa, corpo mistico di Cristo, e aprono le porte della salvezza eterna.
Oggi è ancora valido il principio secondo cui “philosophia ancilla theologiae“?
È impossibile fare teologia senza la filosofia. L’importante, però, è adottare categorie fi-losofiche compatìbili con il contenuto razionale del dogma. Già nel 1998 il Papa filosofo, Giovanni Paolo II, ribadì l’insegnamento perenne della Chiesa sulla teologia: essa non può fare a meno della “retta ragione”, perché l’atto di fede del credente nei misteri soprannaturali presuppone delle certezze naturali – che il Papa chiama la “filosofia implicita” e io chiamo il “senso comune” – le quali a loro volta sono la base e la premessa della filosofia scientifica, il cui nucleo è la metafisica, ossia la filosofia che tratta dell’essere delle cose in senso realistico.
L’espressione scolastica “philosophia ancilla theologiae” è citata dal Papa nell’enciclica proprio per ribadire che la teologia non può fare a meno della filosofia. Da parte di molti teologi, la categoria “mondo moderno” viene assunta come un’unità di pensiero chiusa al trascendente. Si fa così della modernità, senza alcuna serietà scientifica, un pensiero unico ed omogeneo.
Anzi, se qualcuno ricorda ancora ai fedeli che l’unica fede che salva è la fede (divina) nella dottrina della Chiesa e non la fede (umana) nelle elucubrazioni dei presunti teologi, costui viene attaccato come reo di “lesa maestà”. Parlo per esperienza personale.
Come mai oggi vengono definiti “teologi” anche pensatori atei, laicisti, ideologi relativisti?
Certo, possono parlare di Dio e della rivelazione cristiana anche gli atei e i fautori del relativismo, perché si limitano a esporre teorie insensate sulla fede come mera opinione soggettiva, priva sempre di qualsiasi giustificazione epistemica. Se invece si intende parlare sensatamente di ciò che Dio ha detto occorre presupporre la verità naturale che Dio esiste e la verità soprannaturale che Dio ha parlato per mezzo dei Profeti e nella Persona del Figlio Suo, Gesù Cristo.
Quando il teologo non è mosso dall’amore di Dio ma dall’amor proprio non è in condizioni di svolgere il proprio compito speculativo in modo scientificamente serio e alla fine nella Chiesa ci si accorge che i risultati della sua ricerca sono inutili, inservibili in un’economia di testimonianza propriamente evangelica, sia intraecclesiale che ecumenica. Ma non si deve dimenticare che i grandi teologi della storia del Cristianesimo sono stati tutti degli autentici mistici e allo stesso tempo degli autorevolissimi metafisici, come sant’Agostino, sant’Anselmo d’Aosta, san Bonaventura, san Tommaso d’Aquino, il beato Giovanni Duns Scoto, san Giovanni della Croce… Non a caso sono tutti colossi della fede e giganti della teologia. Quella vera.