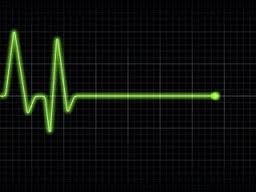A quarant’anni dal rapporto di Harvard. Seguono alcune considerazioni di Chiara Mantovani e Roberto De Mattei sulla morte cerebrale
di Lucetta Scaraffia
Anche la Chiesa cattolica, consentendo il trapianto degli organi, accetta implicitamente questa definizione di morte, ma con molte riserve: per esempio, nello Stato della Città del Vaticano non è utilizzata la certificazione di morte cerebrale. A ricordare questo fatto è ora il filosofo del diritto Paolo Becchi in un libro (Morte cerebrale e trapianto di organi, Morcelliana) che – oltre a rifare la storia della definizione e dei dibattiti seguiti negli anni Settanta, tra i quali il più importante è senza dubbio quello di cui fu protagonista Hans Jonas – affronta con chiarezza la situazione attuale, molto più complessa e controversa.
Il motivo per cui questa nuova definizione è stata accettata così rapidamente sta nel fatto che essa non è stata letta come un radicale cambiamento del concetto di morte, ma soltanto – scrive Becchi – come “una conseguenza del processo tecnologico che aveva reso disponibili alla medicina più affidabili strumenti per rilevare la perdita delle funzioni cerebrali”. La giustificazione scientifica di questa scelta risiede in una peculiare definizione del sistema nervoso, oggi rimessa in discussione da nuove ricerche, che mettono in dubbio proprio il fatto che la morte del cervello provochi la disintegrazione del corpo.
Come dimostrò nel 1992 il caso clamoroso di una donna entrata in coma irreversibile e dichiarata cerebralmente morta prima di accorgersi che era incinta; si decise allora di farle continuare la gravidanza, e questa proseguì regolarmente fino a un aborto spontaneo. Questo caso e poi altri analoghi conclusi con la nascita del bambino hanno messo in questione l’idea che in questa condizione si tratti di corpi già morti, cadaveri da cui espiantare organi. Sembra, quindi, avere avuto ragione Jonas quando sospettava che la nuova definizione di morte, più che da un reale avanzamento scientifico, fosse stata motivata dall’interesse, cioè dalla necessità di organi da trapiantare.
Naturalmente, in proposito si è aperta nel mondo scientifico una discussione, in parte raccolta nel volume, curato da Roberto de Mattei, Finis vitae. Is brain death still life? (Rubbettino), i cui contributi – di neurologi, giuristi e filosofi statunitensi ed europei – sono concordi nel dichiarare che la morte cerebrale non è la morte dell’essere umano. Il rischio di confondere il coma (morte corticale) con la morte cerebrale è sempre possibile.
E questa preoccupazione venne espressa al concistoro straordinario del 1991 dal cardinale Ratzinger nella sua relazione sul problema delle minacce alla vita umana: “Più tardi, quelli che la malattia o un incidente faranno cadere in un coma “irreversibile”, saranno spesso messi a morte per rispondere alle domande di trapianti d’organo o serviranno, anch’essi, alla sperimentazione medica (“cadaveri caldi”)”.
Queste considerazioni aprono ovviamente nuovi problemi per la Chiesa cattolica, la cui accettazione del prelievo degli organi da pazienti cerebralmente morti, nel quadro di una difesa integrale e assoluta della vita umana, si regge soltanto sulla presunta certezza scientifica che essi siano effettivamente cadaveri.
Ma la messa in dubbio dei criteri di Harvard apre altri problemi bioetici per i cattolici: l’idea che la persona umana cessi di esistere quando il cervello non funziona più, mentre il suo organismo – grazie alla respirazione artificiale – è mantenuto in vita, comporta una identificazione della persona con le sole attività cerebrali, e questo entra in contraddizione con il concetto di persona secondo la dottrina cattolica, e quindi con le direttive della Chiesa nei confronti dei casi di coma persistente. Come ha fatto notare Peter Singer, che si muove su posizioni opposte a quelle cattoliche: “Se i teologi cattolici possono accettare questa posizione in caso di morte cerebrale, dovrebbero essere in grado di accettarla anche in caso di anencefalie”.
Facendo il punto sulla questione, Becchi scrive che “l’errore, sempre più evidente, è stato quello di aver voluto risolvere un problema etico-giuridico con una presunta definizione scientifica”, mentre il nodo dei trapianti “non si risolve con una definizione medico-scientifica della morte”, ma attraverso l’elaborazione di “criteri eticamente e giuridicamente sostenibili e condivisibili”.
La Pontificia Accademia delle Scienze – che negli anni Ottanta si era espressa a favore del rapporto di Harvard – nel 2005 è tornata sul tema con un convegno su “I segni della morte”. Il quarantesimo anniversario della nuova definizione di morte cerebrale sembra quindi riaprire la discussione, sia dal punto di vista scientifico generale, sia in ambito cattolico, al cui interno l’accettazione dei criteri di Harvard viene a costituire un tassello decisivo per molte altre questioni bioetiche oggi sul tappeto, e per il quale al tempo stesso costa rimettere in discussione uno dei pochi punti concordati tra laici e cattolici negli ultimi decenni.
* * *
Agenzia Zenit lunedì, 8 settembre 2008
MORTE QUANDO?
ROMA – Pubblichiamo di seguito per la rubrica di Bioetica l’intervento della dottoressa Chiara Mantovani, Presidente dell’Associazione Medici Cattolici Italiani (AMCI) di Ferrara e Presidente di Scienza & Vita di Ferrara.
* * *
Lucetta Scaraffia, dalle pagine dell’Osservatore Romano, riapre una questione che periodicamente solleva discussioni e perplessità: la dichiarazione di morte di una persona umana.
L’argomento è terribile ed affascinante: conosco persone che, tanti anni fa, si iscrissero ad una associazione di donatori d’organo spinte dal solo terrore di essere sepolti vivi. Meglio star certi di finire nella cassa senza rischi di svegliarsi. Il che non è propriamente una dimostrazione di fiducia nella perizia medica, ma ha una sua giustificazione emotiva.
Non sarà forse inutile ripetere alcune piccole considerazioni, tenendo presente sia gli aspetti tecnico-scientifici che quelli etici; non affrontando quelli medico-legali, per il solo motivo che essi sono regolati dalla legislazione, sulla quale attualmente non c’è modo di agire: questo è dunque un aspetto ininfluente non sulla prassi, ma certamente sulla comprensione del problema.
Però resta vero, e anzi assolutamente notabile, che la legislazione si avvale, per esprimersi, di basi di competenza che le sono estranee: ecco il ruolo della scienza medica supportata dal corredo tecnico sufficiente a fornire basi oggettive. Così come è doveroso rimarcare che la nostra legislazione prevede i protocolli più aderenti alle notizie scientifiche certe di cui disponiamo, diversamente da quanto accade in altri Stati europei o nordamericani
E diciamo subito una verità tanto sgradevole quanto evidente: prima o poi bisogna consegnare il corpo morto ad un seppellitore. Oggi anche ad un inceneritore, a causa del poco spazio disponibile per i cimiteri nelle aree urbane e ancor più il disagio psicologico del pensiero della decomposizione. Non si tratta di cinismo, ma solo di realismo.
Per cominciare è indispensabile fare chiarezza sui termini usati: leggo affermazioni tanto inesatte al punto da fraintendere la realtà.
Morte cerebrale: è una espressione errata, dannosa, fuorviante. Troppo usata, purtroppo, come sinonimo di “morte encefalica”, che invece è tutta un’altra questione. Per dare un’idea, anche se grossolana: come se affermassimo che dormire profondamente è come essere morto.
Invece, con “morte encefalica” si intende il silenzio elettrico (l’assenza totale, ripetutamente registrata, di ogni attività nella corteccia cerebrale, nel ponte e nel bulbo: tutto l’encefalo!) di ogni struttura deputata a generare e coordinare qualsiasi altra attività del corpo.
Anche solo da questa generica definizione chiunque può capire che se uno che sembra morto, perché magari non risponde alle parole e ai suoni intorno a lui, ma invece respira da solo e il suo cuore batte autonomamente, evidentemente non è davvero morto! Succede che una parte dell’encefalo sia rovinata, ma non tutto: ciò che regola cuore e polmoni funziona! Non entriamo qui nel delicato argomento di come si voglia considerare la vita di questa ipotetica (ma poi mica tanto!) persona: sofferente, non dignitosa, inutile, insopportabile (per gli altri). Queste sono valutazioni diverse dalla semplice constatazione che la vita non ha abbandonato quel corpo.
Come stabiliamo la morte? Rilevando la cessazione delle funzioni che conosciamo necessarie alla vita: respirazione e circolazione. Chiaramente deve essere una cessazione, non una temporanea e breve interruzione; ma sappiamo anche che un quarto d’ora nell’adulto, mezzoretta nel bambino, senza respirare e/o battere del cuore (e le due cose sono strettamente collegate) causano la morte.
In pratica: senza ossigeno (procurato nei polmoni) distribuito in tutto il corpo dalla pompa-cuore, il cervello (tutto il cervello!!!) si danneggia e non funziona più, ovvero non è in grado di assolvere alla sua funzione di struttura di coordinamento e di input per tutte le funzioni vitali.
E’ un meraviglioso meccanismo autoregolamentato: l’encefalo fa da centralina elettrica, la circolazione porta l’ossigeno dai polmoni alla periferia, anche alla centralina stessa. Interrompere a qualsiasi livello queste funzioni integrate è mettere la macchina corporea fuori uso. Se vediamo qualcuno gravemente traumatizzato, trapassato da pallottole, esanime, senza respirazione, intuiamo la sua morte; ma il motivo vero, in ultima analisi, è sempre riconducibile all’impossibilità di assicurare ossigeno e acqua ai tessuti!
Non sembri, questa elementare descrizione dei meccanismi fisici, dettata da indifferenza verso i sempre presenti significati metafisici: ma è troppa la confusione attualmente presente per tralasciare il lato più concreto.
Coma (depassé, profondo: aggettivi ancora usati ma inesatti) stato vegetativo (permanente o persistente che dir si voglia: in ogni modo si dice impropriamente), non sono equivalenti della morte encefalica: ovvero dello stato in cui, per quel che ne sappiamo finora, la capacità di provvedere ai processi vitali (appunto quelli che consentono la vita) è venuta meno.
E con chiarezza si può affermare che oggi in Italia la legge consente l’espianto di organi solo in caso di morte accertata con criteri neurologici che definiscano un quadro di morte encefalica e non cerebrale.
Per dirla bene: l’elettroencefalogramma piatto NON è ancora morte encefalica, non si espiantano organi se i centri profondi bulbari danno ancora segno di attività elettrica.
In altri luoghi del mondo può succedere: ci giungono notizie che un metodo per giustiziare i condannati in Cina sia l’espianto in vivo, ma fortunatamente non siamo in Cina (almeno finora).
Qualcuno può riferire di una certa “fretta” nel cercare di ottenere il permesso dei parenti (in Italia ancora vincolante): e qui si apre la voragine di un corretto rapporto e comunicazione dei medici nei confronti dei pazienti e delle loro famiglie.
C’è poi il grande dramma psicologico di vedere qualcuno che amiamo sottoposto a ciò che sembra una cura medica (circolazione e ventilazione forzate per mantenere quel necessario apporto di ossigeno): bisognerebbe spiegare bene che sono solo i tempi richiesti proprio per quell’accertamento rigoroso dei criteri di morte encefalica; bisognerebbe riuscire a far intendere che è proprio un meccanismo di sicurezza per accorgersi se ci si è sbagliati, se una registrazione si è interrotta dando risultati falsati. E’ durissimo vedere e sentir parlare di “cadavere a cuore battente”, perché siamo tradizionalmente legati all’immagine del cuore come centro della vita, ma è indispensabile fare uno sforzo chiarificatore per togliere, per quanto è possibile, l’illusione di vita.
Certamente nessuna legge riesce ad impedire l’abuso: e la consapevolezza di questo dovrebbe sempre accompagnare il legislatore, inducendolo ad una prudenza e ad una umiltà che consentano sempre l’aggiornamento sulla base di eventuali nuove scoperte tecnico-scientifiche.
Leggo nell’articolo di Lucetta Scaraffia cui facevo riferimento all’inizio: Come ha fatto notare Peter Singer, che si muove su posizioni opposte a quelle cattoliche: “Se i teologi cattolici possono accettare questa posizione in caso di morte cerebrale, dovrebbero essere in grado di accettarla anche in caso di anencefalie”.
Mi sia consentito replicare sommessamente a Singer che il problema non è “cattolico”: i teologi cattolici esprimono posizioni coerenti con la teologia partendo dai dati di ragione forniti da altre discipline. E ciò che stride è proprio che in realtà il comportamento consigliato dai teologi morali di fede cattolica è coerente con le coordinate espresse finora: il paziente anencefalico dovrebbe essere (e in Italia lo è!) monitorato per tutta quella parte di encefalo che ha e solo al raggiungimento del silenzio elettrico è dichiarato morto!
Si applica proprio in questo caso-limite tutta la prudenza invocata prima: se bastasse solo un EEG, visto che non c’è niente da controllare (il bimbo anencefalico ha solo piccole parti di cervello, spesso non la corteccia) sarebbe dichiarato morto subito. Invece si va oltre, si aspetta che ogni più piccolo segnale sia cessato, e si aspetta che sia cessato per un tempo doppio rispetto all’adulto perché conosciamo la maggiore resistenza del tessuto nervoso del neonato all’anossia.
Se si ragionasse nei termini di “assenza di coscienza” (senza corteccia cerebrale non c’è coscienza) si darebbe ragione al signor Singer, il quale, dal canto suo, non ha neppure bisogno dell’EEG per dichiarare un essere umano una non-persona: per lui fino a quando non si hanno capacità di parola e relazione, non si ha dignità umana! Se si ragionasse nei termini di vita degna-non degna, si potrebbero accelerare i tempi di morte di pazienti senza corteccia funzionante (senza capacità di relazione), ma con il cuore che batte da solo e con i polmoni che scambiano anidride carbonica con ossigeno.
Invece la testardaggine tutta cristiana di appoggiarsi al dato reale ci protegge fino in fondo. Quando sussiste segno di vita, è vita. Bella, brutta, gradevole o puzzolente, è vita.
Ma nell’articolo uscito il 3 settembre, si riportava anche un’altra affermazione francamente sorprendente: Facendo il punto sulla questione, Becchi scrive che “l’errore, sempre più evidente, è stato quello di aver voluto risolvere un problema etico-giuridico con una presunta definizione scientifica”, mentre il nodo dei trapianti “non si risolve con una definizione medico-scientifica della morte”, ma attraverso l’elaborazione di “criteri eticamente e giuridicamente sostenibili e condivisibili”.
Forse fraintendo, me lo auguro, ma qui c’è un invito a prescindere dai fatti. Che cosa può appoggiare legittimamente il giudizio se non la conoscenza del fatto, nella misura che è possibile alla ragione e all’esperienza? Quando la morte si accertava con lo specchietto (se si appannava, si era vivi; se no, si era sepolti. E per giunta senza aspettare troppo tempo, per via della puzza) si commettevano delitti contro l’etica o contro la buona pratica clinica? E poi la verità su cui appoggiare il giudizio dovrebbe scaturire dall’accordo su ciò che è giusto? Mettiamo ai voti i criteri di accertamento della morte?
Il problema etico è di (apparente) semplice soluzione: si dispone con rispetto del cadavere, si tratta con rispetto il vivente. Mi pare superfluo soffermarmi sulla differenza tra “disporre” e “trattare”.
La natura di cosa, ancorché nobile, del corpo morto attiene alla sostanza cadaverica; la natura di persona del corpo vivente attiene alla sostanza di essere. L’una e l’altra vedono nei loro confronti applicata l’etica quando ricevono un trattamento adeguato alla rispettiva natura.
Il problema giuridico è più complesso perché si tratta di tradurre in pratica norme valide per ogni situazione. E in un panorama etico e sociale diviso, anzi, frammentato, come il moderno, questa è operazione sempre più complessa. Ma se anche la legislazione si allontana dalla concretezza del dato conosciuto e onestamente riconosciuto, e se cade nel tranello della concertazione, allora non so immaginare quale possibilità possa avere l’etica di trovare un fondamento comune.
* * *
Considerazioni sulla “morte cerebrale” dopo l’articolo dell’“Osservatore Romano”
L’intolleranza mediatica contro l’editoriale di Lucetta Scaraffia, I segni della morte, sull’“Osservatore Romano” del 3 settembre 2008, suggerisce alcune considerazioni sul tema delicato e cruciale della morte cerebrale.
Roberto De Mattei
Tutti possono consentire sulla definizione, in negativo, della morte come “fine della vita”. Ma che cos’è la vita? La biologia attribuisce la qualifica di vivente ad un organismo che ha in sé stesso un principio unitario e integratore che ne coordina le parti e ne dirige l’attività. Gli organismi viventi sono tradizionalmente distinti in vegetali, animali ed umani.
La vita della pianta, dell’animale e dell’uomo, pur di natura diversa, presuppone, in ogni caso un sistema integrato animato da un principio attivo e unificatore. La morte dell’individuo vivente, sul piano biologico, è il momento in cui il principio vitale che gli è proprio cessa le sue funzioni. Lasciamo da parte il fatto che, per l’essere umano, questo principio vitale, definito anima, sia di natura spirituale e incorruttibile. Fermiamoci al concetto, unanimamente ammesso, che l’uomo può dirsi clinicamente morto quando il principio che lo vivifica si è spento e l’organismo, privato del suo centro ordinatore, inizia un processo di dissoluzione che porterà alla progressiva decomposizione del corpo.
Ebbene, la scienza non ha finora potuto dimostrare che il principio vitale dell’organismo umano risieda in alcun organo del corpo. Il sistema integratore del corpo, considerato come un “tutto”, non è infatti localizzabile in un singolo organo, sia pure importante, come il cuore o l’encefalo. Le attività cerebrali e cardiache presuppongono la vita, ma non è propriamente in esse la causa della vita.
Non bisogna confondere le attività con il loro principio. La vita è qualcosa di inafferrabile che trascende i singoli organi materiali, dell’essere animato, e che non può essere misurata materialmente, e tanto meno creata: è un mistero della natura, su cui è giusto che la scienza indaghi, ma di cui la scienza non è padrona. Quando la scienza pretende di creare o manipolare la vita, si fa essa stessa filosofia e religione, scivolando nello “scientismo”.
Il volume Finis Vitae. La morte cerebrale è ancora vita?, pubblicato in coedizione dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e da Rubbettino (Soveria Mannelli 2008), con il contributo di diciotto studiosi internazionali, dimostra questi concetti in quasi cinquecento pagine.
Non solo non può essere accettato il criterio neurologico che fa riferimento alla “morte corticale”, perché in essa rimane integro parte dell’encefalo e permane attiva la capacità di regolazione centrale delle funzioni omeostatiche e vegetative; non solo non può essere accettato il criterio che fa riferimento alla morte del tronco-encefalo, perché non è dimostrato che le strutture al di sopra del tronco abbiano perso la possibilità di funzionare se stimolate in altro modo; ma neppure può essere accettato il criterio della cosiddetta “morte cerebrale”, intesa come cessazione permanente di tutte le funzioni dell’encefalo (cervello, cervelletto e tronco cerebrale) con la conseguenza di uno stato di coma irreversibile.
Lo stesso prof. Carlo Alberto De Fanti, il neurologo che vuole staccare la spina a Liliana Englaro, autore di un libro dedicato a questo argomento (Soglie, Bollati Boringhieri, Torino 2007), ha ammesso che la morte cerebrale può essere forse definita un “punto di non ritorno”, ma “non coincide con la morte dell’organismo come un tutto (che si verifica solo dopo l’arresto cardiocircolatorio)” (“L’Unità”, 3 settembre 2008). E’ evidente come il “punto di non ritorno”, posto che sia realmente tale, è una situazione di gravissima menomazione, ma non è la morte dell’individuo.
L’irreversibilità della perdita delle funzioni cerebrali, accertata dall’“encefalogramma piatto”, non dimostra la morte dell’individuo. La perdita totale dell’unitarietà dell’organismo, intesa come la capacità di integrare e coordinare l’insieme delle sue funzioni, non dipende infatti dall’encefalo, e neppure dal cuore.
L’accertamento della cessazione del respiro e del battito del cuore non significa che nel cuore o nei polmoni stia la fonte della vita. Se la tradizione giuridica e medica, non solo occidentale, ha da sempre ritenuto che la morte dovesse essere accertata attraverso la cessazione delle attività cardiocircolatorie è perché l’esperienza dimostra che all’arresto di tali attività fa seguito, dopo alcune ore, il rigor mortis e quindi l’inizio della disgregazione del corpo.
Ciò non accade in alcun modo dopo la cessazione delle attività cerebrali. Oggi la scienza fa sì che donne con encefalogramma piatto possano portare a termine la gravidanza, mettendo al mondo bambini sani. Un individuo in stato di “coma irreversibile” può essere tenuto in vita, con il supporto di mezzi artificiali; un cadavere non potrà mai essere rianimato, neppure collegandolo a sofisticati apparecchi.
Restano da aggiungere alcune considerazioni. Il direttore del Centro Nazionale Trapianti, Alessandro Nanni Costa, ha dichiarato i criteri di Harvard “non sono mai stati messi in discussione dalla comunità scientifica” (“La Repubblica”, 3 settembre 2008). Se anche ciò fosse vero, e non lo è, è facile rispondere che ciò che caratterizza la scienza è proprio la sua capacità di porre sempre in discussione i risultati acquisiti.
Qualsiasi epistemologo sa che la finalità della scienza non è produrre certezze, bensì ridurre le incertezze. Altri, come il prof. Francesco D’Agostino, presidente onorario del Comitato Nazionale di Bioetica, sostengono che, sul piano scientifico, la tesi contraria alla morte cerebrale “è ampiamente minoritaria” (“Il Giornale”, 3 settembre 2008).
Il prof. D’Agostino ha scritto belle pagine in difesa del diritto naturale e non può ignorare che il criterio della maggioranza può avere rilievo sotto l’aspetto politico e sociale, non certo quando si tratta di verità filosofiche o scientifiche. Intervenendo nel dibattito, una studiosa “laica” come Luisella Battaglia osserva che “il valore degli argomenti non si misura dal numero delle persone che vi aderiscono” e “il fatto che i dubbi siano avanzati da frange minoritarie non ha alcuna rilevanza dal punto di vista della validità delle tesi sostenute” (“Il Secolo XIX”, 4 settembre 2008).
Sul piano morale poi l’esistenza stessa di una possibilità di vita esige l’astensione dall’atto potenzialmente omicida. Se esiste anche solo il dieci per cento che dietro un cespuglio vi sia un uomo, nessuno è autorizzato ad aprire il fuoco. In campo bioetico, il principio in dubio pro vita resta centrale.
La verità è che la definizione della morte cerebrale fu proposta dalla Harvard Medical School, nell’estate del 1968, pochi mesi dopo il primo trapianto di cuore di Chris Barnard (dicembre 1967), per giustificare eticamente i trapianti di cuore, che prevedevano che il cuore dell’espiantato battesse ancora, ovvero che, secondo i canoni della medicina tradizionale, egli fosse ancora vivo.
L’espianto, in questo caso equivaleva ad un omicidio, sia pure compiuto “a fin di bene”. La scienza poneva la morale di fronte a un drammatico quesito: è lecito sopprimere un malato, sia pure condannato a morte, o irreversibilmente leso, per salvare un’altra vita umana, di “qualità” superiore?
Di fronte a questo bivio, che avrebbe dovuto imporre un serrato confronto tra opposte teorie morali, l’Università di Harvard si assunse la responsabilità di una “ridefinizione” del concetto di morte che permettesse di aprire la strada ai trapianti, aggirando le secche del dibattito etico.
Non c’era bisogno di dichiarare lecita l’uccisione del paziente vivo; era sufficiente dichiararlo clinicamente morto. In seguito al rapporto scientifico di Harvard, la definizione di morte venne cambiata in quasi tutti gli Stati americani e, in seguito, anche nella maggior parte dei Paesi cosiddetti sviluppati (in Italia, la “svolta” fu segnata dalla legge 29 dicembre 1993 n. 578 che all’art. 1 recita: “La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni del cervello”).
La natura del dibattito non è dunque scientifica, ma etica. Che questa sia la verità lo conferma il senatore del PD Ignazio Marino che in un articolo su “Repubblica” del 3 settembre definisce l’articolo dell’“Osservatore Romano” “un atto irresponsabile che rischia di mettere in pericolo la possibilità di salvare centinaia di migliaia di vite grazie alla donazione degli organi”.
Queste parole insinuano innanzitutto una menzogna: quella che il rifiuto della morte cerebrale porti alla cessazione di ogni tipo di donazione, laddove il problema etico non riguarda la maggior parte dei trapianti, ma si pone solo per il prelievo di organi vitali che comporti la morte del donatore, come è il caso dell’espianto del cuore. Ciò spiega come Benedetto XVI, che ha sempre nutrito riserve verso il concetto di morte cerebrale, si sia a suo tempo detto favorevole alla donazione di organi (cfr. Sandro Magister, Trapianti e morte cerebrale, l’“Osservatore Romano” ha rotto il tabù, www.chiesa).
Il vero problema è che il prezzo da pagare per salvare queste vite è quello tragico di sopprimerne altre. Si vuole sostituire il principio utilitaristico secondo cui si può fare il male per ottenere un bene, alla massima occidentale e cristiana secondo cui non è lecito fare il male, neppure per ottenere un bene superiore.
Se un tempo i “segni” tradizionali della morte dovevano accertare che una persona viva non fosse considerata morta, oggi il nuovo criterio harvardiano pretende di trattare il vivente come un cadavere per poterlo espiantare. A monte di tutto questo sta quel medesimo disprezzo per la vita umana che dopo avere imposto la legislazione sull’aborto vuole spalancare la strada a quella sull’eutanasia.