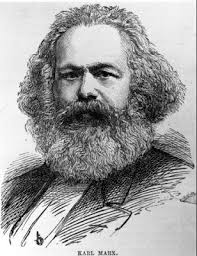Articolo pubblicato su Liberal Anno II n.2
Contro la globalizzazione stanno rinascendo ideologie che sembravano superate
di Jacques Garello
La mondializzazione che stiamo vivendo in questo principio di millennio è senza dubbio il cambiamento più importante che sia occorso nella storia degli uomini dopo la Rivoluzione industriale, ovvero dopo il risveglio dell’Europa nel Dodicesimo e Tredicesimo secolo. A queste accelerazioni storiche riconosciamo del resto alcuni tratti comuni: l’ampliamento dello spazio di comunicazione e di scambio (il cui ruolo è stato posto in evidenza da Adam Smith), il progresso della conoscenza e della fiducia nella creatività umana, l’impulso della libertà e del diritto e, infine (conseguenza e non causa), l’apparizione di nuove tecniche.
Tali periodi di transizione non sono sempre compresi da coloro che li vivono, e talora neppure da coloro che ne sono gli artefici. Poiché la storia non è mai rottura, bensì evoluzione, questi periodi sono segnati dal conflitto tra il vecchio e il nuovo, dalla coesistenza del vecchio mondo, che alberga ancora negli spiriti e nelle istituzioni, e del mondo nuovo, del quale non si distinguono chiaramente i contorni né le nuove regole del gioco. E ciò spiega certe reazioni di rifiuto, di paura collettiva, e infine di violenza.
Dal mio punto di vista vi è dunque una componente naturale, ineluttabile, dell’antimondialismo: il timore della novità, la paura del cambiamento quando non si sa se sia progresso o regresso. Si ha l’impressione che la capacità di padroneggiare il progresso sfugga ai testimoni del progresso. Una reazione simile è stata particolarmente netta nei decenni consecutivi alla Rivoluzione industriale. Sin dal 1791 Malthus s’interrogava su La Crisi. E, aperto da Malthus, il dibattito sulla crisi dominerà il pensiero economico, grosso modo, fino al 1939.
Le formidabili prestazioni dell’industria meccanizzata non avrebbero forse provocato una corsa sfrenata alla produzione? La «crisi di sovrapproduzione», non più semplice incidente passeggero, ma destino apocalittico di un sistema privo di regolazione, è stata una certezza per Malthus, Sismondi, Ricardo e, con ogni evidenza, per Marx. Al contrario, Jean-Baptiste Say, Frédéric Bastiat e gli economisti del Journal (tra cui Pellegrino Rossi) respingevano il principio della crisi e ne traevano la conclusione delle «armonie economiche», – nella misura in cui il Laisser faire, laisser passer fosse rispettato.
Proseguo il parallelo col diciannovesimo secolo: è istruttivo. Come possiamo notare oggi, per sfruttare le reazioni di dubbio e recuperare le paure collettive, all’epoca non sono mancati profeti di sventura e mercanti di illusioni. Marx e i comunisti sono evidentemente coloro che hanno avuto maggior successo in quest’impresa di demoralizzazione sociale, di contestazione del progresso, di ripulsa del sistema e di sfrenato costruttivismo. È questo dunque che viviamo oggi, come lo hanno vissuto gli europei del diciannovesimo secolo: lo sfruttamento delle reazioni naturali che si producono al cospetto dei mutamenti della società, per legittimare una rivolta artificiale, per sostituire un ordine creato, rigido e inumano a un ordine spontaneo, evolutivo, a misura della persona umana.
Il parallelismo con il diciannovesimo secolo non è tuttavia totale. Infatti la nuova ondata di malthusianismo che conosciamo oggi ha la caratteristica evidente di essere la seconda. E il fallimento del pensiero marxista, simboleggiato dalla caduta del Muro di Berlino nel 1989, lungi dall’aver scoraggiato o reso più saggi i malthusiani di tutti i Paesi, li ha resi ancora più aggressivi. È la loro seconda possibilità. Cancellati per un attimo dalla carta intellettuale e politica del pianeta, i rossi si sono dipinti di verde (come alla conferenza di Rio nel 1992), si sono vestiti da contadini (come a Seattle nel 1999), prima di mascherarsi da «società civile internazionale» strutturata intorno alle «Ong» (organizzazioni non governative) a Porto Allegre quest’anno.
Il passato di questi antimondialisti è indubitabile. I leader provengono dall’internazionale trotskista. I fondi sono forniti da tutti coloro che, direttamente o indirettamente, per ragioni tanto economiche quanto ideologiche, hanno interesse a destabilizzare il capitalismo mondiale. Non credo che sia necessario insistere sulle origini e sulle intenzioni di questi «antimondialisti», tanto sono evidenti e, dopotutto, prive d’importanza. Mi pare in effetti più utile rispondere a due domande: perché le tesi antimondialiste hanno avuto tanto impatto sull’opinione pubblica? In che modo i liberali possono riconciliare l’opinione pubblica con il mondialismo?
L’impatto dell’antimondialismo.
Come tutti i manipolatori, gli antimondialisti si basano su credenze popolari e reazioni naturali. Lenin aveva già fornito le istruzioni per l’uso: trovare «alleati oggettivi», sfruttare ogni motivo di malcontento, canalizzarli attraverso «cinghie di trasmissione». Ecco alcune delle armi più spesso utilizzate dagli antimondialisti: il riflesso protezionista e nazionalista, il comunitarismo e l’umanitarismo, la rivendicazione della giustizia sociale, il controllo di un mercato anarchico, la salvaguardia dell’ambiente.Il vecchio demone protezionista è al lavoro. Non è mai stato sradicato.
Frédéric Bastiat spiegava perché: nel dibattito politico vengono privilegiati sempre gli interessi dei produttori rispetto a quelli dei consumatori. I produttori possono organizzarsi in gruppi di pressione, e si fanno tanto più ascoltare in quanto rappresentano una forza elettorale ben localizzata. I consumatori sono disorganizzati e dispersi, e non possono far valere i loro punti di vista. Il protezionismo è tanto più virulento in quanto è antico, e in quanto generazioni successive di produttori sono stati abituati all’assistenza dello Stato contro la concorrenza straniera.
Ciò è particolarmente vero per gli agricoltori europei, che da mezzo secolo beneficiano della politica agricola comune, e per i quali l’idea di lasciar circolare liberamente i prodotti agricoli è inconcepibile. Con ogni evidenza questo protezionismo, come ogni altro, entro un certo termine si volge contro quelli che l’hanno praticato: incapaci di adattarsi alle esigenze del mercato mondiale, i contadini debbono contare sempre più sui sussidi pubblici e sempre meno sulla vendita della loro produzione, e un giorno o l’altro la manna pubblica si esaurisce.
Siamo precisamente a questo punto dell’evoluzione, il che spiega la collera dei contadini contro l’Europa che non li sovvenziona più a sufficienza, e ancor più quella contro l’Omc e tutto ciò che può assomigliare a un obbligo concorrenziale.
Uno dei punti forti del protezionismo consiste nell’agire in nome degli interessi nazionali. Come aveva dimostrato Bastiat nella sua famosa «petizione dei mercanti di candele», le lobby non si presentano mai come difensori di interessi particolari e corporativi, ma parlano in nome dell’interesse nazionale. Non difendono i loro propri privilegi, le loro professioni, ma l’insieme del popolo. Ecco come si trasformerà il protezionismo in un’opera culturale: sono le tradizioni nazionali e regionali che si vogliono salvaguardare.
Contro i MacDonald’s s’invoca il sapore del roquefort e del buon pane di campagna. Non si vogliono eliminare i concorrenti stranieri, bensì la malbouffe. In Italia non si sta forse reinventando lo Slow food per tornare a una tradizione alimentare ridotta a mal partito dalla mondializzazione dei prodotti, dei gusti e delle cucine? Vengono in tal modo risvegliati lo sciovinismo e l’orgoglio nazionale. Ma per trovarsi sul versante della xenofobia, del rifiuto dell’altro e, finalmente, del nazionalismo c’è soltanto una piccola soglia da superare.
È in un clima di nazionalismo esacerbato che si sono preparate le due grandi guerre mondiali. Quest’evidenza ha del resto ispirato la Carta dell’Avana e lo sforzo intrapreso sin dal 1945 per istituire le basi del libero scambio internazionale. Al Gatt sono occorsi più di cinquant’anni per eliminare l’essenziale delle barriere internazionali, ma non è riuscito a esorcizzare il demone protezionista, di recente rinforzato nella sua dimensione culturale.
Comunitarismo e umanitarismo.
Il ricorso all’arma culturale sfrutta due tipi di reazioni psicologiche alla mondializzazione: da una parte la nostalgia del gruppo, della comunità chiusa, dall’altra il sentimento di universale solidarietà, di appartenenza alla grande famiglia umana. Queste reazioni sono opposte, e nondimeno coesistono nel cuore e nella mente di molte persone. Il comunitarismo è una deviazione di un riflesso naturale.
Quando l’essere umano è integrato in una rete di relazioni ampie, lontane e impersonali, sente il bisogno di rinforzare i suoi legami, di rinsaldare la sua cerchia di affetti e di compartecipazione. I contadini del diciannovesimo secolo venuti a lavorare in fabbrica in città industriali sovrappopolate e insalubri sentivano una fortissima nostalgia delle loro campagne, dei loro villaggi, delle loro parrocchie. Hanno cercato nelle sètte socialiste il calore umano che mancava loro: «Il socialismo è la preghiera della città» (G. Leroy).
Oggi quelli che, loro malgrado, si trovano immersi in un mondo a essi estraneo si rifugiano in un’utopia della comunità, della compartecipazione, che esclude il mercato e il capitalismo. Tra l’economia di scambio e l’economia di compartecipazione, hanno fatto la loro scelta, senza capire che la compartecipazione è possibile soltanto se c’è qualcosa da condividere, e che condividere la miseria non ha mai eliminato la miseria. Proprio al contrario, lo scambio è il solo modo di relazioni creatore di ricchezze.
È prioritario rispetto alla compartecipazione, perché rende possibile la compartecipazione. Va inoltre precisato che la compartecipazione dev’essere volontaria e ragionata, e non arrivare al punto di dispensare o scoraggiare gli individui dall’intraprendere e dal lavorare. Il comunitarismo (MacIntire, Taylor) è deviante perché instaura una ripartizione obbligatoria e ugualitaria, negando la proprietà privata e l’interesse personale.
Assai bizzarramente, il comunitarismo può assumere una dimensione mondiale, e la «famiglia umana» è un tema di moda tra gli antimondialisti. Ora, questa grande famiglia sarebbe minacciata dai mercanti, dai finanzieri. I suoi elementi più deboli sarebbero abbandonati alla rapacità delle multinazionali: la prostituzione, la droga, la discriminazione sarebbero altrettanti flagelli legati alla generalizzazione della legge del denaro.
Una petizione contro la «mercificazione» circola ora in tutti i Paesi: non è normale che tutto sia retto da un mercato che dopotutto nessuno controlla. Quest’argomentazione si ricollega infine a quella del comunitarismo per il fatto di respingere e condannare i principi dello scambio mercantile e della proprietà privata. Ed è altresì una deviazione, dal momento che imputa allo scambio, al commercio e alla finanza dei vizi morali che essi non hanno.
Proprio al contrario, le virtù che formano la dignità della persona umana sembrano piuttosto svilupparsi nelle civiltà mercantili, mentre i regimi socialisti hanno determinato, più degli altri, la corruzione e lo schiacciamento dell’essere umano. La libertà degli atti dev’essere compresa nella prospettiva della dignità delle persone, ma, reciprocamente, non si è mai rispettata la dignità delle persone quando le si è private della libertà dei propri atti. La dignità dell’uomo è nella libertà, non nell’universale fraternità o nell’illusoria uguaglianza.
Nello sfruttamento delle reazioni che ho testé evocato l’influenza del marxismo-leninismo è senza dubbio visibile. Troviamo in primo luogo il tema della proletarizzazione: il capitalismo farà sparire le classi medie, la classe contadina, l’artigianato, perché l’accumulazione del capitale costringe o a diventare capitalisti, – e grandi capitalisti, – ovvero ad andare a ingrossare le fila dell’esercito proletario. Il capitalismo mondiale conduce fatalmente alla proletarizzazione mondiale, e alla destrutturazione sociale.
Troviamo poi il tema dell’alienazione: i proletari divengono giocattoli in mano ai capitalisti, la cultura, la religione e il diritto sono concepiti per servire gli interessi della classe politica dominante, e quest’ultima riduce il popolo alla schiavitù intellettuale, imponendo un sistema di «valori» destinato a perpetuare il dominio e lo sfruttamento.
La rivendicazione della giustizia sociale.
La teoria marxista spiega inoltre che se gli individui vengono proletarizzati e alienati dal capitalismo, essi vengono altresì impoveriti: il divario tra i redditi e i livelli di vita non fa che crescere. Per gli antimondialisti l’impoverimento è un tema di grande utilità. Consente infatti di andare incontro al desiderio di giustizia sociale che è stato sviluppato nelle mentalità del diciannovesimo secolo. Hayek ha mostrato le ambiguità del concetto di giustizia sociale (Legge, Legislazione e Libertà).
In nome della giustizia sociale si sono moltiplicate le politiche di prelievi obbligatori e di trasferimenti sociali, i cui effetti più visibili non sono consistiti nel migliorare il destino dei poveri, ma viceversa nel creare disoccupazione, frenare la crescita e permettere ad alcune categorie politicamente influenti di vivere a scapito dell’insieme della popolazione. «Lo Stato è la grande finzione sociale attraverso la quale ciascuno si sforza di vivere a spese di tutti gli altri» (Bastiat). Rimane il fatto che l’idea ugualitarista è assai diffusa, assai popolare, anche se nei Paesi ricchi il divario tra i livelli di vita si è singolarmente ridotto da cinquant’anni a questa parte.
Ora, ci vien detto, il commercio mondiale è tale da arricchire i Paesi ricchi e impoverire i Paesi poveri. Una simile credenza è condivisa da persone che non sono ideologi, e neppure avversari dichiarati dell’economia di mercato. Le cose stanno così nel caso dell’enciclica Populorum progressio, nella quale Papa Paolo VI riteneva che gli scambi internazionali fossero responsabili del sottosviluppo.
E anche, più di recente, nel caso della dichiarazione del presidente Jacques Chirac: «Come potrebbero i Paesi poveri commerciare con il resto del mondo senza essere preliminarmente aiutati?». A Bill Clinton che, durante la Conferenza del Cairo, perorava un cambiamento di politica nei confronti del Terzo Mondo con lo slogan Trade, not aid, Jacques Chirac rispondeva: Aid, not trade.
Tali idee, s’intende, hanno un’origine. Essa è duplice. La prima risale a Friedrich List, e alla teoria della «protezione dell’industria nell’infanzia». Tale teoria partecipa del punto di vista secondo cui gli scambi non possono organizzarsi se non fra partner che siano allo stesso livello di sviluppo, senza di che i più avanzati eliminano gli altri. Persino tra gli ideatori dell’Unione europea non c’è chi non utilizzi quest’argomento per eliminare i Paesi dell’Europa centrale e dell’Est, o per lo meno per ritardare la loro integrazione nella «corte dei Grandi».
La seconda origine è la tesi dell’imperialismo, proposta da Lenin e Rosa Luxemburg all’inizio del Ventesimo secolo. Poiché all’epoca era già evidente che il capitalismo non aveva approfondito il divario tra i redditi, poiché l’annunciato impoverimento non si era prodotto, neppure nella sua forma edulcorata di «impoverimento relativo» (i poveri si sarebbero arricchiti, ma meno rapidamente dei ricchi, cosicché si sarebbero sentiti sempre più poveri a paragone dei ricchi), era necessario trovare una risposta.
Bastava dire che ciò che aveva permesso ai Paesi ricchi di migliorare il destino del proletariato e di sormontare le «contraddizioni interne del capitalismo» non era nient’altro che il saccheggio del resto del mondo colonizzato dalle potenze occidentali. Lo sfruttamento aveva semplicemente cambiato dimensione: era divenuto internazionale, le nazioni capitaliste si arricchivano a scapito delle nazioni proletarie. di conseguenza la conclusione politica s’imponeva: bisognava por fine alla colonizzazione e all’imperialismo, e rimettere i Paesi capitalistici davanti alle loro proprie contraddizioni.
Negli anni Cinquanta, alcuni economisti hanno voluto sostenere «scientificamente» la tesi dell’imperialismo e hanno misurato (a modo loro) la «degradazione dei termini dello scambio» a detrimento dei Paesi del Terzo Mondo. Myrdal, Prebish e Singer hanno fatto passare il loro messaggio negli organismi internazionali, e segnatamente nella Cnuced (Commissione delle Nazioni unite per il commercio e lo sviluppo, a Ginevra).
Parallelamente, numerosi Paesi ricchi (a cominciare dagli stessi Stati Uniti) hanno inteso andare in aiuto dei Paesi poveri per riparare tutto il male che era loro stato fatto. Gli aiuti presero sia la forma di sovvenzioni e di prestiti per il tramite della Banca mondiale e del Fmi, sia della tolleranza doganale in nome del «doppio standard di moralità», che autorizzava i Paesi poveri a proteggersi contro le importazioni e costringeva i Paesi ricchi a sopprimere ogni protezione per le importazioni provenienti dai Paesi poveri (gli accordi di Lomé prevedevano le stesse disposizioni nei rapporti commerciali tra la Cee e l’Africa).
Con questo passato stantio pensavamo di aver chiuso. Ma gli antimondialisti l’hanno resuscitato. E mettono l’accento su due rischi, l’uno grave quanto l’altro: da una parte i Paesi poveri sono sfruttati dal capitalismo mondiale, che si è da poco installato nel Terzo Mondo per trarre profitto da abbondanti risorse naturali e, soprattutto, da una manodopera a buon mercato; dall’altra i produttori dei Paesi ricchi sono minacciati da queste delocalizzazioni, ma anche dalle esportazioni dei Paesi emergenti, dal momento che la concorrenza è falsata dal dumping sociale (Jacques Delors) praticato da questi Paesi.
Fino a un certo punto i due argomenti sono contraddittori, poiché le stesse persone sostengono che i Paesi poveri sono sfruttati (e dunque non sono in grado di nuocere, dal momento che sono le vittime del commercio mondiale), ma nel contempo sono pericolosi (dal momento che perturbano il commercio mondiale). La contraddizione scompare se si pensa che, nello spirito di coloro che adoperano tali argomenti, c’è un colpevole, e uno solo: il capitalismo, che assume aspetti differenti a seconda dei Paesi in esame.
Ciò che più conta, è però il fatto che questi argomenti sono privi di senso, poiché è incontestabilmente ai Paesi più aperti al commercio mondiale che il decollo è riuscito; Paesi nei quali il prodotto pro capite cresce a una velocità spettacolare. Ne consegue che in questi Paesi emergenti i divari fra i redditi si vanno riassorbendo, anche se le vestigia della recente povertà sono ancora visibilissime.
Quanto al dumping sociale, significa semplicemente che prima di acquisire «diritti sociali» e di prevedere confortevoli pensioni, gli individui più poveri desiderano acquisire il diritto di sopravvivere, e forse di preparare con grande modestia il futuro. Si potrebbe evidentemente obbligare gli abitanti dei Paesi poveri ad avere due automobili, una seconda casa e a mangiare caviale e fois gras: è quanto implicitamente auspicano coloro che dichiarano che è impossibile sostenere la concorrenza con gente «che si accontenta di una ciotola di riso» (a meno che non vogliano sostenere che gli europei dovrebbero prendere gusto alla ciotola di riso). Ma i bassi salari sono accettati e preferiti a nessun salario.
Quest’osservazione statica deve necessariamente essere completata da una prospettiva dinamica. Entro un certo termine di tempo, le famiglie fanno maggiori investimenti nell’educazione e nella formazione, e questo «capitale umano» frutterà in seguito redditi superiori. Entro un certo termine, senza giungere a una totale convergenza, i livelli di vita tra le persone appartenenti ai Paesi emergenti e quelle appartenenti ai Paesi sviluppati da antica data si avvicinano.
Non è forse il fenomeno che è stato osservato in Europa non molto tempo fa? La Spagna ospitava l’industria automobilistica perché i suoi salari erano del 25-30% più bassi che altrove; oggi i livelli sono paragonabili. E che dire del Giappone, del quale si è preteso che la sua prosperità provenisse dal bassissimo livello dei salari, mentre oggi il reddito pro capite è superiore a quello della maggior parte dei Paesi europei? La mondializzazione non è fonte d’«ingiusti» divari, ma al contrario tende a permettere a persone e popoli poveri di salire sul treno dello sviluppo e di raggiungere gli altri, anche se con uno sfasamento transitorio.
Anarchia e crisi di un’economia mondializzata.
Su questo punto sarò più breve, dal momento che le discussione è rigorosamente identica a quella che è stata condotta nel diciannovesimo secolo. Oggi gli antimondialisti traggono pretesto dai gravi squilibri registrati nella zona del Pacifico, in Brasile e in Russia nel corso dell’anno 1997. Gli uni (come James Tobin) vi hanno visto la conseguenza del cattivo funzionamento dei mercati finanziari mondiali e dalla spudorata speculazione sulle piazze borsistiche. Gli altri hanno tirato in ballo la dipendenza dei Paesi colpiti dalla crisi nei confronti del Fondo monetario internazionale, la cui politica consisterebbe nel lanciare i governi in azioni di privatizzazione sfrenate e destabilizzatrici.
È vero che il Fmi e la finanza hanno una grave parte di responsabilità nelle crisi in questione, ma tal responsabilità non è quella che viene in genere evocata. La crisi si è verificata in Paesi ove le Banche centrali hanno condotto, spesso con la complicità del Fmi, politiche di credito assolutamente aberranti. In Corea del Sud è la collusione tra il governo, le banche e i grandi gruppi industriali ad aver indotto a sostenere imprese che non avevano nessuna prospettiva di redditività; e un giorno o l’altro bisogna arrendersi all’evidenza. In questo caso non è il mercato a essere in questione, ma, al contrario, il mancato rispetto dell’imperativo della redditività, che è la vera sanzione del mercato.
In Indonesia il sistema bancario era interamente nelle mani di Suharto, e consentiva di finanziare operazioni immobiliari speculative per arricchire la famiglia del dittatore. Che cosa mai può avere in comune un fatto del genere con il mercato? In Tailandia o in Malesia, le banche centrali, imprudentemente impegnate in operazioni prive di legittimità economica, sono state sostenute a più riprese dal Fondo monetario internazionale, che in tal modo le ha indotte a perseverare nell’errore.
La mancanza di lucidità e di vigilanza del Fmi è stata tirata in ballo dalla maggior parte degli economisti che hanno analizzato queste crisi, e che ne hanno dedotto non una crisi del capitalismo, ma una crisi del dirigismo e delle ingerenze del potere politico nel mondo degli affari, – esattamente come nel 1929, del resto.
Dunque l’apocalisse capitalista non si è verificata, ma la scossa è stata sufficiente ad accreditare la tesi del pericolo di un mercato privo di regolamentazione, senza limiti, che dovrebbe necessariamente essere inquadrato e regolato da qualche autorità sovranazionale. Non sono stati persino i begli spiriti riuniti a Davos a sposare questa tesi, nell’evidente speranza di essere gli esperti che domani veglieranno sul benessere dell’economia mondiale?
Eccoci dunque ricondotti, come dicevo, alla famosa discussione: per evitare il disordine, il mercato deve forse essere inquadrato e regolato, oppure funziona come un ordine spontaneo, secondo la legge della «mano invisibile»? È da notare che, comunque sia, i disordini non sono mai stati eliminati da una qualsivoglia pianificazione o intervento pubblico, e che viceversa sono queste iniziative degli Stati a trovarsi all’origine di tutte le irregolarità economiche che si possono deplorare.
Dunque non è con una mondializzazione del potere economico che è possibile «padroneggiare» la congiuntura mondiale. Il mercato si stabilizza senz’alcun intervento. E se in quest’ambito i governi hanno qualche responsabilità, consiste nel garantire l’ambiente istituzionale indispensabile al mercato, e segnatamente i diritti di proprietà, la stabilità monetaria, la libertà d’intraprendere e di scambiare; in che misura i governi adempiono questa missione oggi, in che misura apportano la stabilità giuridica e sociale necessaria all’armonioso funzionamento del mercato?
La salvaguardia dell’ambiente.
Al di là dell’ingiustizia o dell’instabilità nate dalla mondializzazione, troveremo qui l’argomento più moderno, e più massiccio, della crociata degli antimondialisti. La mondializzazione sarebbe distruttrice dell’ambiente, fonte d’inquinamento e di saccheggio delle risorse naturali. Ecco la ragione essenziale per cui a essa si dovrebbe preferire un’organizzazione globale, capace di gestire uno «sviluppo sostenibile».
Ora, l’ecologia va di moda. Per un sano riflesso di conservazione e di rispetto della natura, certo, ma anche per effetto di un timor panico di fronte al futuro e al rischio. Un numero crescente di persone sono divenute adepti della filosofia del «rischio zero». Vogliono essere garantite contro ogni imprevisto, contro ogni incidente. Lo si vede attualmente con le mucche pazze e le epizoozie: il principio «di precauzione» trionfa.
Negli anni Cinquanta, il Club di Roma si era costruito una grande fama commentando il rapporto Meadows del Mit sul futuro del pianeta e sulla sovrappopolazione, l’esaurimento delle risorse naturali e l’aggravarsi dell’inquinamento. Aurelio Peccei e i suoi amici avevano persuaso gli europei che era necessario arrestare la crescita dei Paesi ricchi per lasciare un’eredità decente alle generazioni a venire.
Questo lavoro di propaganda neomalthusiana ha dato i suoi frutti con le numerose condanne della «società dei consumi» nate nei campus americani ed esplose a Parigi, alla Sorbona, nel 1968. Poiché nessuna di queste catastrofi si era verificata, poiché nel mondo il tasso di natalità si abbassava dappertutto, anche in Cina e in India, poiché le numerose scoperte di petrolio off-shore allontanavano di diversi decenni lo spettro dell’esaurimento energetico, poiché l’inquinamento arretrava in modo spettacolare in alcune regioni del mondo, l’aggressività ecologista era progressivamente diminuita.
La faccenda è stata però rilanciata con la Conferenza di Rio. Vi ritroviamo gli ecologisti tradizionali, ma i ranghi si sono infittiti grazie a un certo numero di intellettuali che erano stati marxisti fino a poco tempo prima, e da capi di Stato che avevano in comune il fatto di nutrire un odio accanito per gli americani. I dirigenti francesi sono presenti a Rio, soli rappresentanti di tutti i grandi Paesi.
I due grandi affari saranno quelli del riscaldamento del pianeta (evidentemente dovuto alle emissioni di gas carbonico di una civiltà che ha sacrificato tutto all’automobile) e della distruzione del patrimonio fisico dell’umanità, in particolare della foresta amazzonica. I Paesi ricchi, per alimentare la loro crescita, incoraggiano i Paesi poveri a entrare nel commercio mondiale per fornire le indispensabili risorse naturali, e a saccheggiare i propri territori, senza curarsi del domani. A questi pericoli che minacciano le generazioni attuali, ma ancor più quelle future, si deve rispondere con una pianificazione mondiale della crescita che sia suscettibile di garantire uno «sviluppo sostenibile», a un ritmo sufficientemente equilibrato e controllato per impedire i più gravi danni causati all’ambiente.
L’eco di questo slogan dello «sviluppo sostenibile» sarà considerevole e, come il Club di Roma quarant’anni prima, la condanna del capitalismo che sfrutta il pianeta e la dea Gaia dopo aver sfruttato il Terzo Mondo e le classi lavoratrici, è senza appello. E naturalmente a essere oggetto di tutte le critiche è il Paese che incarna il capitalismo: gli Stati Uniti minacciano il mondo intero, attraverso una mondializzazione che è stata inventata da loro e che funziona a loro esclusivo profitto.
Naturalmente in quest’argomentazione c’è un’aria di famiglia con la teoria dell’imperialismo, e infatti altro non è se non una semplice variazione di quella. Ma c’è ancora di più. In questo caso vengono evocate le scelte intergenerazionali, e si rimprovera al mercato di non saper gestire che le scadenze a breve termine, senza curarsi del lontano futuro. Si evoca anche il gusto per una vita sana, in armonia con la natura, gli uccellini, i fiori.
Il calcolo economico si coniuga elegantemente con i sentimenti bucolici. È la filosofia di Platone: il progresso è alle nostre spalle, il ritorno alla primitività è il ritorno alla purezza. È il trionfo di Jean-Jacques Rousseau: l’uomo è naturalmente buono, la società lo corrompe, la verità è nello stato di natura. La ricerca dello stato di natura, di una società senza conflitti, senza scarsità, senza peccato, ha ossessionato il diciannovesimo secolo.
Auguste Comte, Saint-Simon, Fourier sono stati costruttori di società perfette perché «naturali». Marx vi ha aggiunto un’inflessione tecnica, e che si vuole scientifica: la società senza classi segna la fine della storia perché il processo di evoluzione della materia è compiuto con il modo di produzione capitalistico, purché si epuri da questo capitalismo ciò che ha di ingiusto e di anacronistico: la proprietà privata.
La proprietà privata è le bestia nera degli antimondialisti. Essi indubbiamente ignorano i danni causati all’ambiente nei Paesi collettivisti. Ignorano anche che la proprietà privata è il miglior modo di gestire le risorse scarse, perché introduce la responsabilità nel comportamento degli uomini, mentre la regolamentazione crea soltanto noncuranza, burocrazia e corruzione. Ignorano infine che l’uomo è «la nostra ultima possibilità», come scriveva Julian Simon, il miglior demolitore della tesi dello sviluppo sostenibile.
Julian Simon ha individuato l’errore fondamentale, cosciente o inconscio, dei malthusiani di tutti i Paesi, di tutti i secoli. Esso consiste nel considerare l’economia come un gioco a punteggio zero su uno stock di risorse dato. Gioco a punteggio zero, l’economia non può elargire un profitto agli uni se non defraudando gli altri. Viceversa l’economia è un gioco a punteggio positivo: dopo lo scambio, i due scambisti si trovano a essere più soddisfatti di prima. Infatti la soddisfazione dei bisogni è la miglior definizione che si possa dare di una «ricchezza».
La ricchezza non è né un’accumulazione di denaro (che è soltanto un comodo mezzo per far circolare diritti di proprietà), né una moltiplicazione della materia (alla maniera dei fisiocratici che vedevano un «prodotto netto» soltanto nell’attività agricola e consideravano «sterili» tutte le classi diverse da quella dei contadini). Il valore nasce dallo scambio dei servizi, e le «risorse naturali» non esistono in quanto tali, poiché esse non hanno valore se non dopo che gli uomini le hanno trasformate in servizi resi ad altri uomini.
Per converso, gli uomini sanno scambiarsi servizi che alla terra non devono nulla. Solo lo spirito umano è creatore di ricchezze, ed è per questo che la proprietà privata dev’essere riconosciuta e rispettata, poiché consente a ciascuno di assegnare a se stesso la parte di sé che ha investito nella ricchezza che è stata prodotta.
Così, come tutti gli altri argomenti invocati dagli antimondialisti, anche se è più penetrante e più seducente degli altri, la salvaguardia dell’ambiente è un argomento fallace, un pretesto per abbattere il capitalismo e, dietro il capitalismo, gli Stati Uniti e i Paesi che adottano il «modello anglosassone». Ma è sufficiente, per confutare le tesi antimondialiste presso l’opinione pubblica, dimostrare la loro vacuità e smascherare la loro autentica origine e la loro vera natura? Non credo: bisogna anche persuadere la gente a proposito del significato autentico e delle prospettive della mondializzazione.
Che cosa dire a favore della mondializzazione?
La mondializzazione è gravida di promesse di prestazioni economiche e di progressi sociali quanto la Rivoluzione industriale, cui non smetterò di paragonarla. Ma per godere i pieni benefici della mondializzazione, sarebbe senza dubbio opportuno riformare un complesso di istituzioni, di mentalità, di costumi. Oggi, infatti, i benefici influssi della mondializzazione sono occultati o sminuiti dal pesante retaggio istituzionale, intellettuale e morale del Ventesimo secolo: il secolo dello statalismo, del collettivismo, del nazionalismo, dell’ugualitarismo, ecc.
Le promesse della mondializzazione.
La mondializzazione segnerà senza dubbio un progresso decisivo nelle sfere dell’economia, della politica e della morale. In realtà tali progressi sono quelli che il libero scambio apporta naturalmente, ed erano già stati evocato nei secoli diciannovesimo e Ventesimo da pensatori brillanti come Montesquieu, Turgot, Adam Smith, Benjamin Constant e Frédéric Bastiat. Nell’ambito dell’economia, le prestazioni legate alla mondializzazione non provengono, come sostiene la teoria ricardiana, dalla specializzazione internazionale.
Ricardo ha screditato la scienza economica e portato acqua al mulino degli antimondialisti lasciando intendere che la virtù del commercio internazionale consisteva nello specializzare ciascun Paese nella produzione per la quale deteneva il vantaggio comparato più elevato. Nel suo famoso esempio detto dei «due Paesi-due prodotti», arriva alla conclusione che l’Inghilterra deve accontentarsi di fabbricare panni mentre il Portogallo deve occuparsi esclusivamente delle sue vigne.
Oggi troviamo cervelli eminenti, come Maurice Allais (il solo premio Nobel di Scienza economica, ahimé), predire non soltanto la scomparsa dell’agricoltura francese, ma anche quella della fabbricazione automobilistica o aeronautica francese, e per i francesi la sola possibilità sarebbe quella di rifugiarsi nella produzione di oggetti di lusso (malgrado il fatto che i sarti e i vini italiani facciano loro una pericolosa concorrenza).
Ora, se osserviamo gli attuali flussi commerciali, ci accorgiamo che l’80% degli scambi sono interni a ciascun ramo della produzione intra-branches (si dice anche «scambi incrociati), cioè riguardano prodotti che fanno parte dell’offerta di ambedue i Paesi coinvolti nello scambio.
Come ha brillantemente dimostrato Victoria Curzon-Price, un marziano che guardasse agire i terrestri resterebbe ben presto sconcertato: vedrebbe i francesi vendere automobili agli italiani, che ne producono, proprio nello stesso momento in cui le macchine italiane sono vendute in Francia, in Inghilterra o in Germania, che a loro volta le producono, e le vendono in questi altri Paesi. Fatto si è che il beneficio apportato dal commercio internazionale non è la specializzazione, il cui livello è basso, e peraltro decrescente, ma la concorrenza. Il commercio mondiale è una «lavatrice per imprese»: vi penetrano coperte di fango, di gravami, di costi, e ne escono belle pulite, sbarazzate dei pesi che sopportavano.
Bisogna notare, del resto, che il punto di vista ricardiano e neoclassico è indebitamente nazionalista. Non sono le nazioni che commerciano, e che si specializzerebbero, ma determinate imprese. Possono esserci imprese molto dinamiche in Paesi con una bilancia commerciale globalmente deficitaria. Forse che per il benessere di un Paese, del resto, la «bilancia» significa qualcosa?
Perché gli americani funzionano da parecchi lustri con una bilancia in disavanzo, come d’altronde, un tempo, gli inglesi? La bilancia è un’invenzione dei mercantilisti, preoccupati di vedere l’oro e l’argento fuggire all’estero per pagare eventuali saldi passivi nati dalle transazioni commerciali. I mercantilisti preferiscono ridurre il commercio (grazie a un rigido controllo da parte dello Stato) piuttosto che beneficiare delle produzioni offerte a un prezzo migliore nel mondo intero. Frédéric Bastiat ha ridicolizzato i teorici della bilancia dimostrando che per i consumatori nazionali le importazioni sono un affare migliore che le esportazioni.
Frédéric Bastiat aveva però deliberatamente preso le parti dei consumatori contro quelle dei produttori e dei governanti. Ecco in che cosa il libero scambio è fonte di progresso per l’insieme dei popoli: grazie alla concorrenza, esso costringe i produttori a mettersi completamente al servizio dei consumatori. Quindi la mondializzazione significa essenzialmente mettere a disposizione un numero impressionante di beni e servizi alle migliori condizioni per una parte crescente del mondo intero.
Questa forma di progresso è passata sotto silenzio. di solito il progresso non è considerato se non attraverso il personaggio del produttore (imprenditore o lavoratore). Si immagina volentieri che il miglioramento delle condizioni di vita si produca grazie all’aumento dei redditi. Ma dal momento che il potere d’acquisto è solo la comparazione dei redditi e dei prezzi, un calo dei prezzi ha sul piano aritmetico lo stesso effetto dell’aumento dei redditi.
Se ne potrebbe quindi concludere che le due forme di progresso, a mezzo dei redditi o a mezzo dei prezzi, sono equivalenti. Ma le cose non vanno affatto così. Dal punto di vista psicologico, la gente preferisce l’aumento dei redditi al calo dei prezzi. L’uno è immediato, personale, visibile, l’altro è immediato, diffuso e impercettibile. «Meglio un uovo oggi che una gallina domani», si dice. La gente preferisce una migliore busta paga a un calo dei prezzi nei negozi.
Dal punto di vista della ripartizione dei frutti della crescita, i risultati non sono affatto gli stessi. Un aumento dei redditi remunera i produttori per gli aumenti di produttività che hanno realizzato: salariati, investitori e proprietari intascano una maggior quantità di salari, d’interessi e di profitti pagandosi sul valore aggiunto che hanno creato; e questo indubbiamente li stimola.
A paragone di ciò, il calo dei prezzi consiste nel chiedere ai produttori di abbandonare del tutto o in parte gli aumenti di produttività per metterli a disposizione della clientela. In questo caso il progresso si diffonderà in tutti i canali della società, e giungerà fino ai più lontani, ai più miseri, alla «grande famiglia umana», come diceva Bastiat, che precisava: «La concorrenza è la forza umanitaria che strappa il progresso, man mano che esso si realizza, dalle mani dell’individualità, per farne il comune retaggio della grande famiglia umana».
In queste condizioni, il dibattito intorno alla mondializzazione assume una dimensione notevole: altro non è se non il vecchio conflitto d’interessi fra produttori e consumatori. E si comprende la mobilitazione dei gruppi di produttori, sia industriali che agricoli.
Oltre al merito di «socializzare», di «democratizzare» il progresso economico, la concorrenza ha anche il vantaggio di stimolare incessantemente l’innovazione. Nei mercati poco attivi e poco concorrenziali, le imprese hanno la tendenza ad «addormentarsi sugli allori del profitto» (Schumpeter). Con la mondializzazione c’è sempre qualche concorrente reale o potenziale che può trarre profitto dalla passività di un’impresa incapace di innovare.
Tutti sono dunque spronati a essere in anticipo di un’idea, di una tecnica, poiché in un tal clima soltanto l’innovazione permette di trarre profitto per un breve momento dalla posizione dominante e privilegiata che l’innovazione conferisce. In seguito gli imitatori verranno a contestare gli innovatori e i margini dei benefici si scioglieranno come neve al sole. Bisogna quindi innovare in permanenza, se si vuole mantenere sul lungo periodo un’alta redditività dell’impresa.
Questo pungolo della concorrenza è acuito dalla mondializzazione della finanza. Infatti i capitali sono permanentemente in cerca di alta redditività. La massa di capitali detenuti, in particolare, dai fondi pensione si sposta verso le imprese e le attività più competitive. E in un’impresa si sa che, al di sotto di una certa soglia di redditività, le quotazioni delle azioni possono improvvisamente cadere e i direttori in carica rimetterci la propria posizione: l’«autorità amministrativa» delle imprese è quindi divenuta, soprattutto per le grandi società per azioni, una necessità assoluta, e spinge a una produttività che cresce senza sosta.
Certo, si dà qualche abuso, in questo tipo di approvazioni talvolta frettolose e sconsiderate, o in questa ricerca di altissime prestazioni (come si vede con l’evoluzione del Nasdaq nella fase attuale). Ma il principio resta comunque sano, poiché torna a porre l’impresa sotto il controllo del profitto, cioè sotto il controllo della concorrenza, cioè sotto il controllo della clientela.
Se la mondializzazione è una promessa di accresciuta prosperità per i Paesi ricchi, è altresì la sola possibilità di sviluppo per i Paesi poveri. Contrariamente a quanto sostiene la tesi della degradazione dei termini dello scambio, a progredire sono i Paesi più aperti. Come abbiamo visto, per certi abitanti del Terzo Mondo l’integrazione nella rete degli scambi mondiali è l’occasione di avviare un progresso personale.
È falso pretendere che le imprese d’Asia, d’Africa o d’America Latina non abbiano alcuna possibilità di entrare nel mercato. C’è sempre qualcosa da vendere, e l’ingegnosità dei più poveri che vogliono strapparsi alla miseria è davvero notevole. Se alcuni asiatici, africani o latino-americani vegetano nella più totale miseria, ciò dipende dal fatto che il loro ambiente istituzionale, e soprattutto il loro governo, li hanno schiacciati per meglio sottometterli, e li hanno rinchiusi in un sistema di economia diretta e «protetta».
Per i Paesi ricchi sarebbe criminale privare i poveri di questi benefici della mondializzazione. Predicare il rallentamento della crescita è un lusso che possono pagarsi gli americani o gli europei, ma per gli altri è un dramma, poiché la loro sopravvivenza e il loro decollo dipendono dalla possibilità di avere accesso agli scambi esteri. I Paesi ricchi non possono trarsi d’impaccio praticando una sorta di pubblica assistenza che peraltro è entrata in una fase di rapido declino.
Poiché la pubblica assistenza non ha giovato ad altri che a una minoranza di dirigenti, e mai i popoli ne hanno risentito il sia pur minimo effetto. Regalare un pesce non è un metodo efficace: bisogna insegnare a pescare.
Curiosamente, la concorrenza e i mutamenti di prospettive economiche da cui la mondializzazione è necessariamente accompagnata, hanno incidenze politiche di grande momento. Infatti la mondializzazione non si limita a creare una concorrenza tra imprese, ma ne crea anche una fra Stati, e avrà quindi il duplice effetto di liberare gli Stati dalla pressione dei gruppi d’interesse e di alleggerire la parte dello Stato nella vita sociale. Finché operavano sovranamente all’interno delle loro frontiere, gli Stati erano gli artefici e i complici del protezionismo.
Ma i trattati commerciali, soprattutto allorché erano accompagnati dalla clausola della nazione più favorita, già avevano diminuito nel diciannovesimo secolo il grado di libertà dei governi, costretti a rispettare gli impegni presi. Adesso ogni sforzo fatto dagli Stati per sottrarre i loro cittadini alle costrizioni del mercato rischia di essere vano. Lo si vede bene in Francia. È nel nome del trattato di Maastricht e della costruzione dell’Europa che era stato abbandonato quanto di più oltranzista era presente nella politica agricola comune e nella protezione dei contadini francesi. Nel nome della concorrenza la Francia è stata costretta a privatizzare le sue telecomunicazioni, la Régie Renault, le banche nazionalizzate, ecc.
Finalmente gli Stati non possono più niente per proteggere i loro cittadini. Ecco quel che potrebbe allentare la morsa nella quale erano prigionieri, e ridare alla democrazia un volto più simpatico di quello della distribuzione di prebende e di privilegi agli amici e ai sostenitori del potere. A loro volta gli Stati dovranno allentare la stretta sui privati cittadini, e soprattutto sugli imprenditori.
Nella competitività internazionale, infatti, il vantaggio sarà dei cittadini degli Stati che avranno la mano fiscale e regolamentare più leggera. L’armonizzazione delle imposte e delle legislazioni si farà necessariamente nel senso dell’alleggerimento, poiché le economie sono più competitive quando sono più libere, come dimostrano le statistiche sugli «indici di libertà economica». Quindi vi sarà necessariamente una riconsiderazione del ruolo dello Stato, che si limiterà sempre più a quelli che, fra i suoi compiti, costituiscono le sue «prerogative regie», come la polizia, la giustizia e la difesa. Sarà la fine dello Stato assistenziale.
Un certo numero di socialisti se ne rendono conto e deplorano questo stato di cose. Possiamo citare a mo’ di esempio il recentissimo libro Notre État, scritto da una ventina di enarchi, tutti alti funzionari francesi: «Il buon vecchio Stato giacobino da cent’anni ha mostrato tutto ciò di cui era capace, ora si esaurisce e fa pena vederlo.»
L’ineluttabile ritiro dello Stato assistenziale in virtù della mondializzazione è sul punto di modificare il comportamento degli individui, e di riportare in auge il senso delle responsabilità, il riconoscimento del merito e della competenza, il gusto dell’iniziativa. Invece di farsi a pezzi per ottenere dal governo una più congrua frazione del prodotto nazionale, le professioni e gli individui penseranno infine a vivere delle loro complementarità e trovando una buona intesa.
Montesquieu vantava i benefici morali del doux commerce. Non c’è nulla, fino alle relazioni tra i popoli, che non si pacifichi. L’opera comune realizzata in Europa e il libero scambio instaurato dal trattato di Roma hanno fatto, per la comprensione tra francesi, tedeschi, italiani e inglesi, più di qualsiasi programma politico.
Fatto si è che il commercio costringe a tener conto degli altri. Non si sviluppa se non in un clima di reciproca fiducia, e nel rispetto dei contratti e di altre regole del gioco sociale. Mentre l’economia amministrata genera l’ignoranza e la corruzione, l’economia mondiale esige vigilanza e onestà. È davvero a torto che si continua a presentare il mercato come una sorta di giungla nella quale regnerebbe la legge del più forte. Non c’è niente di più civilizzato, di più civile, del mercato, perché obbliga gli interessi personali ad armonizzarsi invece di scontrarsi, perché richiede un grande rigore nei rapporti reciproci, un rispetto dei diritti e dei doveri.
Tutti i filosofi della libertà, da Locke e Adam Smith fino a Hayek e a Bruno Leoni, hanno insistito sul legame necessario fra la libertà e il diritto. Liberare gli scambi non premia i più forti, bensì i migliori, coloro che rendono i servigi più utili alla comunità. Ecco il vero umanitarismo, il vero universalismo. Come diceva Bastiat, è la famiglia umana nel suo insieme che in un clima di concorrenza e di apertura trae vantaggio dal progresso. In tal modo si arriva a quella situazione di «bene comune» che la tradizione cristiana ha raccomandato per così tanto tempo, dal momento che in essa gli uomini sono proclivi alla cooperazione, alla comprensione, alla cura degli altri.
Se queste ultime considerazioni aprono prospettive assai felici, ci mostrano anche tutto il cammino da percorrere. Oggi siamo ancora lontani dal doux commerce, la concorrenza è in pericolo, gli Stati non vogliono lasciare la preda. Vale a dire che l’accesso ai benefici della mondializzazione non sarà né immediato né meccanico: si dovrà procedere alle indispensabili riforme che permetteranno di voltare definitivamente la pagina dell’economia politica, della società politicizzata e dell’umanità degradata.
Le indispensabili riforme.
Francis Fukuyama ha bruciato un po’ troppo le tappe, quando ha annunciato, dopo la caduta del Muro di Berlino, che stavamo per vivere la «fine della storia». Quel titolo suggeriva che la transizione al mercato e l’instaurazione della mondializzazione si sarebbero fatte senza indugi e senza difficoltà. Undici anni dopo, si ha l’impressione di essere avanzati a piccolissimi passi. Subiamo infatti la «tirannia dello statu quo», come dice Milton Friedman. Le forze conservatrici sono al lavoro.
Coloro che sono vissuti per lo Stato e grazie allo Stato in tutto il corso del Ventesimo secolo non vogliono dichiararsi battuti, e non smettono di condurre azioni ritardanti. Queste proroghe vanno a vantaggio degli antimondialisti, non solo perché i benefici della mondializzazione tardano a farsi sentire, ma anche e soprattutto perché si imputano tutti gli errori, gli squilibri e le ingiustizie presenti nel mondo contemporaneo all’«ondata liberale», alle privatizzazioni e al mercato, – proprio nel momento in cui questi mali sono dovuti essenzialmente alle lentezze o ai rifiuti della mondializzazione.
L’esempio più caratteristico è quello della Russia, ove si denunciano volentieri i danni del capitalismo «selvaggio» e dell’economia di mercato in un Paese nel quale nessuna delle riforme indispensabili alla transizione è stata seriamente avviata. Non basta sciogliere il Partito comunista dell’Unione Sovietica per trovarsi in un universo capitalista e mercantile (del resto il Partito comunista è stato nel frattempo resuscitato!).
La prima serie di riforme da mettere in cantiere per arrivare a una vera mondializzazione è nella sfera istituzionale. Il mercato e il libero scambio esigono, come minimo, una moneta sana, diritti di proprietà privata precisi e rispettati, tribunali capaci di far regnare il diritto, una riduzione drastica del settore pubblico e della spesa pubblica, banche e borse attente alla redditività, un mercato del lavoro fluido e fondato sul libero contratto. La presente enumerazione è impressionante, ma la maggior parte dei teorici del mercato hanno insistito sulla necessità di un tale ambiente istituzionale. Il mercato non funziona da sé, né senza costi. Esistono «costi marginali di trasformazione», come ha scoperto Ronald Coase.
Questa lunga lista di riforme consente di verificare che neppure le nazioni più ricche sono conformi al mercato da un punto di vista istituzionale. Negli Stati Uniti, in Canada o in Europa occidentale, gli attacchi alla proprietà privata sono numerosi, settore pubblico e bilanci dello Stato sono ancora assai pesanti, i mercati del lavoro sono sovraregolamentati e sovracontrollati. E che dire, allora, degli altri Paesi, quelli che erano collettivizzati e pianificati dodici anni or sono?
E di quelli che, come Cuba, la Cina, le dittature dell’Africa o del Medio Oriente, non hanno neppure rinunciato al loro sistema aberrante e inumano, ma continuano ugualmente a pesare nella diplomazia mondiale e a falsare il gioco nelle istanze internazionali?
Nella maggior parte dei casi l’esito è incerto. Si può immaginare che in mancanza di queste riforme un certo numero di Paesi e blocchi interi di Paesi si autoescluderanno dal concerto della mondializzazione, e saranno in grado di nuocergli. Ma si può anche sperare che la dinamica della mondializzazione finisca per imporre le riforme cui è occorso un così lungo tempo per definirsi e caratterizzarsi. L’esempio di Cuba induce al pessimismo, quello, più recente, della Bulgaria, ridà fiato alla speranza.
Le riforme istituzionali hanno tante più probabilità di essere avviate in quanto le mentalità si saranno a loro volta evolute. Ora, le mentalità sono state forgiate nel Ventesimo secolo dai sistemi educativi e dalle modalità della protezione sociale. L’educazione è divenuta affare di Stato, e la formazione della gioventù non si è più svolta sotto la buona guardia delle famiglie, ma viceversa sotto il controllo di funzionari che erano per lo più ideologici e irresponsabili.
Scolari, liceali e studenti universitari hanno progressivamente disimparato il lavoro, l’emulazione, la cortesia, l’onestà, e gli istituti che frequentano sono centri direzionali della violenza, della droga e di tutte le devianze. In certi Paesi emergenti, per contro, si vedono i genitori investire la maggior parte delle loro gracili risorse negli studi e nel perfezionamento dei propri figli. In tal modo accumulano un «capitale umano» che Gary Becker ha dimostrato essere il fattore essenziale, se non esclusivo, dello sviluppo.
Quanto all’assistenza sociale, nella maggior parte dei Paesi ricchi è stata organizzata in modo tale da condurre gli individui a comportarsi come assistiti. I «diritti sociali» si sono moltiplicati: copertura dei periodi di malattia, pensioni, garanzia del posto di lavoro, della casa, redditi e salari minimi, ecc. Progressivamente, il legame tra lo sforzo produttivo del lavoratore, del risparmiatore o dell’imprenditore è stato spezzato.
Quando si può guadagnare altrettanto denaro (se non più) restando a casa invece di andare a lavorare, perché cercare un lavoro? A dispetto degli sforzi recenti che sono stati fatti per passare dal Welfare al Workfare, in molti Paesi è spesso tuttora vantaggioso essere disoccupato piuttosto che impiegato. Oggi, certo, questo tipo di protezione sociale sta andando a rotoli. Da una parte ci si è resi conto che si stava trasformando l’assistenza sociale in una «trappola per poveri», e che le persone più assistite sprofondavano nella miseria.
D’altra parte, nei Paesi che hanno da poco ridotto (a causa della concorrenza mondiale) i prelievi obbligatori e la spesa pubblica non c’è più molto denaro da redistribuire. Infine alcuni sistemi pensionistici, come le pensioni per ripartizione, sono sul punto di esplodere, e a tali sistemi il cambio è dato, almeno parzialmente dalla capitalizzazione, più conforme allo spirito del mercato e più adatta all’esercizio della responsabilità personale.
Da questo punto di vista, la Francia rappresenta un bel bastione di resistenza, e la famosa «previdenza sociale» è mantenuta da anni a prezzo di duri sforzi, a colpi di sovvenzioni e di prelievi sempre più considerevoli. Questa ostinazione dimostra certo l’irresponsabilità dei dirigenti, ma anche la totale incoscienza dei «soggetti contribuenti», che non vedono arrivare l’esplosione, tuttavia prossima e ineluttabile, e sono tuttora persuasi che una riforma del sistema attuale sarebbe gravida di notevoli rischi, di perdite di reddito e di forti ingiustizie, mentre è proprio il sistema attuale a condurre per il più breve cammino a queste funeste prospettive.
Ecco, peraltro, ciò che pone il già ricordato dibattito sul dumping sociale sotto una luce nuova. In tutti i Paesi ad alta «assistenza sociale» forte è la tentazione di costringere le altre nazioni a innalzarsi allo stesso livello. I francesi e i tedeschi vorrebbero costringere i polacchi, i romeni, e domani i tailandesi o gli abitanti di Mauritius a pagare oneri pesanti quanto quelli che loro stessi sopportano. Ma chi li seguirà lungo questa stupida via?
In realtà si tratta dunque di un alibi per frenare la mondializzazione, adducendo a pretesto il fatto che non si può commerciare se non con partner dello stesso livello, e che concorrenza significa uguaglianza dei competitori. Ma che cos’è una competizione in cui tutti i concorrenti sono uguali? La confusione tra concorrenza e uguaglianza è certamente un errore d’analisi, ma è soprattutto un’arma politica assai efficace nelle mani degli antimondialisti.
La verità è che presto o tardi occorrerà farla finita con i «diritti sociali», e sostituirli con procedure di assicurazione e di mutualità ben più efficaci e assai meno costose, come ha dimostrato l’esperienza della seconda meta del diciannovesimo secolo. Bisogna cancellare dalla lista dei «diritti dell’uomo» le aggiunte che sono state fatte dall’Onu nel 1948, e tornare alla dichiarazione del 1789. Gli uomini perdono la libertà, quando si aspettano dalla società che essa se ne faccia carico e li garantisca contro tutti i rischi.
Quest’evoluzione delle mentalità, questo rinvio degli uomini liberi alle loro responsabilità, dovrebbero altresì permettere di cambiare i costumi. È vero che, come si è visto, la mondializzazione spaventa perché sarebbe una rottura dei legami comunitari, una distruzione delle tradizioni locali, un lassismo generalizzato e un libero gioco degli egoismi.
Ma gli effetti distruttivi della mondializzazione non saranno invece quelli delle società collettivizzate e statalizzate? È lo Stato assistenziale che ha inferto qualche colpo fatale alla famiglia. È l’economia diretta che ci ha fruttato corruzione e truffa. È la regolamentazione che ha creato il mercato nero. È la pubblica assistenza che ci ha resi pigri e sottomessi. E perché diamine si vuole una mondializzazione che riesce appena a balbettare, e che è ostacolata da tanti conservatorimi?
Resta comunque vero che l’immersione in una società mercantile pone esigenze morali particolarmente forti. Per praticare il mercato e, nel contempo, completarlo efficacemente. Per praticarlo, bisogna costringersi al rispetto degli altri: bisogna associare la libertà e la responsabilità, avere il coraggio delle proprie azioni, accettare le sanzioni, rispettare le differenze. Bisogna bandire l’ugualitarismo, ispirato dalla gelosia, dall’invidia, dall’avidità. Tutte queste virtù si concentrano in una sola che, trattandosi del mercato, è giudicata cardinale da Hayek: l’onestà.
Il mercato più efficiente e competitivo, benché il suo campo d’azione sia più esteso di quanto generalmente non si creda, non risolverà però tutti i problemi. Esistono atti umani che non dipendono dalla logica mercantile. dipendono in particolare da una logica che sotto gli attacchi dello Stato assistenziale ha molto sofferto: la logica comunitaria. La solidarietà volontaria è il naturale completamento del mercato, va a smussarne gli spigoli, a edulcorarne le dure sanzioni. Nel gioco economico vi saranno sempre degli emarginati, e non bisogna chiedere alla mondializzazione di condurci a una società perfetta, totalmente armonica e giusta.
In tal caso tocca a uomini liberi sentirsi responsabili nei confronti di coloro che si trovano in una condizione nella miseria fisica, ma anche di avvilimento morale. Questo vien fatto in modo naturale nel quadro della famiglia, la più antica e la più efficace, nonché la più accogliente delle comunità di vita e di compartecipazione. Ma questo si fa anche nelle comunità associative, confessionali, professionali, e nelle collettività locali. Ritessere le maglie della rete sociale, rinvigorire la «società civile» che nel diciannovesimo secolo ha suscitato l’ammirazione di Tocqueville in America: ecco l’obiettivo e il dovere morale degli uomini di buona volontà.
Tutti quelli che, a immagine di Hayek o di Becker, hanno provato a immaginare i cambiamenti morali intervenuti a causa della mondializzazione sono giunti alla stessa conclusione: gli individui cercheranno tanto più di stringere ulteriormente i legami familiari e comunitari quanto più saranno immersi in una rete impersonale e lontana. Come l’albero, l’uomo ha bisogno di radici. E come l’albero che spiega la sua chioma, l’uomo ha bisogno di radici più profonde.
Questo saggio prospettico sarebbe sconveniente e ridicolo se non fossimo proprio alla svolta del nuovo secolo e del nuovo millennio. E se non ci trovassimo proprio nel momento della storia in cui una grande e bella avventura attende l’umanità. Ma all’avventura della mondializzazione dobbiamo fare eco con un guizzo di umanità, con un «supplemento d’anima». È in questo registro che dobbiamo parlare della mondializzazione, invece di farci prendere nelle trappole della propaganda delle corporazioni e della dialettica dei nostalgici del totalitarismo.
(traduzione dal francese di Filippo Scarpelli)