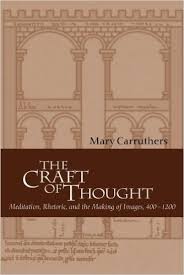 Il Sole 24 Ore 18 luglio 1999
Il Sole 24 Ore 18 luglio 1999
Pubblicato dalla Cambridge University Press un affascinante testo sui luoghi del pensiero, sui modi della creazione di quei «ritratti» che funzionano come immagini del passato e sul vero nemico dei ricordi: non l’oblio, bensì il vagare disordinato della mente, quello che i latini chiamavano «curiositas»
di Lina Bolzoni
E’ difficile dimenticare. Specie quando si tratta di qualcosa che ci ha preso fortemente, che ha messo in gioco sentimenti e passioni. Per questo Ovidio dedica una parte dei suoi Remedia amoris proprio alle tecniche per controllare la memoria, insegna cioè a guardarsi dai luoghi, ma anche dal dolce suono della cetra e della lira, dalle chiacchiere degli amici, dagli spettacoli che possono risuscitare i fantasmi dell’amore.
Ma spesso cercare di dimenticare non ha senso, perché rischiamo di distruggere, insieme con le immagini che ci fanno ormai soffrire, una parte di noi, della nostra identità. Sarebbe come sforzarsi — diceva Bernardo di Chiaravalle — di radere via da una pergamena delle parole e finire col distruggere la pergamena stessa, che è ormai imbevuta dell’inchiostro con cui quelle parole sono state scritte. Quel che Bernardo consiglia è invece di ridisporre i ricordi nel teatro della nostra mente, così da riuscire a guardarli da un altro punto di vista (che riesca a modificare la nostra intendo, la nostra disposizione emotiva). Così ad esempio, dice Bernardo, la fiducia nel perdono di Dio permetterà di fare i conti in modo meno angoscioso con la memoria dei peccati.
L’esperienza materiale della scrittura su pergamena, così lontana dalla nostra, viene qui usata per descrivere un gioco fra memoria e oblio che invece ancora ci riguarda da vicino. Quello di Bernardo è solo uno dei moltissimi esempi citati in un libro affascinante pubblicato di recente da Cambridge University Press: The Craft of Thought. Meditatio, rhetoric, and the making of images 400-1200 (La forza del pensiero. Meditazione, retorica, e la costruzione delle immagini dal 400 al 1200), scritto da Mary Carruthers, una medievista che insegna alla New York University.
Al centro del libro sta la riscoperta di una lunghissima tradizione, che è stata viva soprattutto in ambiente monastico, ma che va ben al di là, in quanto riguarda infatti alcune esperienze fondamentali, e cioè il modo di leggere, di pensare, di scrivere e di educare. L’autrice prende le mosse dalle tecniche della meditazione monastica per mostrare come esse insegnino a plasmare la propria mente, a creare una mappa di “luoghi”; qui si collocano i ricordi delle cose lette e sentite, di qui si derivano il materiale e le associazioni necessarie per nuovi pensieri, nuove parole, nuove opere.
La “forza del pensiero” cui il titolo allude sta appunto in questo: nella capacità di costruire nella propria mente templi, tabernacoli, palazzi e giardini; nel fare della propria memoria un archivio capace di riprodursi, e di generare. È una memoria di cui la Carruthers sottolinea la differenza rispetto alla memoria classica: è una memoria che si nutre della Bibbia, o meglio di alcuni passi della Bibbia che si imprimono nella mente e nel corpo così da costruire una griglia di loci cui tutto si riconduce, e da cui tutto prende le mosse; è una memoria che ha come oggetto la Gerusalemme celeste, e il mondo eterno dell’Aldilà: è una memoria che mobilita le passioni e lega fortemente la lettura alla scrittura, la conservazione all’invenzione.
Questa memoria richiede un costante impegno di concentrazione e di elevazione morale; suo nemico non è tanto l’oblio, ma piuttosto la curiosìtas, il vagare disordinato della mente, la fornicatio con la realtà sensibile. Il monaco — e il fedele — costruiscono percorsi, scanditi da tappe, o innalzano scale, i cui gradini arrivano fino al cielo, come nella visione di Giacobbe (Gen., 28); operano secondo un metodo che, unisce la geometria dello schema (il diagramma, la scala, la mota) con il proliferare delle immagini, spesso sanguinolente e corpulente.
Così ad esempio nel V secolo la Psxcomachia di Prudenzio usa Virgilio per cantare la nuova materia epica cristiana, e cioè la battaglia tra vizi e virtù; in questo modo parte da un patrimonio di memoria saldamente collocato nella mente del pubblico e lo riveste di nuovi significati e di una diversa funzione: vizi e virtù sono associati a episodi e personaggi della Bibbia (secondo un procedimento che Dante ci ha reso familiare); ci viene messo davanti agli occhi, ossessivamente, il modo in cui ogni vizio viene ucciso, senza risparmiarci dettagli sanguinosi; infine viene descritto un tempio dedicato alla Vittoria: in quell’edificio troveranno “luogo” tutte le immagini, là la molteplicità si ricomporrà nell’unità.
Lo schema del percorso, del viaggio, gioca un molo essenziale e interviene a diversi livelli. Un percorso è ad esempio la lettura: si cammina per i luoghi del testo, e ci si lascia prendere dalle immagini che via via si trovano, si dialoga con i personaggi che si incontrano; si costruisce, sul fondamento del significato letterale, l’edificio prezioso dei sensi allegorici. E anche i testi sono costruiti in modo tale da prefigurare, da guidare il percorso della lettura, facendo leva appunto sulla memoria e sull’immaginazione.
Proprio a questo servono, secondo la Carruthers, alcune caratteristiche formali che le retoriche medievali raccomandano caldamente: così ad esempio la brevitas spinge il lettore a far germogliare il testo nella propria mente, come il granello di senape della parabola evangelica; l’oscurità, l’allegoria costringono il lettore a fermarsi a riflettere e a ricordare, impongono una lentezza che può essere creativa; il ductus, il modo cioè in cui il tema è trattato, diventa appunto un percorso che guida a raggiungere la meta. Le chiese, i monasteri rendono visibile ciò che i testi suggeriscono all’occhio della mente: attraverso di essi si può compiere fisicamente un percorso del tutto simile a quello che i testi descrivono, cercando di fissarlo nella memoria.
Sono, dice la Carruthers, macchine per la meditazione. La regola del gioco è creare uno scambio continuo fra occhio del corpo e occhio della mente. E così anche i diversi luoghi del monastero possono interagire, scambiarsi la funzione. Come capita nel 200 ad Amiens, nella Biblionomia di Richard de Fournival. La biblioteca è descritta sotto forma di un giardino: i libri, raggruppati nelle diverse arti liberali, sono “collocati” nelle aiole. Questo dimostra, scrive la Carruthers, che il giardino veniva usato per ricordare l’ordinamento della biblioteca.
Un modo gentile e gradevole, potremmo dire, per costruirsi un efficace data base mentale, prendendo alla lettera metafore antiche, quali ad esempio quella della raccolta di testi che sceglie fior da fiore, che costruisce una antologia – ossia appunto un giardino – ideale.
Davvero imponenti sono i testi e le esperienze, che il libro prende in esame. Si può restare perplessi di fronte a singole analisi, o anche di fronte ad affermazioni di carattere generale: così ad esempio, dice la Carruthers, le tecniche che lei mette in luce hanno ben poco a che fare con la tradizione classica dell’arte della memoria: le sembrano piuttosto vicine ai procedimenti della mistica ebraica, o ad alcune pratiche orientali, come la meditazione del mandala e le processioni hindu.
Si può osservare però che la tradizione ebraica ha una forte diffidenza nei confronti delle immagini, che giocano invece un ruolo essenziale nella vicenda che il libro ricostruisce; chiunque abbia esperienza di un Paese cattolico, d’altra parte, ritrova tratti molto familiari nelle pagine dedicate alle processioni come rituali di memoria, capaci di legare luoghi e immagini, e di suscitare un forte coinvolgimento emotivo.
Resta il fatto, tuttavia, che il fascino centrale del libro sta nella sua capacità di farci vedere in modo nuovo molte cose, e di basilare importanza: modi di procedere, strutture di pensiero, meccanismi retorici che spesso vanno ben al di là del Medioevo, e hanno una lunga durata. Quando noi leggiamo, o ascoltiamo le parole dell’apostolo Paolo — dice ad esempio Agostino nel De trinitate (Vin.4,7) — ognuno di noi cerca di creare la sua immagine, e quella delle persone che lui nomina. Agostino — uno dei protagonisti del libro della Carruthers — ci descrive qui un modo di leggere che cerca di visualizzare l’autore, così da creare con lui un rapporto più personale, come avviene in un incontro, in un dialogo; proprio per questo la costruzione del ritratto può funzionare da immagine della memoria, nel senso che ci aiuta a ricordare — quasi a ricreare — il testo che si è letto o sentito.
È un modo di leggere i testi che abbiamo dimenticato, anche se è durato a lungo, e ha trovato espressioni affascinanti (cfr. Purché leggere resti un piacere, «Il Sole-24 Ore», 15 marzo 1998). In questi ultimi anni ci sono ricerche che ci possono aiutare a riscoprirlo. Ad esempio alcune mostre e convegni sono andati alla ricerca di come l’autore viene raffigurato, e di come questo interagisca col modo di leggere i suoi testi.
Possiamo così vedere le diverse immagini di Dante presenti in alcuni manoscritti illustrati della Divina Commedia che sono conservati alla Biblioteca Riccardiana di Firenze (I Danti riccardiani. Parole e figure, a cura di Giovanna Lazzi e Giancarlo Savino. Firenze. Polistampa. 1996). Dai tesori della stessa Biblioteca sono poi stati tratti 40 manoscritti che contengono ritratti di autore: si comincia dai grandi scrittori dell’antichità e si arriva fino agli autori del Quattro e del Cinquecento (Immaginare l’autore. Il ritratto del letterato nella cultura umanistica. Ritratti riccardiani, a cura di Giovanna Lazzi, Firenze, Polistampa, 1998)
Questa galleria di ritratti interagisce così con le immagini create dalle parole, con i vari tipi, cioè, di ritratti letterari che, in uno dei saggi premessi al catalogo, La letteratura umanistica e le forme del ritratto. Linee per una ricerca, Paolo Viti ricostruisce con efficacia, inseguendoli fra poesie e trattati, lettere, commenti, biografie, e libri di “ricordanze”.
La riscoperta delle tecniche della memoria non serve tuttavia soltanto a gettare nuova luce su componenti basilari della nostra tradizione culturale. E davvero di grande suggestione vedere come possa aiutare a capire esperienze di altre culture, pratiche e prodotti di mondi che sono molto lontani dal nostro. È ad esempio il caso dei Luba, una popolazione che vive nel Sud-Est dello Zaire. Nel 1996 il Museo dell’arte africana di New York ha dedicato loro una mostra, accompagnandola con un catalogo (Memory. Luba Art and the Making of History, a cura di Mary Nooter Roberts e di Alien F. Roberts) a cui hanno collaborato antropologi ed entomologi, archeologi e storici dell’arte. Quel che viene alla luce è una dimensione, materiale e simbolica, che lo sguardo occidentale aveva finora trascurato.
Si è infatti tradizionalmente guardato ai manufatti Luba da un punto di vista estetico: si sono dunque scelti e collezionati solo quegli oggetti che in qualche modo potevano essere interpretati come opere d’arte, con una netta preferenza per le statue antropomorfiche. Di molti manufatti, d’altra parte, non si capiva proprio l’uso, la funzione, il significato. Fra questi, delle tavole rettangolari di legno, dette lukasa, da cui sporgono grani di perle e a volte anche immagini in altorilievo.
Tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta, si è cominciato a considerarle secondo un’ottica nuova, che teneva conto fra l’altro della riscoperta della tradizione dell’arte della memoria fatta da Frances Yates in L’arte della memoria. Il libro della Yates riportava alla luce un modo di ricordare che si basava in primo luogo sullo spazio, sulla successione dei luoghi nello spazio. Mostrava inoltre come i sistemi di memoria fossero capaci di unire insieme le parole e le immagini, la conservazione e l’invenzione: una volta costruito — nella mente, o fisicamente — il teatro della memoria, vi si possono infatti recitare molti spettacoli, nel senso che si possono usare i luoghi e le immagini per creare di volta in volta nuove associazioni.
Questi meccanismi di base si rivelavano di incredibile utilità anche nel caso dei manufatti Luba, dei lukasa in primo luogo. Si è visto che le perle e le varie sporgenze delineano un diagramma che rappresenta cose diverse, un’unica struttura che si ripete a livelli diversi della realtà: è ad esempio il territorio Luba, con i luoghi dove risiedono i diversi spiriti protettori, ma è anche la corte del re, con l’ordinata disposizione dei vari dignitari; è l’anatomia del corpo umano e nello stesso tempo è la rappresentazione della tartaruga totemica della famiglia regale. Proprio perché è costruito così, il lukasa funziona da sistema della memoria: chi lo usa, magari ripercorrendo con il dito i suoi diversi “luoghi”, può ricordare cose molto diverse, come i miti e l’epica delle origini, le migrazioni dei clan, gli elogi degli eroi e dei re, gli insegnamenti morali e così via.
In questo modo il sistema di memoria genera le parole, la narrazione, costruisce di volta in volta quella “memoria” di cui la comunità ha bisogno. Il lukasa è usato nei riti, nelle danze, così che l’efficacia delle parole sia rafforzata dalla musica e dal linguaggio del corpo. E chi lo usa non è a sua volta una persona qualsiasi: è un iniziato, che ha viaggiato nel mondo degli spiriti, ed è entrato a far parte del gruppo dei Mbudye, gli “uomini-memoria”, gli storiografi di corte, che sono, come gli indovini, i depositari della saggezza.
In questi ultimi mesi le vicende della Serbia e del Kosovo ci hanno riproposto in modo tragico la questione della memoria, storica e individuale. Il modo in cui un lontano passato è stato reinventato si è intrecciato con la sistematica distruzione anche delle prove di identità delle singole persone, dai documenti di identità alle targhe delle macchine. Anche per questo può essere forse interessante riflettere su libri come quelli che abbiamo qui ricordato. Mi sembra infatti significativo che, tra passato e presente, tra cultura occidentale ed esperienze africane, la questione della memoria si ripresenti oggi in modo così forte, e così legata ai problemi delle molteplici forme dell’interpretazione.
C’è come un bisogno di rompere i vincoli, le barriere tradizionali, per interrogarsi in modo più libero sul modo in cui ognuno di noi, e ogni singolo gruppo, ricostruisce via via il proprio passato, si ri-racconta la propria storia.




