Un movimento già radicalizzato che rischia solo di indebolire le economie occidentali a tutto vantaggio della Cina, di gran lunga il primo inquinatore del pianeta
di Federico Punzi
Quello che si è aggregato attorno a Greta Thunberg è il movimento più populista, più demagogico, più anti-scientifico, dogmatico, anti-capitalista e quindi anti-occidentale dei nostri giorni e sarebbe un errore sottovalutarlo. Per quantità, diffusione, e qualità, armamentario ideologico e capacità di produrre effetti tangibili sulle nostre vite, non è paragonabile ad alcun movimento definito “populista”.
Se qualcuno l’avesse scambiato per una di quelle fiammate di folclore ambientalista che di tanto in tanto si manifestano, o pensa di cavalcarlo per sostenere, in una logica emergenziale, un’agenda green economicamente e politicamente sostenibile, dovrebbe aprire gli occhi perché rischia di venire travolto.
 Tutti ormai associano il giovane volto di Greta alla battaglia contro i cambiamenti climatici (ex global warming, perché di warming non se ne registra abbastanza…), ma forse in pochi hanno ascoltato con attenzione i suoi discorsi. Il problema è che a non prenderla sul serio per la sua età, a fare ironia sulla sua impreparazione e le sue contraddizioni, si viene additati come haters e accusati di essere insensibili alla questione ambientale e alla passione politica dei giovani.
Tutti ormai associano il giovane volto di Greta alla battaglia contro i cambiamenti climatici (ex global warming, perché di warming non se ne registra abbastanza…), ma forse in pochi hanno ascoltato con attenzione i suoi discorsi. Il problema è che a non prenderla sul serio per la sua età, a fare ironia sulla sua impreparazione e le sue contraddizioni, si viene additati come haters e accusati di essere insensibili alla questione ambientale e alla passione politica dei giovani.
Allora non facciamo gli insensibili, prendiamola sul serio: ma così facendo scopriamo che non è permesso niente di meno che adorarla. Non si può, però, pretendere che sia presa sul serio e al tempo stesso sia al riparo da critiche anche dure. L’impressione invece è che sia proprio questo il ricatto morale da parte di chi ha visto in lei una testimonial perfetta.
Perfetta perché inattaccabile: devi essere un cinico mostro se polemizzi con una ragazzina che si batte con tutto il suo candore per ciò in cui crede e che, per di più, ha la sindrome di Asperger. Qui non ci interessa quanto e come Greta venga strumentalizzata, dai genitori o da altri, se l’operazione sia stata o meno pianificata fin nei minimi dettagli, quale sindrome abbia, ma entrare nel merito.
 Tutti abbiamo, o dovremmo avere a cuore l’ambiente, la qualità della vita nelle nostre città, la salute nostra e del nostro pianeta. Ma non è questo il punto. Il problema è il massimalismo del movimento di Greta, il ricorso al catastrofismo, i toni minacciosi, apocalittici, direi millenaristici, non supportati da evidenze scientifiche, che rischiano però di spingere i governi ad adottare politiche costosissime per l’economia e i contribuenti quanto scarsamente efficaci per l’ambiente, a fronte di una minaccia inesistente, almeno nei termini in cui ci viene prospettata.
Tutti abbiamo, o dovremmo avere a cuore l’ambiente, la qualità della vita nelle nostre città, la salute nostra e del nostro pianeta. Ma non è questo il punto. Il problema è il massimalismo del movimento di Greta, il ricorso al catastrofismo, i toni minacciosi, apocalittici, direi millenaristici, non supportati da evidenze scientifiche, che rischiano però di spingere i governi ad adottare politiche costosissime per l’economia e i contribuenti quanto scarsamente efficaci per l’ambiente, a fronte di una minaccia inesistente, almeno nei termini in cui ci viene prospettata.
La questione ecologica e climatica viene affrontata in termini ideologici, quasi religiosi: il movimento di Greta ha i suoi testi sacri, i suoi riti, predica una condotta di vita moralmente corretta, ha persino una sua escatologia, profetizza la fine del mondo a meno che l’umanità non si converta al suo credo. Ci sono i peccati e la redenzione, persino l’astinenza dal mangiare carne o concepire figli.
 E non può mancare la santificazione della fondatrice: la verità rivelata a una giovane senza peccato che da quel momento è animata dalla missione di salvare l’umanità condividendola. Tutti coloro che si permettono di esprimere dubbi, di avanzare studi e dati che contraddicono le sacre scritture, vengono indicati come infedeli, negazionisti al soldo dei sordidi interessi delle multinazionali. Come se la “rivoluzione green” non sia essa stessa un grande business, che garantisce profitti privati a fronte di costi sopportati dalla collettività… Ma la nostra casa non è “in fiamme”.
E non può mancare la santificazione della fondatrice: la verità rivelata a una giovane senza peccato che da quel momento è animata dalla missione di salvare l’umanità condividendola. Tutti coloro che si permettono di esprimere dubbi, di avanzare studi e dati che contraddicono le sacre scritture, vengono indicati come infedeli, negazionisti al soldo dei sordidi interessi delle multinazionali. Come se la “rivoluzione green” non sia essa stessa un grande business, che garantisce profitti privati a fronte di costi sopportati dalla collettività… Ma la nostra casa non è “in fiamme”.
Quando si sono accorti che il riscaldamento globale non riscaldava, o non riscaldava abbastanza (come da almeno 15 anni), tanto che tutti i modelli predittivi allarmistici sull’aumento delle temperature hanno finora fallito, allora hanno cominciato a parlare più genericamente di “cambiamenti climatici”. Il clima cambia. Già, ma perché cambia?
L’origine antropica del riscaldamento o dei cambiamenti è tutt’ora un atto di fede piuttosto che una verità scientifica. Se non abbiamo un modello in grado di prevedere con ragionevole accuratezza il trend di aumento delle temperature, come possiamo pensare di programmare un intervento per invertirlo? E, nel caso funzionasse, dovrebbe essere così preciso da non causare un raffreddamento della Terra, esito anch’esso indesiderabile.
Quest’anno ricorre il trentennale non solo della repressione di Piazza Tienanmen o della caduta del Muro di Berlino, ma anche di una delle tante profezie degli “esperti” delle Nazioni Unite: “Intere nazioni potrebbero essere spazzate via dalla faccia della terra dall’innalzamento del livello dei mari se la tendenza al riscaldamento globale non verrà invertita entro l’anno 2000”.
 Era il 29 giugno 1989 e gli “esperti”, gli scienziati che Greta ci ammonisce di ascoltare (anche se il mondo scientifico non è così compatto come si dice), ci davano dieci anni di tempo per evitare il disastro, l’estinzione. E si tratta solo di uno degli innumerevoli allarmi che in questi decenni si sono rivelati fasulli. Delle due l’una: o si trattava di allarmi infondati, o le politiche (o meglio le tecnologie) adottate da allora sono state più che sufficienti per evitarlo.
Era il 29 giugno 1989 e gli “esperti”, gli scienziati che Greta ci ammonisce di ascoltare (anche se il mondo scientifico non è così compatto come si dice), ci davano dieci anni di tempo per evitare il disastro, l’estinzione. E si tratta solo di uno degli innumerevoli allarmi che in questi decenni si sono rivelati fasulli. Delle due l’una: o si trattava di allarmi infondati, o le politiche (o meglio le tecnologie) adottate da allora sono state più che sufficienti per evitarlo.
Ma com’è possibile che istituzioni, parlamenti, leader politici, capi di stato e di governo, persino il Papa, si mettano in fila per stringerle la mano e addirittura baciarla, ovviamente a favore di telecamere? Nonostante siano proprio i leader e la politica, le elite economiche dei Paesi “ricchi”, occidentali, i suoi avversari dichiarati, i bersagli delle sue invettive, tutti sgomitano per salire sul carro di Greta. Le risposte sono tre.
C’è, in Europa, ma in parte anche in Nord America, un vecchio establishment, una classe politica decotta, totalmente screditata per la sua incapacità di affrontare le crisi e rispondere ai cambiamenti, che cavalcando l’onda Greta spera di recuperare consensi, di rilegittimarsi, di darsi una rilucidata ideologica, di “parlare ai più giovani”.
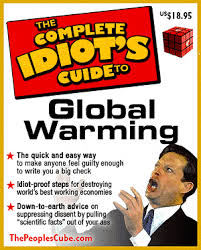 La logica emergenziale offre anche il pretesto per una gigantesca operazione redistributiva attraverso la quale veicolare consenso. In Germania, dove avanzano i Verdi con percentuali a due cifre e l’economia, abbandonato il nucleare, va tuttora a carbone e gas russo, Angela Merkel propone un piano da 100 miliardi, ma un po’ ovunque lo slogan Green New Deal è ormai sulla bocca di tutti.
La logica emergenziale offre anche il pretesto per una gigantesca operazione redistributiva attraverso la quale veicolare consenso. In Germania, dove avanzano i Verdi con percentuali a due cifre e l’economia, abbandonato il nucleare, va tuttora a carbone e gas russo, Angela Merkel propone un piano da 100 miliardi, ma un po’ ovunque lo slogan Green New Deal è ormai sulla bocca di tutti.
Più tasse sui consumatori e i produttori non green (o più debito, ovvero sempre più tasse rinviate nel tempo) per raccogliere risorse da allocare verso investimenti, o addirittura comportamenti, green. I più ambiziosi parlano di decarbonizzazione, di una riconversione industriale e produttiva programmata e gestita dall’alto. Dai politici. Cosa può andare storto? Tutto, come insegnano i piani quinquennali di sovietica memoria.
Nella sua miopia, questa classe politica non si accorge però che sta allevando il “mostro” che molto probabilmente darà il colpo di grazia alla sua già pericolante legittimazione: da una parte, infatti, nuove tasse ecologiche, anche minime, rischiano di scatenare la rabbia delle classi medio-basse che, già sottoposte alle pressioni della globalizzazione e dell’immigrazione, dovrebbero sopportare ulteriori costi, più o meno occulti.
Pensiamo ai settori come l’agricoltura o il trasporto aereo, in cui semplicemente non c’è alternativa ai combustibili fossili, che saranno colpiti solo per fare cassa, o ai tanti, ancora la maggioranza, che per lavorare devono muoversi, ma non possono permettersi i prezzi proibitivi delle ultime tecnologie green. Dall’altra, nemmeno una cura da cavallo riuscirà a soddisfare le richieste del popolo di Greta.
Come si evince dai suoi epigoni sparsi in diversi Paesi, è un movimento già radicalizzato, che rischia di segnare un’intera generazione, educandola ad un impegno politico ideologico e massimalista e ad una contestazione anti-capitalista e anti-sviluppista, come quello no global nei primi anni 2000. Nessuna misura green apparirà ai loro occhi abbastanza per salvare il pianeta.
 Terza ragione: è su temi globali come i cambiamenti climatici, le migrazioni, la stabilità finanziaria, che fanno leva organismi e consessi sovranazionali quali Onu, G20 o WEF per avanzare l’idea di una governance globale. E questi temi vengono usati da chi governa le istituzioni Ue per introdurre più normative e controlli a livello europeo, per aumentare la spesa pubblica intermediata dal burosauro di Bruxelles, e ampliare così i propri poteri a danno delle democrazie nazionali.
Terza ragione: è su temi globali come i cambiamenti climatici, le migrazioni, la stabilità finanziaria, che fanno leva organismi e consessi sovranazionali quali Onu, G20 o WEF per avanzare l’idea di una governance globale. E questi temi vengono usati da chi governa le istituzioni Ue per introdurre più normative e controlli a livello europeo, per aumentare la spesa pubblica intermediata dal burosauro di Bruxelles, e ampliare così i propri poteri a danno delle democrazie nazionali.
Il problema è che se la svolta green sarà nei termini massimalisti gridati in piazza nei FridaysForFuture, si rivelerà un salasso economico e provocherà un backlash politico. Se si tratterà di aspirine, alimenterà nei partigiani del clima la frustrazione per la “rivoluzione incompiuta”. In entrambi i casi, saranno le elite europeiste e globaliste che oggi ne alimentano le aspettative ad uscirne con le ossa rotte.
Uno dei falsi miti diffusi da Greta è che i mancati progressi nell’affrontare i cambiamenti climatici si debbano addebitare a un supposto egoismo dei Paesi più sviluppati, occidentali, e alle loro multinazionali: “La nostra biosfera viene sacrificata per far sì che le persone ricche in Paesi come il mio possano vivere nel lusso”.
Ma pur ammettendo l’origine antropica di questi fenomeni, se si osservano i dati delle emissioni di CO2 e di altri agenti inquinanti come la plastica, o addirittura di altri già proibiti, emerge chiaramente come sia la Cina di gran lunga il primo inquinatore del pianeta, che però gli accordi di Parigi esentano da qualsiasi impegno fino al 2030.
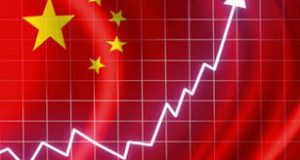 Dal 2000 la Cina ha più che triplicato le sue emissioni di CO2 (e potrà aumentarle almeno fino al 2030), mentre Stati Uniti ed Europa le hanno ridotte di oltre il 10 per cento. Piazza Tienanmen – non le strade di Washington, Stoccolma, o Berlino – dovrebbe essere l’epicentro dei Global Strike di Greta. Come i movimenti antimilitaristi degli anni ’60 e ’70, che chiedevano il disarmo unilaterale dell’Europa nonostante avessimo i missili sovietici puntati contro, così oggi le azioni per il clima invocate dai FridaysForFuture, se adottate anche in piccole dosi, avrebbero l’effetto di un salasso sulle nostre economie, facendo esplodere una profonda crisi politica e sociale, e quindi di “disarmarci” a tutto vantaggio della Cina.
Dal 2000 la Cina ha più che triplicato le sue emissioni di CO2 (e potrà aumentarle almeno fino al 2030), mentre Stati Uniti ed Europa le hanno ridotte di oltre il 10 per cento. Piazza Tienanmen – non le strade di Washington, Stoccolma, o Berlino – dovrebbe essere l’epicentro dei Global Strike di Greta. Come i movimenti antimilitaristi degli anni ’60 e ’70, che chiedevano il disarmo unilaterale dell’Europa nonostante avessimo i missili sovietici puntati contro, così oggi le azioni per il clima invocate dai FridaysForFuture, se adottate anche in piccole dosi, avrebbero l’effetto di un salasso sulle nostre economie, facendo esplodere una profonda crisi politica e sociale, e quindi di “disarmarci” a tutto vantaggio della Cina.
Il catastrofismo ha purtroppo questa antipatica controindicazione: può portarci a sacrificare lo sviluppo, la crescita economica, sull’altare della difesa dell’ambiente, con il tragico risultato di rinunciare al primo senza riuscire a salvaguardare il secondo.
Si parla molto di sviluppo sostenibile, ma avremmo innanzitutto bisogno di un ambientalismo sostenibile, compatibile con lo sviluppo, perché senza quest’ultimo non c’è innovazione tecnologica, l’unica arma davvero in grado di ridurre l’inquinamento e difendere l’ambiente.





