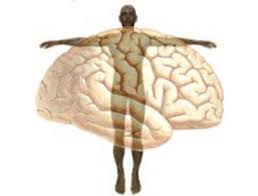In queste pagine il prof. Giovanni Stelli riepiloga con chiarezza le corrette definizioni di individuo e di persona, sgomberando il campo da sterili discussioni su scienza e fede, confessionalismo e laicità. Si tratta di impostare la cruciale questione della bioetica in termini antropologici, anche per dare un fondamento oggettivo ai diritti universali dell’uomo.
Sullo sfondo, l’analisi filosofica di Robert Spaemann. Il prof. Stelli, già docente di Pedagogia e Didattica della filosofia nell’Università della Basilicata, ha pubblicato, fra l’altro, La ricerca del fondamento (1995), Il labirinto e l’orizzonte (1998), Modelli di insegnamento della filosofia (2001), La scienza della prassi (2009). Con P. Sensi è autore di una Storia della filosofia in tre volumi. Il libro di Giovanni Stelli, Il filo di Arianna (2007), è stato ampiamente illustrato da Michelangelo Pelàez nel n. 578 (2009) di Studi cattolici.
di Giovanni Stelli
Ma è veramente così o non si tratta piuttosto di un conflitto tra diverse concezioni dell’ uomo e della ragione? Il classico argomento dei fautori della «ragione» e della «laicità», che più correttamente dovrebbero esser detti laicisti, viene così proposto: con questa determinata legge (che consente, per esempio, l’aborto o l’eutanasia) non si obbliga il credente a fare ciò che la legge consente; ma il credente, a sua volta, non ha il diritto di obbligare gli altri a non fare ciò che essi ritengono lecito.
Il credente, coerente con la sua fede, non ricorrerà, per esempio, all’aborto, ma il non credente potrà ricorrervi, senza che l’uno violi la libertà dell’altro e viceversa. In altri termini: perché mai il credente dovrebbe imporre a tutti, anche ai non credenti, i suoi particolari convincimenti religiosi? A questa posizione laica e liberale, rispettosa dei diritti di tutti, si opporrebbe quindi una posizione integralista che vorrebbe invece obbligare tutti a seguire una concezione morale particolare; e ciò costituirebbe un’indebita intromissione della religione (di una religione) nella sfera pubblica dello Stato laico, il quale per definizione deve essere neutrale rispetto a tutte le possibili diverse visioni del mondo.
In realtà, il carattere sofistico del ragionamento può essere facilmente evidenziato mediante un argomento controfattuale. Supponiamo che si voglia e si possa far approvare una legge volta a reintrodurre l’istituto della schiavitù in forma volontaria (stabilendo cioè la necessità dell’assenso dell’eventuale candidato schiavo a essere ridotto in schiavitù).
Il ragionamento a difesa di una iniziativa del genere sarebbe del tutto identico a quello menzionato in precedenza: io non ti obbligo né ad avere schiavi né a diventare schiavo; se nutri determinate convinzioni, rifiuterai queste possibilità; ma perché negarle ad altri che non la pensano come te, che valutano positivamente l’istituto della schiavitù, sia dal lato del padrone sia da quello dello schiavo?
Nella forma in cui è presentato, l’argomento non può avere quindi una validità generale: esso vale in tutti i casi in cui non entra in gioco una violazione dei diritti fondamentali dell’uomo. Ognuno ha il diritto e la possibilità di arricchirsi in modo lecito, ma non tutti sono obbligati a farlo; ognuno ha la libertà di praticare una determinata religione, ma non tutti sono obbligati a farlo e così via. È chiaro, invece, che l’argomento non può essere esteso ad affermazioni come «ognuno può possedere schiavi (consenzienti), ma nessuno è obbligato a farlo» o «ognuno ha il diritto di praticare la pedofilia (con minori consenzienti), ma nessuno è obbligato a farlo» e così via.
Non ci troviamo pertanto di fronte a un conflitto tra fede e ragione, bensì a un confitto tra diverse concezioni dell’ uomo, in cui in prima istanza non è affatto questione di opzioni religiose. Lo scontro si gioca completamente sul piano della ragione e dei diritti fondamentali dell’uomo, diritti che non sono sottoposti alle regole della maggioranza e del consenso, ma che costituiscono o dovrebbero costituire il presupposto incondizionato delle leggi positive (si pensi alla «Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo» del 1948).
È necessaria un’ulteriore precisazione, in quanto il presunto conflitto tra fede e ragione viene spesso presentato come un conflitto tra fede e scienza: bisogna, si sostiene, lasciar fare alla scienza, affidarsi agli scienziati, e non già interferire indebitamente nella libertà di ricerca con opzioni religiose particolari. La tesi presuppone che (a) la scienza sia in grado di dare risposte alla domanda su ciò che si deve fare e (b) che le risposte della scienza siano univoche.
La seconda assunzione è smentita dalla più elementare esperienza: non c’è problema (si pensi, per esempio, alla questione del «riscaldamento del pianeta») su cui gli scienziati non siano divisi, su cui gli «esperti» non diano risposte diverse e, a volte, addirittura opposte. Ma, anche nei rari casi in cui siano condivise dalla comunità scientifica, le risposte degli scienziati non riguardano e non possono mai riguardare in linea di principio ciò che si deve fare, bensì si limitano a fornirci gli strumenti indispensabili per sapere che cosa si può fare, le cognizioni necessarie che ci consentono poi di decidere ciò che si deve fare.
Possiamo avere una risposta scientifica alla domanda su che cosa sia un feto dell’età di tre mesi, ma la risposta alla domanda se sia lecito eliminarlo con una pratica abortiva dipende da presupposti di altro tipo: dal fatto di considerarlo «persona» o «non persona» o «persona potenziale», dal peso rilevante che secondo alcuni va attribuito all’interesse della madre, dei genitori, della società e così via; dipende cioè da una serie di presupposti filosofici. L’idea che si debba «lasciar fare» alla scienza è essa stessa un’idea filosofica, caratteristica di quella filosofia ingenua detta scientismo, che spaccia per certezze «scientifiche» convinzioni filosofiche implicite e inconsapevoli.
Un «incantesimo» millenario & il «nuovo» utilitarismo
Dietro le battaglie apparenti tra fede e ragione, integralismo e laicità, fede e scienza si svolge dunque un’altra battaglia, che è quella reale, tra diverse visioni dell’uomo, diverse concezioni antropologiche. Una delle novità più radicali del nostro tempo è costituita infatti da una profonda mutazione di quella visione dell’uomo che, pur con declinazioni molteplici e differenti, ha caratterizzato la cultura occidentale per due millenni.
È una mutazione annunciata con entusiasmo da alcuni filosofi e bioeticisti, come Maurizio Mori, che ha scritto a proposito del «caso Englaro»: «Eluana ha rotto l’incantesimo della sacralità della vita»; questa «rottura», si badi, è tale nei confronti non soltanto del cristianesimo, ma anche della tradizione greca, di ciò che lo stesso Mori chiama ippocratismo, riferendosi al «Giuramento di Ippocrate» che interdice al medico di praticare l’eutanasia e di procurare l’aborto (1).
In che cosa precisamente consiste questa mutazione? Possiamo comprenderla a partire da alcune convinzioni o certezze intuitive, considerate indiscutibili e generalmente condivise fino a qualche tempo fa: a) tutti gli uomini, in quanto uomini, sono persone. Proprio queste convinzioni — che erano parte integrante del senso comune e su cui per secoli si è esercitata la riflessione filosofica al fine di chiarirle e argomentarle razionalmente – vengono oggi messe in questione in vario modo e da varie parti.
L’uomo non è più considerato persona in senso eminente, bensì un animale che presenterebbe differenze non essenziali rispetto ai mammiferi superiori. In queste posizioni il concetto di persona si stempera fino a perdere del tutto il suo significato originario. Questo concetto, così come l’espressione «sacralità della vita umana», significava (e significa) che la vita di una persona è inviolabile anche quando non risulta più funzionale a quei soggetti – genitori, parenti, membri della società in genere – che si trovano necessariamente in relazione con essa; e anche quando non è funzionale (ovvero «funziona male», in modo imperfetto) alla persona stessa, perché disabile, malata, anziana, o non ancora del tutto formata, come nel caso del feto e del neonato.
Ma, una volta che la nozione di persona sia stata eliminata o stravolta, per la formulazione delle regole morali non resta che il criterio utilitaristico, riconoscere cioè come criterio o valore soltanto ciò che è utile, ciò che serve e «funziona» sia in relazione al singolo individuo sia in relazione alla società. Qualche esempio può servire a chiarire che cosa si intende con ciò. Il filosofo australiano Peter Singer, che insegna bioetica a Princeton ed è stato consigliere di Clinton, è il rappresentante più noto di questa tendenza utilitaristica in campo bioetico.
Nel 1998 con il titolo «Quando è giusto uccidere un bambino», il New York Times pubblicò un estratto del libro Practical Ethics, base dell’insegnamento di Singer a Princeton, in cui viene sostenuta la tesi della possibilità di applicare l’eutanasia a un neonato emofiliaco. È vero che il neonato emofiliaco potrebbe vivere «in positivo equilibrio tra la felicità e l’infelicità» e quindi ci sarebbe qualche ragione per opporsi alla sua soppressione. Ma se la sua morte inducesse i genitori ad avere un altro figlio «con migliori prospettive di felicità maggiore per tutti», l’opposizione dovrebbe cadere.
«Da un punto di vista complessivo», ha affermato Peter Singer in un’intervista del 2008, «uccidere il neonato emofiliaco non è l’equivalente morale di uccidere una persona. La perdita di una vita felice da parte del primo bambino è superata dal guadagno di una vita più felice da parte del secondo. Di conseguenza, se uccidere il bambino emofiliaco non ha conseguenze negative per altri, da un punto di vista complessivo, sarebbe giusto ucciderlo» (2).
Si tratta, come si vede, di un utilitarismo conseguente, che calcola la somma totale di vantaggi e svantaggi: «Quando la morte di un neonato malformato conduce alla nascita di un altro bambino con migliori prospettive di una vita felice, la quantità totale di felicità sarà maggiore se il bambino malformato viene ucciso» (3).
Singer sostiene che l’aborto è omicidio, ma lo ritiene lecito, così come ritiene lecito sopprimere in certe determinate condizioni i neonati: dal momento che non c’è alcuna «differenza morale cruciale tra lo sviluppo di un essere umano dentro o fuori il corpo materno», bisogna chiedersi: «perché limitare l’uccisione nell’utero? Non avviene niente di magico alla nascita. Un bambino prematuro può essere meno sviluppato di un feto in fase avanzata» (4).
In presenza di determinate condizioni del soggetto e in vista di precisi vantaggi degli altri soggetti coinvolti, è lecito sopprimere la vita di feti, bambini, disabili e anziani. Quali sono queste condizioni? Esse si riassumono sostanzialmente in un solo criterio, stabilito ovviamente da coloro che hanno il potere di stabilirlo, ossia da esseri umani attualmente viventi e «normali»: la «qualità della vita» ovvero la distinzione tra «vita degna di essere vissuta» e «vita non degna di essere vissuta» (5).
La prospettiva dei vantaggi degli altri soggetti coinvolti è poi facilmente accettabile a partire dai desideri e dalle aspettative di questi ultimi. I due aspetti – condizioni del soggetto da sopprimere e vantaggi per gli altri soggetti — sono illustrati con grande chiarezza da Singer in relazione al caso di neonati con spina bifida: «La ragione del lasciarli morire [i bambini con spina bifida] era la miserevole vita che avrebbero condotto [condizioni del soggetto] e la cura dei bambini che sarebbe diventata un peso per i genitori [utilità degli altri soggetti coinvolti]. Ma molti di loro non morivano rapidamente, alcuni vivevano per mesi, altri per anni, altri non morivamo affatto. Non era una situazione desiderabile.
La decisione morale era se un bambino handicappato dovesse vivere o morire. Una volta presa la decisione, la morte del bambino, abbiamo pensato che dovesse avvenire in modo umano. La decisione se il bambino debba morire o no deve essere presa sulla dettagliata conoscenza della sua condizione, sulla situazione della famiglia e sulla possibilità di rifiuto dei genitori. […] Un altro elemento [di cui tener conto] è il legame fra la madre e il figlio. Esiste, anche prima della nascita, ma non è così forte come quello che si forma le settimane successive alla nascita. Quindi, se le prospettive del bambino sono povere, sarà più facile per i genitori distaccarsi dal bambino appena possibile» (6).
L’eutanasia infantile è quindi nell’interesse del bambino, a cui viene così risparmiata una «vita povera». Ma, si badi, è soprattutto utile ai genitori, i cui desideri e le cui aspettative vanno assolutamente rispettati anche in assenza della prima condizione (la qualità della vita del soggetto da sopprimere). Anche se «né l’emofilia né la sindrome di Down sono così gravi da rendere la vita non degna di essere vissuta», i genitori hanno comunque il diritto di «trattare i feti come intercambiabili o sostituibili» (7); anche se il bambino «potrà avere una vita senza eccessiva sofferenza, ma i genitori pensano che sia un peso eccessivo per loro e vogliono averne un altro, penso sia ragionevole considerare gli interessi del futuro bambino.
I genitori possono a buon diritto dolersi che sia nato loro un bambino malformato. In questo caso l’effetto della morte del bambino sui genitori può essere una ragione per ucciderlo, piuttosto che contro» (8) In modo analogo argomenta il pediatra olandese Eduard Verhagen, che preferisce usare il termine «termination» («noi scegliamo di terminare il bambino») oppure «deliberata fine della vita» invece del più esplicito «uccidere» di Singer.
Il protocollo di Groningen sulla «morte infantile», di cui Verhagen è un autore, distingue tre categorie di bambini che possono essere «terminati»; il problema sussiste per il terzo gruppo in cui determinante è la previsione di una qualità della vita accettabile. Pur ammettendo che «il novantanove per cento dei casi di spina bifida sono compatibili con una vita normale», mentre il 90% dei bambini con questa anomalia viene abortito prima di nascere, Verhagen sostiene che sono sempre i genitori a dover decidere se sopprimere o no il loro bambino: «Dico questo, che sono d’accordo sempre sul fatto che i genitori hanno la scelta prima della nascita e dopo la nascita. Scegliere se far vivere o no il loro bambino» (9).
Lo stravolgimento del concetto di persona
In posizioni come queste l’eclissi del concetto di persona sembra innegabile. Eppure negli ultimi trent’anni proprio alla nozione di persona si sono spesso richiamati coloro che intendevano attaccarne il nucleo profondo e il carattere universale. Dissociando il concetto di uomo da quello di persona, si è tratta la conseguenza che non a tutti gli uomini in ogni fase della loro esistenza e in qualunque condizione spetterebbe la qualifica e la dignità di persone; il neonato, per esempio, non avrebbe le caratteristiche e quindi la dignità di una persona.
Il procedimento argomentativo è il seguente: si sceglie una caratteristica che dovrebbe definire la «persona» (per esempio, l’autocoscienza), si individuano gli esseri umani che non presentano questa caratteristica, o la presentano in modo gravemente difettivo, e si negano loro di conseguenza i diritti spettanti agli altri esseri umani che di questa caratteristica sono invece provvisti.
Dal momento che non tutti gli uomini sarebbero persone, non avrebbe più senso parlare di «diritti umani universali». Ecco come si esprime Singer: «È immediatamente evidente [sic] che non c’è fondamento nella linea tracciata fra esseri umani e altri animali. Al contrario, riguardo a queste caratteristiche [le caratteristiche morali significative che qualificano la persona] alcuni esseri umani non le hanno e alcuni animali non umani le possiedono. I bambini appena nati e gli esseri umani intellettualmente disabili non possiedono razionalità, autonomia, autocoscienza e capacità di comprendere che esistono nel tempo. Mentre gli scimpanzè e i grandi primati hanno queste capacità, almeno in un certo grado.
Su queste basi possiamo dire che alcuni esseri umani non sono persone mentre alcuni animali non umani lo sono» (10). Per respingere tesi di questo genere, ha osservato Robert Spaemann, non sono sufficienti, l’orrore istintivo e «una certa paura pubblica» da esse suscitati; la «resistenza dello stupore» è certo una prima sana reazione, ma non può sostituire la riflessione, che oggi deve interrogarsi nuovamente sul significato della nozione di persona (11).
Individuo, uomo, persona
La persona presuppone l’individuo, ma è più dell’individuo. Che cosa è un «individuo»? Il termine, che significa ciò che è indiviso, designa appunto un ente che non si può scindere senza che in tal modo vada perduto proprio ciò che lo caratterizza come questo ente determinato, come questo individuo. Un pezzo di materia inorganica, un sasso, una roccia, un gas non perde le sue caratteristiche, se viene diviso.
Un ente inorganico non è quindi un individuo. È solo nel mondo organico che emerge, e gradatamente si afferma, qualcosa che può dirsi individualità: un centro di organizzazione autonoma, capace di auto-riprodursi (il fondamento della vita sono le molecole del Dna, che posseggono la decisiva proprietà dell’autoreplicazione), qualcosa che non può essere suddiviso senza cessare di esser quello che è.
La pianta è già un centro di organizzazione in grado di autoriprodursi, ma non è ancora individuo in senso proprio, in quanto non è ancora, per così dire, centrata in sé stessa: le parti di cui si compone sono solo relativamente autonome, esse sono anche l’intera pianta; il taglio o la privazione di una di tali parti, come un ramo o una gemma, non lede la pianta nella sua integrità di organismo in unità immediata col suo ambiente da cui assimila ininterrottamente cibo, privo di mobilità, di calore e di sensibilità. La differenza tra pianta e animale è costituita dal chiaro emergere dell’individualità: la pianta è una forma aperta, si espande cioè all’esterno, laddove l’animale è una forma chiusa, si concentra cioè verso l’interno.
L’animale è centrato in sé stesso, le sue parti (le membra) perdono la loro autonomia ed esso, in quanto capace di muoversi e di interrompere l’assunzione di cibo, è relativamente autonomo nei confronti dell’ambiente naturale (12). Con la sensazione, infine, si apre una differenza tra interno ed esterno: l’essere vivente conquista una realtà oltre il corpo e l’unità immediata con la natura viene così superata in via definitiva. L’animale è pertanto individuo (e anche soggetto) in senso proprio, un centro interno di organizzazione che si espande all’esterno.
Tuttavia esso mantiene con l’ambiente che lo circonda sempre il medesimo rapporto, le cui modalità non variano (se non in misura irrilevante) col tempo, un rapporto identico quindi, di cui l’istinto è la manifestazione tipica. Con la comparsa dell’uomo si apre una nuova pro spettiva: mentre l’animale non può uscire dal suo mondo-ambiente, l’uomo non ha un mondo-ambiente in senso proprio, bensì ha in generale un mondo: egli conosce infatti il mondo-ambiente che gli è toccato in sorte in quanto ente naturale e proprio per questo è in grado di superarlo. A differenza degli animali e già sul piano meramente biologico, l’uomo è, secondo la definizione di Plessner, un «essere eccentrico» (13).
Soltanto in presenza dell’uomo diventa possibile parlare non semplicemente di individuo, ma anche di persona. Non è però sufficiente la tradizionale definizione dell’uomo come «animale razionale», poiché il termine ragione designa solo un momento, per quanto assai importante, della persona. Cercheremo ora di chiarire il significato della nozione di persona, seguendo le riflessioni di Spaemann, a partire dal senso comune e dal linguaggio ordinario.
Qual è il senso di espressioni di uso comune come «non merita di essere uomo, non merita la qualifica di uomo», «atti disumani», «mancanza di umanità»? Non potremmo certo adoperare queste espressioni in riferimento a un altro essere vivente. È solo l’uomo che può meritare o demeritare il suo essere-uomo. Ma ciò vuoi dire: gli altri esseri viventi sono ciò che sono, mentre l’uomo può essere diversamente da come è.
Dire che l’uomo può essere diversamente da come è significa dire che l’uomo è persona: in quanto persone gli uomini non sono semplicemente la loro natura, ma possiedono la loro natura ed è questo possedere che costituisce in modo specifico il loro essere (14): le persone non sono assorbite dal loro determinato modo di essere», «ma assumono nei confronti di questo un certo atteggiamento, adottandolo e realizzandolo o respingendolo»(15).La riflessione razionale è solo una delle forme, una forma particolarmente astratta, in cui viene alla luce questa differenza tra poter-essere ed esser-così; anzi, si potrebbe dire che è proprio tale differenza a rendere possibile la riflessione razionale.
Questa struttura dell’essere umano rimanda alla nozione di scopo o funzione essenziale. «Uomo» è un concetto che non può essere definito e compreso senza fare riferimento alfine o alla natura essenziale dell’uomo stesso (16). Il fine o natura essenziale dell’uomo non è semplicemente il vivere (l’esser-così), ma il vivere bene (il poter-essere diversamente da come si è): ciò che si è di fatto non coincide mai con ciò che si potrebbe, si vorrebbe o si dovrebbe essere. Questa differenza, di cui ogni uomo è sempre più o meno consapevole, è a fondamento di tutta una serie di fenomeni familiari come il rimorso, il pentimento, il senso di colpa, il proponimento, la promessa e così via; è a fondamento, insomma, dell’esperienza morale.
Questa differenza apre lo spazio della libertà: posso essere diversamente da come sono, ma posso anche, all’opposto, essere come sono, restare ciò che sono; tuttavia anche questa è una decisione che presuppone la libertà, anche questa è una scelta libera. E da questa esperienza, in cui la persona si mette in relazione con sé stessa, si origina anche l’idea di contingenza: per esperienza personale sappiamo non solo del nostro esser-così da cui possiamo distanziarci, ma anche che la nostra esistenza non è necessaria.
Da ciò il senso del tempo e della morte: fra tutte le specie animali solo l’essere umano, ossia la persona, «vive» la morte, anche se può facilmente dimenticarlo (17), e dall’esperienza personale della propria contingenza trapassa immediatamente all’esperienza della contingenza delle altre persone e del mondo. Da quanto detto fin qui consegue che la persona è sempre un’esistenza individuale, un qualcuno, un individuo unico. In quanto persona, l’uomo si rapporta liberamente alla propria natura e questo rapportarsi riguarda sempre il singolo individuo, i suoi comportamenti specifici e singolari (18).
Ma è vero, nel contempo, che io sono questo singolo, questa persona determinata, proprio perché mi trovo già da sempre insieme e in relazione con altri. Il «luogo» che solo io occupo nell’universo «è a sua volta determinato dalla sua posizione rispetto a tutti gli altri luoghi» occupati dagli altri e «la persona dunque è determinata dalla sua relazione rispetto ad ogni altra persona» (19).
Ciò vuoi dire che non si può essere persone solo al singolare: l’io implica il tu, la singolarità presuppone l’esserci di molti singoli. Non a caso «di Dio come persona si iniziò a parlare per la prima volta quando ci si mise a parlare di tre persone divine» (20). Si potrebbe dire che la relazione tra le persone è una relazione a priori, nel senso che noi non «entriamo» in questa relazione, ma ci troviamo già da sempre in essa.
Naturalmente sono poi le caratteristiche sociali e storiche (professione, nazionalità, cittadinanza) delle persone a determinare la differenza tra le diverse comunità di cui esse fanno parte di fatto. Essenziale tuttavia è che queste appartenenze sono appartenenze libere, possono essere accettate o rifiutate. La persona non è mai una mera parte di un tutto, bensì è essa stessa una totalità: «La comunità degli uomini non assorbe in sé la persona annientandone l’autonomia […], ma la valorizza ulteriormente, perché il rapporto tra persona e comunità è di un tutto verso un altro tutto» (21).
Doveri verso la persona: il riconoscimento
Dal momento che la persona esiste solo in relazione ad altre persone, il suo essere persona deve essere riconosciuto dagli altri, per cui «tutti i doveri verso le persone sono riconducibili al dovere di percepire le persone come persone». È ovviamente possibile, e in questo consiste il male, negare il riconoscimento e ridurre la persona a oggetto, considerare e trattare qualcuno alla stregua di qualcosa (22).
Più in particolare il dovere del riconoscimento significa: a) non devo sacrificare questa determinata persona nell’interesse della specie; si tratta qui della dignità della persona e non del suo valore: «II valore della vita di dieci uomini può essere maggiore di quella di un solo uomo, la dignità di dieci uomini non significa qualcosa in più della dignità di uno solo»; b) devo considerare tutti gli altri «uguali a me» proprio nel senso della loro incomparabile unicità; gli uomini sono simili tra loro in quanto appartenenti alla specie umana, mentre «in quanto persone non sono simili ma uguali, ma proprio in virtù del fatto che essi sono ogni volta unici e incommensurabili nella loro dignità»(23).
È bene ribadire che la persona non è tale in quanto riconosciuta e quindi cooptata e accolta (ma anche eventualmente rifiutata) nella comunità delle persone. Il riconoscimento è certamente un atto libero, ma è anche e soprattutto una risposta adeguata: come do ragione a qualcuno in quanto egli ha effettivamente ragione, allo stesso modo riconosco qualcuno come persona in quanto egli è già persona, e non in base a criteri di cooptazione «definiti da quanti sono già stati riconosciuti» (24).
Si ripresenta a questo punto la domanda: tutti gli uomini sono persone? Esistono diritti umani universali, in quanto diritti della persona, oppure non avrebbe più senso parlare di «diritti umani», poiché una parte degli uomini ne sarebbe esclusa? Forse alcuni uomini non sarebbero persone, perché non presenterebbero alcune proprietà morali, come razionalità e autocoscienza, che dovremmo considerare essenziali per definire la persona?
Si potrebbe obiettare che già le caratteristiche con cui, seguendo Spaemann, abbiamo cercato di definire la persona – caratteristiche innanzi tutto di tipo esistenziale o pratico-affettivo – non coincidono con quelle «proprietà morali» essenziali utilizzate da coloro che, come Singer, intendono negare lo statuto di persona a tutti gli esseri umani.
Ma il punto decisivo è un altro: le caratteristiche tipiche della persona vanno intese come caratteristiche che si sviluppano in una serie di stadi, stadi che costituiscono appunto la vita concreta della persona. Non si può sostenere, per esempio, che i neonati e i bambini piccoli non sono persone o, semmai, sono soltanto persone potenziali: «Le persone possono svilupparsi. Tuttavia non si può sviluppare qualcosa per diventare persona. Da qualcosa non si sviluppa qualcuno.
La persona è qualcuno che si trova in determinati stati e precede quindi già da sempre questi stati». Persone potenziali non esistono: dire che il neonato è un essere umano potenziale contraddice non solo il senso comune, ma lo stesso linguaggio, a meno che non si intenda dire che egli è un adulto potenziale. Embrione, feto, neonato, bambino, uomo adulto sono stadi di sviluppo della persona, che «non è il risultato di una trasformazione, ma di una generazione, come la sostanza secondo Aristotele. Essa è sostanza, perché essa è il modo in cui un uomo è».
Si pensi all’uso del pronome personale «io»: iniziamo a dire «io» dopo molto tempo dalla nascita e quando lo diciamo ci riferiamo all’uomo che prima non diceva ancora «io»; «non diciamo “allora è nato qualcosa da quale io mi sono sviluppato”», bensì «io sono nato in quel giorno» ossia «io ero questo essere» (25).
E questo il motivo per cui percepiamo i disabili gravi come persone malate e non come animali di una specie diversa e particolare (anche una sedia difettosa resta sempre una sedia!) e, percependoli come malati e quindi bisognosi di aiuto, cerchiamo di curarli, di ristabilire in qualche modo la loro «natura». Anche i disabili gravi, i malati di mente per esempio, non sono la loro natura, ma hanno la loro natura, pur se in modo gravemente difettoso: «Dal momento che la loro natura è inferma, anche il loro possesso di tale natura è infermo».
Se non possiamo entrare nel loro mondo, non possiamo nemmeno escludere la presenza in essi di intenzionalità e capacità di produrre significati che ci sfuggono: in ogni caso percepiamo che essi non sono ritornati nel regno animale. E la presenza di questi malati, proprio perché non guardiamo alle qualità utili o gradevoli che essi non hanno, può suscitare in noi la ragione specifica del rispetto dell’uomo verso sé stesso: «Ciò che essi danno all’umanità in questo modo, attraverso il loro prendere, è più di quanto essi stessi ricevano» (26).
In conclusione: il riconoscimento dell’essere persona è il riconoscimento di un diritto incondizionato, che non dipende da presupposti empirici: «I diritti umani non vengono conferiti o concessi, ma rivendicati da ciascuno con egual diritto» e sono incondizionati «soltanto quando essi non vengono fatti dipendere dall’adempimento di qualche condizione qualitativa, della cui esistenza decidono coloro che sono già membri della comunità giuridica».
E poiché «la persona è l’uomo e non una qualità dell’uomo», l’unico criterio dell’essere persona è la semplice appartenenza biologica al genere umano: la persona muore quando muore l’uomo, non può morire prima dell’uomo (27).
Note
1) Cit. in «II Foglio», 11.02.2009, p. I (corsivo aggiunto); il cosiddetto mistero della vita, aggiunge Mori, «è roba vecchia, roba superata dai progressi scientifici». Il medesimo entusiasmo per la «rottura dell’incantesimo», ma in versione «compassionevole», è stato espresso dalla scrittrice Lidia Ravera: «Abbiamo pietà dei nostri cagnolini, quando sono malati li portiamo dal veterinario, un’iniezione e via. Perché non abbiamo questa pietà per gli esseri umani? Ringrazio Beppino Englaro» (ibidem). II Giuramento di Ippocrate, come è noto, prescrive: «Non darò a nessuno alcun farmaco mortale neppure se richiestone, né mai proporrò un tale consiglio; ugualmente non darò alle donne pessari per provocare l’aborto» (Ippocrate, Antica medicina. Giuramento del medico, Rusconi, Milano 1998, p. 129).
11) R. Spaemann, Persone. Sulla differenza tra «qualcosa» e «qualcuno», Roma-Bari 2005, Laterza, p. 5.