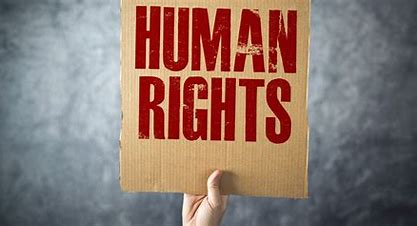Korazim.org 8 aprile 2025
Oggi ricorre uno dei numerosi anniversari (108 quelli disseminati durante tutto l’anno secondo il “Calendario dei Diritti Umani” del Consiglio d’Europa) pensati per “sensibilizzare”, “celebrare”, “formare”, “stimolare la consapevolezza”, “realizzare azioni progettuali” etc. sui diritti dell’uomo.
L’8 aprile, infatti, è la Giornata mondiale dei Rom, una ricorrenza istituita nel 1990 per celebrare la cultura e stigmatizzare le discriminazioni nei confronti di quel popolo che, con termine spregiativo, è conosciuto dai più come “zingaro”.
Degna sicuramente di nota in ricorrenze come l’odierna è l’azione di formazione e informazione storica e culturale volta a fare memoria del fatto che anche i Rom, come gli ebrei, i disabili, i dissidenti politici etc. furono vittime dell’Olocausto nazionalsocialista. Da quando però nel 1945 l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) fu costituita «per riaffermare la fiducia nei diritti umani, nella dignità e nel valore della persona umana» e nel 1948 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, di tutte queste iniziative, obiettivamente, si è perso il conto con tutte le conseguenze del caso riguardo alla loro efficacia e utilità.
Il discorso complessivo sui diritti dell’uomo non può, a questo riguardo, prescindere da quello sull’ideologia dei diritti che, negli ultimi decenni soprattutto, ha causato un’inflazione tale di iniziative, campagne, rivendicazioni etc. che hanno finito per generare un quadro giuridico contraddittorio. Pensiamo per esempio alla rivendicazione del “diritto” all’aborto assieme a quello alla vita, oppure il diritto al lavoro e quello al tempo libero o, infine, quello all’uguaglianza che va di pari passo con la richiesta di riconoscere ogni tipo di diversità. La prospettiva che ne deriva è quella del caos o, in alternativa, quella del relativismo.
Oltretutto, come denunciato da ultimo dal filosofo e politologo francese Alain de Benoist, i “diritti dell’uomo” sono diventati ormai un termine passe-partout, usato per demonizzare gli avversari, emettendo scomuniche dal sapore pseudo-religioso. Nelle interviste raccolte nel libro L’ideologia dei diritti dell’uomo (Bietti editrice, Milano 2023), de Benoist invita a ricollocarli nel contesto storico nel quale sono stati formulati, segnato dall’irruzione della borghesia mercantilistica e dall’aurora della modernità liberal connotata da individualismo, utilitarismo e contraddizioni epocali. Contraddizioni poi trasfuse in quella dei diritti dell’uomo che è diventata una delle ultime religioni laiche del nostro tempo.
Come noto, i diritti umani sono stati solennemente “dichiarati” in diverse occasioni, spesso come preambolo alle carte costituzionali di cui tra la fine del Seicento e il Ventesimo secolo si sono dotati tuttu i Paesi europei, americani e infine quelli di tutto il mondo. Ma questa loro “positivizzazione” cosa ha comportato? Innanzitutto, che la parola “diritto” è connessa sempre alla legislazione statale o internazionale. Alcuni fra i più illuminati giuristi, filosofi e politici anche contemporanei ritengono però che le leggi non possano essere giuste se non discendono da un senso di giustizia universale. Non discendano, quindi, da principi morali-giuridici espressione di quel diritto naturale inscritto nella stessa natura umana.
Se la “bussola” del diritto naturale smette di fare da criterio per il diritto positivo, l’inflazione e la contraddittorietà dei diritti dell’uomo è la conseguenza logica. Senza il riconoscimento di un fondamento oggettivo, naturale, ontologico, la “teoria dei diritti umani” si presta (come accaduto fin dalle sue prime formulazioni del resto) a utilizzi strumentali, politici e, quindi, alla fine ideologici.
Anzitutto sono i due presupposti distintivi dei diritti umani “originati” nel Ventesimo secolo ad averli resi socialmente e politicamente friabili, ovvero il loro carattere individualistico e soggettivistico. Entrambi hanno posto le basi della strumentalizzazione considerando l’uomo come individuo astratto al di fuori dei suoi legami sociali, religiosi e familiari. Che se ne fa l’uomo concreto e reale della sua proprietà senza che i suoi beni siano godibili dalla sua famiglia? Che senso ha per lui essere libero, quando i membri del suo popolo non lo sono? Che vita può essere la sua senza quella dei suoi affetti, o senza poter adorare il suo Dio?
E quando in nome dei “diritti dell’uomo” si distruggono le culture autoctone, introducendo i soli deteriori stili di vita occidentali, come sorprendersi che i popoli così profondamente violentati nella loro identità e specificità non si ribellino?
Come denunciato dal già citato de Benoist, vi sono alcune evidenze nella società globale di oggi difficilmente contestabili che documentano le contraddizioni e derive dell’ideologia dei diritti umani. Anzitutto, il risultato più appariscente di questa ideologia dominante dei diritti è la distruzione morale e giuridica dei rapporti familiari e di quelli religiosi. Entrambi sono destinati a scomparire praticamente con l’imposizione nelle leggi e nelle giurisprudenze dell’individualismo liberal con il conseguente deterioramento dei legami umani in generale.
Questa deriva è suggellata dalla corruzione del significato delle parole che utilizziamo. Nel senso che alle parole non si dà più il senso che hanno. Questo sta succedendo negli ultimi decenni con la teoria del genere [gender] o con quella del razzismo sistematico [Critical Race Theory]. Con l’imporsi di queste ideologie alcuni temi e parole che siamo abituati ad avere care in quanto ereditate dalle nostre tradizioni divengono proibite e motivo di “colpevolezza” o, meglio, d’imputabilità. Sì, perché la caratteristica peculiare di queste due ideologie è che non inducono solo effetti sociali e politici ma anche giuridici. È questo uno dei fattori principali che hanno scatenato il caos e, quindi, l’inflazione e contraddittorietà dei diritti dell’uomo.