Strumenti culturali di Litterae Communionis n.5
I GRANDI DELLA CULTURA MODERNA RIVISITATI
«Un personaggio ha una vita sua, mentre un uomo… un uomo così, in genere, può non essere nessuno» sei personaggi in cerca d’autore
Testo di Franco Colombo
La sua vita
«…e sei tutto e sei niente, e sei niente e sei tutto».
 Pirandello muore a Roma il 10 dicembre 1936. Due anni prima aveva ricevuto il Premio Nobel per la letteratura. Le sue ultime volontà confermano la personalità d’un uomo che aveva sempre sfuggito la teatralità. « /. Sia lasciata passare in silenzio la mia morte. Agli amici, ai nemici preghiera non che di parlarne sui giornali, ma di non farne pur cenno. Né annunzi né partecipazioni. II Morto, non mi si vesta. Mi s’avvolga, nudo, in un lenzuolo. E niente fiori sul letto e nessun cero acceso. III. Carro d’infima classe, quello dei poveri. Nudo. E nessuno m’accompagni, né parenti, né amici. Il carro, il cavallo, il cocchiere e basta. IV. Bruciatemi. E il mio corpo appena arso, sia lasciato disperdere; perché niente, neppure la cenere, vorrei avanzasse di me. Ma se questo non si può fare sia l’urna cineraria portata in Sicilia e murata in qualche rozza pietra nella campagna di Girgenti, dove nacqui».
Pirandello muore a Roma il 10 dicembre 1936. Due anni prima aveva ricevuto il Premio Nobel per la letteratura. Le sue ultime volontà confermano la personalità d’un uomo che aveva sempre sfuggito la teatralità. « /. Sia lasciata passare in silenzio la mia morte. Agli amici, ai nemici preghiera non che di parlarne sui giornali, ma di non farne pur cenno. Né annunzi né partecipazioni. II Morto, non mi si vesta. Mi s’avvolga, nudo, in un lenzuolo. E niente fiori sul letto e nessun cero acceso. III. Carro d’infima classe, quello dei poveri. Nudo. E nessuno m’accompagni, né parenti, né amici. Il carro, il cavallo, il cocchiere e basta. IV. Bruciatemi. E il mio corpo appena arso, sia lasciato disperdere; perché niente, neppure la cenere, vorrei avanzasse di me. Ma se questo non si può fare sia l’urna cineraria portata in Sicilia e murata in qualche rozza pietra nella campagna di Girgenti, dove nacqui».
La scarna solitudine espressa in queste ultime volontà è testimoniata da Corrado Alvaro, amico di Pirandello: «Se ne andava solo come era sempre stato. Arrivò il rappresentante del Governo e lesse sbalordito quel mezzo foglio in cui la scrittura era sicura come forse era stata sicura nei suoi manoscritti giovanili, sicura, perentoria, compiuta. Che ne fosse sconcertato il sacerdote, si capiva… Ma quello che era fuori di sé e per tutt’altre ragioni, era il rappresentante del Governo. Lesse e rilesse quel foglio, se lo copiò, e si domandava come avrebbe fatto a presentarlo al Duce.
Un grande uomo, un uomo celebre che va via in quel modo, chiudendosi la porta alle spalle, senza un saluto, senza un pensiero, senza un omaggio sovratutto, chiedendo di essere coperto appena di un lenzuolo ma da nessuna uniforme, da nessuna camicia nera come era di rito… Disse: “Se n’è andato sbattendo la porta”. Di fronte alla perplessità di quel funzionario c’era da misurare una condizione umana… uno, autore di un racconto col titolo C’è qualcuno che ride, annunciava il nulla a tutta la gloria e a tutta la potenza, ed era lui che rideva. Pirandello, nel punto supremo del suo destino terreno, affermava di essere libero e solo». (1)
L’asciutto testamento e la testimonianza di Corrado Alvaro evidenziano la solidità morale di un uomo che vissuto solo, riaffermava nella morte la libertà della propria solitudine. Alieno da sempre ai colpi di scena, Pirandello ha sempre condotto una vita estremamente riservata tra una cerchia d’amici molto ristretta. Sono lontane le “performances” artistico-esistenziali del vate D’Annunzio, Lo stesso regime si vede sbatter la porta in faccia da chi privilegiava una vita anteriore del tutto scevra da condizionamenti.
Questa è la tappa finale ma illuminante di un cammino di vita iniziato il 28 giugno 1867. Pirandello nasce nella villa campestre ove la famiglia si era rifugiata durante un’epidemia di colera. Porta nel sangue le tradizioni, la linfa di una progenie tutta garibaldina ad eccezione d’uno zio sacerdote, che, pur fedele ai Borboni, accolse in casa e mantenne i fratelli di fede contraria. Il padre Stefano, ultimo di ventiquattro fratelli, aveva combattuto con Garibaldi sino allo scontro dell’Aspromonte, occasione in cui luogotenente dell’irrequieto eroe era Rocco Ricci Granitto, fratello della futura madre dello scrittore.
Questo zio, che pare abbia addirittura portato dall’Aspromonte lo stivale forato di Garibaldi, ospiterà Pirandello nella propria casa romana allorché dall’università di Palermo egli passerà a quella della capitale. Aveva scelto di continuare gli studi dopo una giovinezza in cui già era emersa la sua forte sensibilità verso la vita ed i suoi casi. Ed è per studiare con maggiore concentrazione che si reca a Roma.
E’ l’anno 1887: governa il paese per la prima volta il Crispi; è il periodo in cui si allarga in Italia come in Europa la questione sociale. Cresciuto dentro le forti idealità di coloro che avevano combattuto per l’unità, Pirandello è più che mai cosciente delle disillusioni ormai cocenti di questi uomini. Vivrà personalmente gli scandali di questi anni, primo fra tutti quello della Banca romana del 1893, descritto con amarezza ne / vecchi e i giovani. In questo anno (1893) Pirandello è appena rientrato da Bonn dove ha conseguito la laurea con una discussione sul tema Suoni e sviluppi di suono della parlata di Girgenti. Aveva lasciato la università romana per un litigio con un professore, rientra nella capitale perché ammalato, e qui si stabilisce.
Grazie all’assegno paterno può dedicarsi liberamente alle lettere, guidato nei primi anni da Luigi Capuana, su consiglio del quale scrive il primo romanzo: L’esclusa (1893). Negli anni successivi la sua attività s’intensifica. Scrive numerosi articoli su giornali e riviste, compone le sue prime novelle e il secondo romanzo, II turno (1895).
Nel 1897 inizia pure la collaborazione alla rivista «Marzocco». I suoi saggi erano improntati ad un tenace antidannunzianesimo e ciò fu la causa di non poche polemiche con il mondo letterario del tempo, in cui il D’Annunzio imperava. Questo provocò anche la diffidenza degli editori che solo dietro la caparbia insistenza del Capuana pubblicarono, prima con incertezze poi con sempre più vivo interesse, le opere pirandelliane.
Nel 1894 frattanto Pirandello si era sposato con Maria Antonietta Portolano da cui ebbe tre figli. La felicità del momento viene interrotta bruscamente dal fallimento economico del padre. La notizia provoca nella signora Maria Antonietta una tale impressione che il suo fisico e la sua mente cederanno. Improvvisamente Pirandello si ritrova senza alcuna sostanza e con la moglie gravemente inferma. Lo aiuteranno il forte carattere e la determinazione dei momenti difficili. Grazie ai proventi dell’insegnamento e delle sue, sino ad allora gratuite, collaborazioni editoriali, lo scrittore riuscirà a salvaguardare il mantenimento della non piccola famiglia.
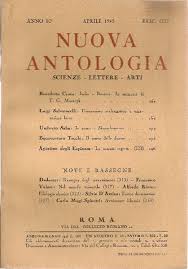 In questo difficile periodo la rivista «La Nuova Antologia» gli richiede un romanzo. La difficoltà del momento solletica l’azzardo e lo scrittore promette un’opera che non c’è o meglio di cui c’è solo il titolo: Il fu Mattia Pascal. Verrà pubblicato periodicamente e Pirandello lo scriverà «a puntate». E’ l’inizio della grande produzione pirandelliana, sta per giungere il successo. Ma alla fortuna dello scrittore fa da contrasto la difficile vicenda dell’uomo. Le difficoltà nascevano da una situazione familiare piuttosto critica, in cui la malattia della moglie creava non pochi problemi. Ciò nonostante Pirandello si lasciò convincere ad internarla in una casa di cura solo nel 1919, dopo esserle stato sempre vicino.
In questo difficile periodo la rivista «La Nuova Antologia» gli richiede un romanzo. La difficoltà del momento solletica l’azzardo e lo scrittore promette un’opera che non c’è o meglio di cui c’è solo il titolo: Il fu Mattia Pascal. Verrà pubblicato periodicamente e Pirandello lo scriverà «a puntate». E’ l’inizio della grande produzione pirandelliana, sta per giungere il successo. Ma alla fortuna dello scrittore fa da contrasto la difficile vicenda dell’uomo. Le difficoltà nascevano da una situazione familiare piuttosto critica, in cui la malattia della moglie creava non pochi problemi. Ciò nonostante Pirandello si lasciò convincere ad internarla in una casa di cura solo nel 1919, dopo esserle stato sempre vicino.
Questi anni contribuiranno a rafforzare la solitudine dello scrittore il cui atteggiamento nei confronti della vita procederà di pari passo con le sue opere. Anche negli anni della sua più grande produzione, ormai impegnato non più solo come autore bensì anche come uomo di teatro sui palcoscenici del mondo, Pirandello conserverà il proprio dignitoso distacco, la propria costituzionale riservatezza.
E’ lui stesso a darci un quadro della sua vita in una lettera del 15 ottobre 1924: «Vivo a Roma quanto più posso ritirato; non esco che per poche ore soltanto sul far della sera, per fare un po’ di moto, e m’accompagno se mi capita, con qualche amico: Giustino Ferri o Ugo Fleres. Non vado che rarissimamente a teatro. Alle 10, ogni sera, sono a letto. Mi levo la mattina per tempo e lavoro abitualmente sino alle 12. Il dopo pranzo, dì solito, mi rimetto a tavolino alle 2 e mezza, e sto fino alle 5 e mezza; ma, dopo le ore della mattina, non scrivo più, se non per qualche urgente necessità; piuttosto leggo o studio. La sera, dopo cena, sto un po’ a conversar con la mia famigliuola, leggo i titoli degli articoli, e a letto. Come si vede nella mia vita non c’è niente che meriti di essere rilevato: è tutta inferiore, nel mio lavoro e nei miei pensieri che… non sono lieti. Io penso che la vita è una molto triste buffoneria, poiché abbiamo in noi, senza poter sapere né come né perché né da chi, la necessità d’ingannare di continuo, noi stessi con la spontanea creazione di una realtà (una per ciascuno e non mai la stessa per tutti) la quale di tratto in tratto si scopre vana e illusoria. Chi ha capito il giuoco, non riesce più ad ingannarsi; ma chi non riesce più ad ingannarsi non può più prendere né gusto né piacere alla vita. Cosi è. La mia arte è piena di compassione amara per tutti quelli che s’ingannano; ma questa compassione non può non essere seguita dalla feroce ir-risione del destino, che condanna l’uomo all’inganno » (Saggi).
Questa allergia alle convenienze sociali non è neppure contraddetta dallo scrittore nell’ultimo periodo della sua vita. Egli infatti col successo si trovò ad essere suo malgrado un uomo pubblico. Le sue opere si rappresentavano ovunque, dappertutto si richiedeva la sua presenza. Ebbene nel parlare di sé e della sua opera egli non vendeva la propria merce bensì difendeva la propria arte, che, come i suoi personaggi, sentiva del resto sempre più staccata da sé.
 «Eccomi qua pronto a rispondere a quelle domande che vi piacerà rivolgermi, purché siano discrete, o sulla letteratura in genere o più propriamente sul teatro o anche intorno a ciò che purtroppo suoi chiamarsi il mio pensiero filosofico, benché io non mi sia mai assunto nessuna responsabilità filosofica e mi sia inteso sempre e soltanto di fare arte, secondo le mie possibilità, non filosofia. Certo, da tutta la mia opera fantastica, si può dedurre un particolare modo che io ho sempre avuto di considerare il mondo e la vita. Questo modo, che a me pare naturalissimo, ed espresso nel modo che a me sembra più proprio e più chiaro, sembra invece agli altri, spesso, strano ed oscuro. Signori, originali si è o non si è. Non si può essere originali per forza. Chi vuoi essere originale, sarà stravagante, non originale… chi è veramente originale non sa neppure di esserlo. Lo è perché vede il mondo e la vita con occhi nuovi; e come vede, dice e scrive: dice e scrive parole nuove, parole sue e non d’altri. E non vuoi farlo apposta. Signori io vi giuro che il mio teatro non l’ho fatto apposta. Quasi, anzi, vorrei non averlo fatto così, anche per non sentirmi più dire che esso è nuovo».
«Eccomi qua pronto a rispondere a quelle domande che vi piacerà rivolgermi, purché siano discrete, o sulla letteratura in genere o più propriamente sul teatro o anche intorno a ciò che purtroppo suoi chiamarsi il mio pensiero filosofico, benché io non mi sia mai assunto nessuna responsabilità filosofica e mi sia inteso sempre e soltanto di fare arte, secondo le mie possibilità, non filosofia. Certo, da tutta la mia opera fantastica, si può dedurre un particolare modo che io ho sempre avuto di considerare il mondo e la vita. Questo modo, che a me pare naturalissimo, ed espresso nel modo che a me sembra più proprio e più chiaro, sembra invece agli altri, spesso, strano ed oscuro. Signori, originali si è o non si è. Non si può essere originali per forza. Chi vuoi essere originale, sarà stravagante, non originale… chi è veramente originale non sa neppure di esserlo. Lo è perché vede il mondo e la vita con occhi nuovi; e come vede, dice e scrive: dice e scrive parole nuove, parole sue e non d’altri. E non vuoi farlo apposta. Signori io vi giuro che il mio teatro non l’ho fatto apposta. Quasi, anzi, vorrei non averlo fatto così, anche per non sentirmi più dire che esso è nuovo».
Niente di studiato, quindi, ma tanto nella vita quanto nelle opere Pirandello è sempre fedele a sé, perché «non si può essere originali per forza». Lontana dai clamori e dai colpi di scena la vita di Pirandello è stata il non facile cammino di un uomo che ha cercato, soprattutto attraverso la propria creatività poetica, di superare le superficialità illusone di un’esistenza alienante e proprio per questo falsa. Tutto questo nella consapevolezza della necessità di superare l’egoismo isolato ed isolante del «per sé», onde assegnare un senso assoluto ed universale alla vita.
La sua opera
«Si nasce alla vita in tanti modi, si nasce anche personaggi!».
Il sentimento del contrario: II saggio sull’umorismo
 Nella pausa creativa che dal 1904 al 1908 trova Pirandello intento a dare ordine al suo castello raziocinante, si colloca tra gli altri il Saggio sull’umorismo (1908). Riteniamo importante, per comprendere l’opera pirandelliana, questa sorta di summa ideologica, posta com’è al centro d’una maturazione e di una crescita letteraria che proprio in questi anni toccava vertici già elevati (del 1904 è la pubblicazione de // fu Mattia Pascal).
Nella pausa creativa che dal 1904 al 1908 trova Pirandello intento a dare ordine al suo castello raziocinante, si colloca tra gli altri il Saggio sull’umorismo (1908). Riteniamo importante, per comprendere l’opera pirandelliana, questa sorta di summa ideologica, posta com’è al centro d’una maturazione e di una crescita letteraria che proprio in questi anni toccava vertici già elevati (del 1904 è la pubblicazione de // fu Mattia Pascal).
In questo saggio Pirandello da lucida spiegazione di quel sentimento del contrario o coscienza della contraddizione che nasce tra la vita e la forma, tra l’anelito ad una pienezza e ad una libertà del vissuto e le costrizioni dei ruoli che vuoi la società, vuoi i doveri e le colpe c’impongono. «… la tristizia degli uomini si deve spesso alla tristezza della vita, ai mali di cui essa è piena e che non tutti sanno o possono sopportare; induce a riflettere che la vita, non avendo fatalmente per la ragione umana un fine chiaro e determinato, bisogna che, per non brancolar nel vuoto, ne abbia uno particolare, fittizio, illusorio, per ciascun uomo, o basso o alto» (L’umorismo).
Queste finzioni nelle quali l’uomo crede di realizzarsi pienamente sono poste in crisi dall’intervento della riflessione che le smaschera e le scopre giustapposte quali sono veramente. Il comico, ch’è l’avvertimento del contrario, si trasforma così in umorismo, che altro non è se non la «drammatizzazione del comico». Pirandello ce ne da fulgida dimostrazione nell’esempio della vecchina imbellettata oltre misura, il cui voler essere altro da quello che realmente è, non può non suscitare, in un primo tempo, il riso.
«Ma se ora interviene in me la riflessione, e mi suggerisce che quella vecchia signora non prova forse nessun piacere a pararsi così come un pappagallo, ma che forse ne soffre e lo fa soltanto perché pietosamente si inganna, che parata così, nascondendo così le sue rughe e le canizie, riesca a trattenere a sé l’amore del marito più giovane di lei, ecco che io non posso più riderne come prima, perché appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto andar oltre a quel primo avvertimento o piuttosto più addentro; da quel primo avvertimento del contrario mi ha fatto passare a questo sentimento del contrario.» (L’umorismo).
Troviamo così in questa sistemazione del pensiero pirandelliano i due elementi portanti della sua opera: il desiderio profondo della vita, e la coscienza del vivere. La tumultuosa adesione alle illusioni ed alle fittizie messe in scena dell’esistenza e la persuasione cosciente del sentirsi vivere. Nel Saggio sull’umorismo sono quindi in un certo senso codificate quelle tensioni vitali che possiamo ritrovare nell’affollata umanità dell’intera opera pirandelliana.
Le «Novelle per un anno»
 II corpus delle novelle offre da sé un panorama umano caleidoscopico ed affascinate. Esse ci presentano una tale varietà di casi da rendere del tutto inutile la ricerca di una loro organica unità. I molteplici aspetti che ci riservano sono equiparabili agli innumerevoli mondi che ciascuno di noi porta con sé.
II corpus delle novelle offre da sé un panorama umano caleidoscopico ed affascinate. Esse ci presentano una tale varietà di casi da rendere del tutto inutile la ricerca di una loro organica unità. I molteplici aspetti che ci riservano sono equiparabili agli innumerevoli mondi che ciascuno di noi porta con sé.
Nella prima stagione della novellistica (1895-1902), l’autore sembra quasi registrare quei casi umani il cui comun denominatore è la sofferenza. I luoghi in cui essi trovano svolgimento sono essenzialmente Roma e la Sicilia, due ambienti naturali che presto però assumono una loro ben precisa valenza sociale: da una parte la Roma borghese, dall’altra la Sicilia popolana. Il dramma di questa ambivalenza è la disperata vicenda di Annicchia Marullo (La balia).
Giunta a Roma dalla Sicilia per far da balia in un’agiata famiglia, sperimenterà l’incomprensione e l’incomunicabilità tra due mondi non solo diversi ma anche disarticolati. La sua prima uscita in una Roma ai suoi occhi grande e quasi fagocitante è la inconsapevole presa di coscienza di un destino: «Rientrò in casa, da quella prima passeggiata, stordita, quasi vacillante, con gli orecchi che le ronzavano, come se fosse stata in mezzo ad un tumulto ed avesse faticato tanto ad uscirne. E si senti di gran lunga, di gran lunga più lontana dal suo paese, come non si sarebbe mai immaginato, e quasi sperduta in un altro mondo che non le pareva ancor vero» (La balia). Annicchia sarà vittima della propria innocenza ed inferiorità sociale, raggirata dall’altrui ipocrisia e spietatezza.
In questo mondo sofferto, persino la morte sembra un’inutile scelta, una protesta che non coglie il segno. Così è per Cesarino Brei ed il fratellino Nini (In silenzio), il loro suicidio non può apparire che inutile e superfluo di fronte all’ingiustizia della vita. Manca ancora all’uomo pirandelliano proprio la coscienza che il dramma della vita non è da ricercarsi nelle ingiustizie umane o sociali, bensì nella vita stessa. Emerge però sin d’ora il senso della disperata condizione umana per cui la vita è «…a lampi e a cantonate… ogni tanto, un lampo; ma per veder che cosa? Una cantonata. » (Notizie dal mondo).
Nelle novelle dei primi anni del secolo viene delineandosi il tema della parte che ciascuno dentro la società assume o si vede obbligato ad assumere. E’ questa forma la maschera dietro la quale nascondersi per vivere così una vita di sole apparenze, come per Carlino Sgro in Tirocinio, oppure l’incancellabile marchio dell’infamia e della colpa da cui non si riesce ad uscire. Diego Bronner (nella novella E due!) subisce questa classificazione sociale. Ha sbagliato, ha pagato alla società il suo errore ma ciò non è stato sufficiente: è e sarà per sempre «un colpevole».
Ma non basta! Spettatore impotente di un suicidio ne rimane talmente colpito che, vittima di quell’evento, si uccide anche egli gettandosi da un ponte come aveva visto fare a chi l’aveva preceduto. «E due!» dice tra sé. E’ la matematica disperata dell’assurdo; la vita corrosa ed in ultimo spezzata dalla crudeltà di una forma insostenibile e quindi soffocante.
E’, infine, nelle novelle della seconda stagione (dal 1908 in poi) che il protagonista pirandelliano acquista coscienza di sé e del proprio dramma. Avviene in queste novelle la sapiente fusione tra l’elemento ideologico e quello narrativo.
Il sentirsi oggetto del tradimento della vita: è questa persuasione la nuova emblematica coscienza dei personaggi pirandelliani. «Ma che vuoi dire, — sostiene il protagonista de La trappola — darsi una realtà, se non fissarsi in un sentimento, rapprendersi, irrigidirsi, incrostarsi in esso? E dunque, arrestare in noi il perpetuo movimento vitale, far di noi tanti piccoli e miseri stagni in attesa di putrefazione, mentre la vita è flusso continuo, incandescente di indistinto… La vita è il vento, la vita è il mare, la vita è il fuoco; non la terra che si incrosta e assume forma. Ogni forma è la morte.» (La trappola).
Ancora la forma (cioè la parte), con in più la coscienza del doverla subire. Tutto allora è relativo, non esiste alcuna realtà se non quella che ci diamo noi. Il dolore della vita, questa condanna del perenne non-essere trova emblematica rappresentazione nella storia della signora Leuca, la cui parte è una quasi serena rassegnazione nei confronti della vita.
«La vita? Eh già, proprio quella la vita: una vergogna da non potersi nemmeno confessare; una miseria da compatire così., stringendo le spalle e socchiudendo gli occhi, o spingendo su su il mento come fosse anche un ben duro e amaro boccone da ingozzare. E che cos’era allora questa che da undici anni lei, la signora Leuca, viveva qua in questa sua casa monda e schiva, con le discrete visite di tanto in tanto delle sue buone amiche del patronato di beneficenza e del dotto parroco di Sant’Agnese e di quel bravo signor Ildebrando l’organista?» (Pena di vivere così).
Una domanda quest’ultima che non trova risposta. E’ mai possibile che il vivere possa coincidere con il suo opposto? Che la vita cui si aggrappa sia appiglio vano trasformantesi nella coscienza della sua illusorietà?
I romanzi
 II vivere ed il non vivere, l’esserci ed il non esserci, sono l’inconsueta esperienza di Mattia Pascal, che privato della vita, di fronte al proprio «suicidio» inventa una nuova esistenza. E’ la trovata, per molti versi geniale, de II fu Mattia Pascal, che pubblicato nel 1904 segue la precedente uscita di altri due romanzi, L’esclusa e // turno. In questi, come ne I vecchi e i giovani (1909), Pirandello è mosso da quella tensione, già evidenziata per la prima stagione novellistica, di riprendere una umanità, una società dentro la sua sofferenza e disillusione.
II vivere ed il non vivere, l’esserci ed il non esserci, sono l’inconsueta esperienza di Mattia Pascal, che privato della vita, di fronte al proprio «suicidio» inventa una nuova esistenza. E’ la trovata, per molti versi geniale, de II fu Mattia Pascal, che pubblicato nel 1904 segue la precedente uscita di altri due romanzi, L’esclusa e // turno. In questi, come ne I vecchi e i giovani (1909), Pirandello è mosso da quella tensione, già evidenziata per la prima stagione novellistica, di riprendere una umanità, una società dentro la sua sofferenza e disillusione.
Ne II fu Mattia Pascal questo stadio è superato e l’umorismo pirandelliano opera già distesamente. Mattia Pascal, angariato da una vita opprimente, si trova graziato dalla scoperta del proprio «suicidio». La nuova esistenza come Adriano Meis, in un primo tempo scevra d’ogni vincolo, lo ritrova poi di fronte alla realtà della propria nullità ed impotenza: «…i morti non debbono più morire ed io sì: io sono ancora vivo per la morte e morto per la vita».
Il ritorno alla primigenia identità, frutto di un «secondo suicidio», lo ritroverà fuori della vita e si riveleranno allora dense di significato le parole del vecchio Anselmo Paleari: «A noi uomini … nascendo, è toccato un tristo privilegio: quello di sentirci vivere, con la bella illusione che ne risulta: di prendere cioè come una realtà fuori di noi questo nostro interno sentimento della vita, mutabile e vario, secondo i tempi, i casi e la fortuna.»
La «gran mercantessa di vetri colorati» ch’è l’illusione, porterà alla pazzia dell’incoerenza assoluta un altro grande protagonista dell’opera pirandelliana, quel Vitangelo Moscarda che in Uno, nessuno, centomila sfida la vita e le sue apparenze vedendosi così confinato, privato di tutto, in un ospizio, dove sembra aver raggiunto quella forma perfetta, ch’è la solitudine di chi vive fuori della vita: «Muoio ogni attimo, io, e rinasco nuovo e senza ricordi: vivo e intero, non più in me, ma in ogni cosa fuori».
Il banale accadimento (il naso storto) che lo rende cosciente d’essere per sé ciò che non è per gli altri, è l’inizio della china verso l’incapacità a ritrovarsi se non nell’astrazione del fuori di sé. Vitangelo Moscarda è già un personaggio della grande stagione drammaturgica pirandelliana.
«I più accreditati santoni della narrativa ottocentesca s’erano industriati a costruire il loro personaggio pezzo per pezzo. Egli (Pirandello) quel personaggio si sarebbe «divertito» a smontarlo, con umorismo ed ironia crudele, di chi vede l’uomo inghiottito dall’ombra che lo segue dappresso. Non è più l’uomo… come in Mattia Pascal, che ha ceduto l’ombra, bensì l’ombra che ha perduto l’uomo: ombre vane spettrali, in cerca di un corpo. I Sei personaggi sono già silenziosamente in marcia per raggiungere il palcoscenico del loro teatro ». (2)
 Ad ingigantire questo incedere verso la stagione teatrale, culmine di tutta l’opera pirandelliana, aveva già contribuito il romanzo Quaderni di Serafino Gubbio operatore, pubblicato nel 1915 col titolo di Si gira. Serafino Gubbio svolge la professione di operatore presso la casa cinematografica Kosmograph; il suo lavoro lo pone nella condizione di coscientizzare una dimensione del tutto marginale nei confronti di una vita che va rivelando la sua relatività: «Sono operatore. Ma veramente, essere operatore, nel mondo in cui vivo e di cui vivo, non vuoi mica dire operare. Io non opero nulla… Un signore venuto a curiosare, una volta mi domandò: — Scusi non si è ancora trovato il modo di far girare la macchinetta da sé? … era malizioso. Perché con quella domanda voleva dirmi: — Siete proprio necessario voi? Che cosa siete voi? Una mano che gira la manovella». Essere l’impassibile mano che gira la manovella è dunque la condizione di Serafino, il quale proietterà anche nella vita questo marginalismo. Egli «osserva» infatti, nel suo vivere, un mondo le cui passioni, vere o presunte non lo scuotono se non raramente dalla sua poltrona di spettatore.
Ad ingigantire questo incedere verso la stagione teatrale, culmine di tutta l’opera pirandelliana, aveva già contribuito il romanzo Quaderni di Serafino Gubbio operatore, pubblicato nel 1915 col titolo di Si gira. Serafino Gubbio svolge la professione di operatore presso la casa cinematografica Kosmograph; il suo lavoro lo pone nella condizione di coscientizzare una dimensione del tutto marginale nei confronti di una vita che va rivelando la sua relatività: «Sono operatore. Ma veramente, essere operatore, nel mondo in cui vivo e di cui vivo, non vuoi mica dire operare. Io non opero nulla… Un signore venuto a curiosare, una volta mi domandò: — Scusi non si è ancora trovato il modo di far girare la macchinetta da sé? … era malizioso. Perché con quella domanda voleva dirmi: — Siete proprio necessario voi? Che cosa siete voi? Una mano che gira la manovella». Essere l’impassibile mano che gira la manovella è dunque la condizione di Serafino, il quale proietterà anche nella vita questo marginalismo. Egli «osserva» infatti, nel suo vivere, un mondo le cui passioni, vere o presunte non lo scuotono se non raramente dalla sua poltrona di spettatore.
II crollo delle ultime certezze, il constatare la fine di un mondo cui dalla giovinezza era rimasto molto legato, sarà il colpo definitivo, la spinta fatale verso il baratro dell’estraneità assoluta. Dopo le ultime disillusioni lo stato d’animo di Serafino è quello di colui che ha perso ogni riferimento e vive nel vuoto. La parabola sta per completarsi.
Nell’ultimo tratto del romanzo Serafino gira, dentro una gabbia, solo con l’attore protagonista, la scena dell’uccisione di una tigre. Ma la realtà della vita entra di viva forza dentro «l’irreale realtà» del canovaccio cinematografico. Reso folle dalla passione, Nuti, l’attore protagonista, spara non alla tigre, bensì alla Nestoroff, la prima attrice, che assisteva all’azione scenica.
Quasi in una nemesi passionale, il Muti stesso viene sbranato dalla tigre, finita a sua volta da un provvidenziale colpo di pistola. Mentre in pochi attimi-secondi la situazione precipita, Serafino Gubbio continua impassibile a girare: «…fui tratto indietro strappato dalla gabbia con la manovella della macchinetta così serrata nel pugno, che non fu possibile in prima strapparmela. Non gemevo, non gridavo: la voce, dal terrore, mi s’era spenta in gola, per sempre».
Nel mutismo più assoluto, nel suo «silenzio di cosa» Serafino Gubbio giunge all’ultima tappa del suo cammino dentro l’illusorietà della vita. Questo viaggio è in parte comune anche al suo autore. «Di fronte alla ormai scoperta e irreversibile condanna dell’uomo, questo romanzo è precisamente la radiografia della poetica pirandelliana, il suo evolvere da un atteggiamento di partecipazione attiva al dramma delle sue creature a un atteggiamento di pura contemplazione». (3)
Con Serafino Gubbio e Vitangelo Moscarda, Pirandello è ormai giunto alle soglie della sua più straordinaria stagione creativa, i Sei personaggi stanno per entrare in teatro alla ricerca d’un autore.
Il teatro
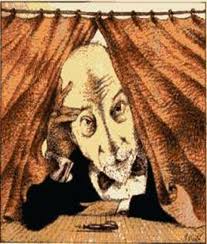 Tutta l’opera di Pirandello giunge alla sua esaltazione nel teatro. La stagione teatrale testimonia l’avvenuta maturazione della coscienza pirandelliana che in tante opere, anche grandi, era andata crescendo. Escludendo i primi lavori da La morsa (1898) a // dovere del medico (1911), possiamo dire che il momento magico del teatro pirandelliano inizia con All’uscita (1916) e Così è (se vi pare) (1917), parabole, come le chiama l’autore, in cui non esiste ancora dialettica tra la tragica condizione umana e la coscienza raziocinante del suo esistere. Generatasi questa dialettica ecco allora nascere il grande teatro di cui Pirandello è il Poeta. Da // berretto a sonagli a Il gioco delle parti; da Ma non è una cosa seria a La vita che ti diedi, per citarne solo alcune.
Tutta l’opera di Pirandello giunge alla sua esaltazione nel teatro. La stagione teatrale testimonia l’avvenuta maturazione della coscienza pirandelliana che in tante opere, anche grandi, era andata crescendo. Escludendo i primi lavori da La morsa (1898) a // dovere del medico (1911), possiamo dire che il momento magico del teatro pirandelliano inizia con All’uscita (1916) e Così è (se vi pare) (1917), parabole, come le chiama l’autore, in cui non esiste ancora dialettica tra la tragica condizione umana e la coscienza raziocinante del suo esistere. Generatasi questa dialettica ecco allora nascere il grande teatro di cui Pirandello è il Poeta. Da // berretto a sonagli a Il gioco delle parti; da Ma non è una cosa seria a La vita che ti diedi, per citarne solo alcune.
E’ però nei Sei personaggi in cerca d’autore e nell’Enrico IV che Pirandello tocca i punti più elevati del suo creare. I sei personaggi ricercano un autore che dia loro la possibilità di svolgere quel dramma per cui sono «nati»; Enrico IV, essendogli venuta meno la forza di rappresentare sul palcoscenico della vita il proprio dramma di uomo autentico, accetta la «bollatura» di chi lo vuole pazzo, recitando a sé stesso ed agli altri la propria pazzia cosciente.
Questi i poli culminanti dell’iceberg pirandelliano. Da un lato sei figure, o meglio sei ombre la cui realtà appare a volte più cruda, più solidamente ingenerata rispetto a chi, uomo, vive la labilità temporale. Dall’altro un uomo, ormai ombra a se stesso, la cui vita diviene lucida pazzia per sfuggire la normalità ipocrita di chi giudica senza pietà l’altrui vivere.
Su di un palcoscenico «senza quinte né scena, quasi al buio e vuoto», durante le prove de // gioco delle parti (la commedia di un certo Pirandello), si materializzano sei personaggi introdotti non si sa come da un usciere. Approdano al palcoscenico dalle nebbie fumigose della cerebralità coronarica d’un autore che non ha saputo dar loro una rappresentabilità. «Nati» per il dramma, vivono la tragica sospensione della bonaccia atemporale dell’irrappresentabilità.
Il Padre, la Madre, la Figliastra, il Figlio, i due Bambini, giungono con la loro angoscia ad un palcoscenico: loro, nati personaggi, cercano un autore. Il Padre: « …l’autore che ci creò, vivi, non volle poi, o non potè materialmente, metterci al mondo dell’arte. E fu un vero delitto, signore, perché chi ha la ventura di nascere personaggio vivo, può ridersi anche della morte. Non muore più! Morrà l’uomo, lo scrittore, strumento della creazione; la creatura non muore più! E per vivere eterna non ha neanche bisogno di straordinarie doti o di compiere prodigi. Chi era Sancho Panza? Chi era Don Abbondio? Eppure vivono eterni, perché — vivi germi — ebbero la ventura di trovare una matrice feconda, una fantasia che li seppe allevare e nutrire, far vivere per l’eternità! Il capocomico: Tutto questo va benissimo! Ma che cosa vogliono loro qua? Il padre: Vogliamo vivere, signore! » (Sei personaggi).
 Di fronte allo sdegno incredulo del capocomico e degli attori si pone l’anelante caparbietà dei personaggi. «Nell’azione si fronteggiano in un rapporto complesso due gruppi: gli «attori» ed i «personaggi». Gli attori sono uomini che si presentano come maschere. Essi stanno provando una commedia e pur apparendo al pubblico in abiti quotidiani, con un palcoscenico aperto e privo di allestimenti, come in un episodio di vita reale, denunciano la propria essenza di forme vuote che ricevono i contenuti dai personaggi interpretati (realtà della finzione).
Di fronte allo sdegno incredulo del capocomico e degli attori si pone l’anelante caparbietà dei personaggi. «Nell’azione si fronteggiano in un rapporto complesso due gruppi: gli «attori» ed i «personaggi». Gli attori sono uomini che si presentano come maschere. Essi stanno provando una commedia e pur apparendo al pubblico in abiti quotidiani, con un palcoscenico aperto e privo di allestimenti, come in un episodio di vita reale, denunciano la propria essenza di forme vuote che ricevono i contenuti dai personaggi interpretati (realtà della finzione).
I «personaggi» sono maschere che si presentano come uomini. Mossi da un impulso vitale ancora indifferenziato, sono figure fantastiche ma vere, passioni immaginarie ma autentiche, che fanno irruzione nella realtà del palcoscenico, chiedendo imperiosamente di assumere una forma in cui esprimersi e atteggiandosi come attori che recitano una parte (finzione della realtà). (4)
E’ il teatro nel teatro, l’azione senza intreccio di un dramma che pur tende nella sua irrisolvibilità ad una ipotetica catarsi. Le prime resistenze del capocomico e degli attori sono vinte, anch’essi risucchiati dentro il gorgo mulinante del dramma da rappresentarsi. Soprattutto la figliastra pare fremere più d’ogni altro: «Senta per favore: ce lo faccia rappresentare subito, questo dramma, perché vedrà che ad un certo punto io… io prenderò il volo! Sissignore! prenderò il volo! il volo!» (Sei personaggi).
Prendere il volo, liberarsi d’una tragica «vita» senza soluzione, per affidarla al palcoscenico, il luogo dove si gioca a fare sul serio. Ecco allora dipanarsi tra svenimenti ed alterchi la vicenda delle sei apparizioni, ora sin troppo reali. Il capocomico prima spazientito ne è poi irretito. Si ritira col Padre per stendere un primo canovaccio; rientra, affida le parti ed ecco di nuovo frapporsi tra rappresentazione e realtà l’ingovernabile scontro degli attori con i personaggi. Da una parte chi vuoi rappresentare un dramma, dall’altra chi vuoi vivere perché nato per questo.
«Il padre. …Perché — veda — qua per lei e per i suoi attori si tratta soltanto — ed è giusto — del loro giuoco… il giuoco della loro arte, che deve dare appunto — come dice il signore — una perfetta illusione di realtà… Ora se lei pensa che noi come noi non abbiamo altra realtà fuori di questa illusione!… Ma sì, signori! Quale altra? Quella che per loro è un’illusione da creare, per noi è invece l’unica nostra realtà. Ma non soltanto per noi, del resto, badi! Ci pensi bene. Mi sa dire chi è lei? Il capocomico. Come, chi sono? — Sono io!… Il padre. Un personaggio, signore, può sempre domandare a un uomo chi è. Perché un personaggio ha veramente una vita sua, segnata di caratteri suoi, per cui è sempre «qualcuno». Mentre un uomo — non dico lei, adesso — un uomo cosi in genere, può non essere «nessuno».
L’illusorietà di una realtà immutabile di fronte ad una realtà che muta ed è per questo illusoria. Il personaggio che è, e l’uomo che non riesce ad affermare il proprio essere. E’ questo l’altro iter drammatico che si va a sovrapporre agli altri dentro una scena spoglia eppur turgida di sentimenti e di tensione raziocinante. Manca una trama? Mancano i fatti?
«Ma un fatto è come un sacco: vuoto non si regge. Perché si regga bisogna prima farci entrar dentro la ragione ed i sentimenti che lo han determinato». Di sentimenti, di spirito raziocinante i sei personaggi traboccano. La loro forza evocativa compirà persino un altro «miracolo». Quasi dal nulla, evocata apparentemente da qualche cappellino, piomberà entro la sala Madama Pace, equivoca commerciante, «megera d’enorme grassezza, con una pomposa parrucca di lana colar carota e una rosa fiammante da un lato».
Alle reiterate domande di stupore degli attori, alle accuse più o meno velate di teatralismo, il Padre risponde quasi sdegnato: « Ma scusino! Perché vogliono guastare, in nome d’una verità volgare, di fatto, questo prodigio di una realtà che nasce, evocata, attratta, formata dalla stessa scena, e che ha più diritto di vivere qui, che loro; perché assai più vera di loro? Quale attrice fra loro rifarà poi Madama Pace? Ebbene: Madama Pace è quella! Mi concederanno che l’attrice che la rifarà, sarà meno vera di quella che è lei in persona! ».
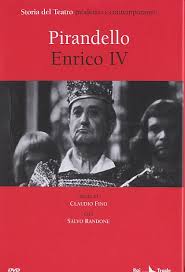 La realtà della scena si è sovrapposta ancora una volta alla realtà della vita. L’illusione diviene reale, la realtà appare fragile come l’illusione. I sei personaggi continuano con assoluta fedeltà la loro tragedia. Perseguono la rappresentazione del loro sentimento: il rimorso per il Padre, la vendetta per la figliastra, lo sdegno per il Figlio, il dolore per la Madre. I due figlioletti sono allo stato puro delle mute ombre, «presenze» che genereranno il culmine del dramma. Il bambino di fronte alla sorellina affogata si sparerà. La detonazione creerà il panico: finzione? realtà?
La realtà della scena si è sovrapposta ancora una volta alla realtà della vita. L’illusione diviene reale, la realtà appare fragile come l’illusione. I sei personaggi continuano con assoluta fedeltà la loro tragedia. Perseguono la rappresentazione del loro sentimento: il rimorso per il Padre, la vendetta per la figliastra, lo sdegno per il Figlio, il dolore per la Madre. I due figlioletti sono allo stato puro delle mute ombre, «presenze» che genereranno il culmine del dramma. Il bambino di fronte alla sorellina affogata si sparerà. La detonazione creerà il panico: finzione? realtà?
«La prima attrice. E’ morto! Povero ragazzo! E’ morto! Oh che cosa!
Il primo attore. Ma che morto! Finzione! finzione! Non ci creda!…
Il padre. Ma che finzione! Realtà, realtà signori! realtà! ».
La fissità reale della «vita» d’un personaggio non può essere che finzione per l’uomo che vive il fluire della vita. Il palcoscenico può ospitare solo l’illusorietà, per quanto accreditata e seria, del personaggio che l’attore interpreta in un serio giuoco d’arte. Quello che è finzione per gli attori e per il capocomico, che ultimo fuggirà da quelle rinascenti ombre, è la tragica realtà del personaggio. Giunta la tragedia al suo epilogo eccoli di nuovo sulla scena: vivi perché dentro la tragica fissità del loro dramma.
Tra i fatti ed i personaggi Pirandello inserisce, come elemento esplodente, la dialettica, che opera la deflagrazione totale del suo teatro in cui i personaggi si ritrovano soli, ombre vagolanti, private di ogni punto fermo, eternamente fissate nel loro dramma. Si gioca ormai a carte scoperte. Persino all’autore sfugge la sua creazione. I personaggi vivono nella loro solitudine il dramma di una ricerca. Di fronte a queste maschere nude si opera la deflagrazione di ogni convenzione teatrale tradizionale.
All’inizio dei Sei personaggi in cerca d’autore, il pubblico è di fronte ad un palcoscenico vuoto, chiamato ad assistere alla crescita d’una commedia nel suo farsi tale. Nel corso delle «prove» ecco l’imprevedibile: dal fondo della sala avanzano sei personaggi. Inizia una tragedia ingovernabile, di cui nessun autore è l’ideatore: è il dramma di chi l’autore non ha. Il sovvertimento dei canoni tradizionali è già drastico eppure si radicalizzerà al termine di una rappresentazione in cui tutto è «saltato». Non più logiche conseguenze, non finali a sorpresa ma, comunque, ad ogni buon conto, finali.
Restano le ombre di personaggi senza tempo perché fuori dal tempo. Resta la contemplazione di una vita, quella di tutti, multiforme ed illusoria, il cui significato ci sfugge, tanto da essere costretti a contemplarne il contraddittorio svolgersi. I personaggi cercano un autore, l’uomo cerca un senso alla vita. Pirandello rivoluziona certo il teatro, ponendo in questo modo chi vi assiste di fronte ad una possibilità di verifica, di giudizio.
Non si può non pensare a questo proposito a Brecht, anche se i due drammaturghi, al di là delle tecniche in parte similari, sono parecchio diversi. L’autore tedesco, infatti, propone un messaggio al proprio pubblico per giungere con lui alla realizzazione di una diversa qualità di vita. Il suo teatro, la sua proposta sono essenzialmente politici, perché sono l’effetto di chi crede ad un cambiamento della società ed usa del teatro per smascherare le doppiezze, le ambiguità, le storture e giungere poi a scardinarle.
Pirandello non ha alcuna proposta da fare. La società c’è ma è in secondo piano, prima viene l’uomo con la sua tragedia. Egli pone di fronte allo spettatore un teatro in cui la vita è spoglia, nessuna delle sue illusone proprietà è celata. Le maschere del suo teatro sono nude
II personaggio in crisi è l’emblema del teatro pirandelliano. In un mondo in cui l’uomo si trova schiacciato dalle parti che volente o nolente è costretto a sostenere, coloro che si possono vantare d’averne una ed anzi in essa solamente vivono, non riescono a rappresentarla. Al centro dell’opera pirandelliana è la coscienza critica della crisi dell’uomo, e dentro il mondo teatrale questa crisi è vissuta dal personaggio.
C’è un altro scenario a far da sfondo ad una singolare tragedia, è la stanza di una villa arredata in modo tale da parere la sala del trono di Enrico IV. Qui vive la propria pazzia chi, ritenendosi appunto Enrico IV, agisce ed opera di conseguenza.
Un apparato di costumi ed addetti alimenta la sua immedesimazione nella speranza d’alleviare gli effetti della malattia, nonché di guarirla. Causa di questa pazzia, una caduta da cavallo durante una festa mascherata in cui l’allora giovane sosteneva la parte del re tedesco. Lo incontriamo allorché Donna Matilde Spina, sua figlia Frida, l’amante Tito Belcredi ed un dottore, accompagnati dal conte di Nolli, vengono a fargli visita. Il dottore spera infatti di guarirlo grazie soprattutto all’aiuto di Matilde, la donna inutilmente amata dal protagonista prima della pazzia.
Accade però l’inimmaginabile. Le parti così chiaramente distribuite paiono improvvisamente capovolgersi. Enrico IV svela ai suoi finti scudieri esser svanita da tempo la sua pazzia. «Non capisci? Non vedi come li concio, come me li faccio comparire davanti, buffoni spaventati! E si spaventano solo di questo, oh: che stracci loro addosso la maschera buffa e li scopra travestiti; come se non li avessi costretti io stesso a mascherarsi, per questo mio gusto qua, di fare il pazzo! …Ma dite un po’, si può star quieti a pensare che c’è uno che si affanna a persuadere gli altri che voi siete come vi vede lui, a fissarvi nella stima degli altri secondo il giudizio che ha fatto di voi? — «Pazzo» «pazzo»! — Non dico ora che lo faccio per ischerzo! Prima, prima che battessi la testa cadendo da cavallo…» (Enrico IV).
 Queste parole riassumono il dramma di questa grande creatura pirandelliana. Da tempo rinsavito non è riuscito a rientrare nella vita. Anche in essa era bollato per cui tanto valeva continuare la recita. Chi è allora il pazzo, lui Enrico IV o coloro ch’egli costringe a travestirsi e recitare?
Queste parole riassumono il dramma di questa grande creatura pirandelliana. Da tempo rinsavito non è riuscito a rientrare nella vita. Anche in essa era bollato per cui tanto valeva continuare la recita. Chi è allora il pazzo, lui Enrico IV o coloro ch’egli costringe a travestirsi e recitare?
Non è la risposta che interessa, importa rilevare ancora una volta l’illusorietà d’una vita in cui la parte prende il sopravvento. Pure Enrico IV ne sarà travolto. Immedesimatosi ormai nel proprio ruolo giungerà sino a ferire mortalmente Belcredi, il suo vecchio rivale in amore. La Forma ha avuto il sopravvento sulla vita. E’ pazzo Enrico IV? «Ora sì… — risponde — per -forza…».
Enrico IV è il «settimo» personaggio pirandelliano. Si è costituito un palcoscenico su cui recitare la fissità della propria parte. In essa vive disponendo persino della vita altrui. Rinuncia alla vita che lo voleva schiavo di una illusorietà crudele, sceglie la «realtà» del proprio personaggio. Ma alla fine, quando la vita lo attirerà di nuovo a sé, non saprà dire di no, ed il suo «bisogno di vita» esploderà drammaticamente. Il ritorno alla finzione, la gabbia del personaggio, diverrà la fuga per sottrarsi alla responsabilità d’un omicidio. Per questo Enrico IV è il personaggio più solo e più tragico di Pirandello. In lui il conflitto tra realtà interiore ed esteriore si risolve nella assoluta disgregazione della realtà del proprio io. Resta la lucida pazzia dentro una livida solitudine.
In conclusione, ci sembra di ravvisare in queste due opere, che sono un po’ la vetta di Pirandello, la volontà di cogliere in personaggi assolutamente autonomi lo stadio ultimo e tragico della condizione umana. La vita ci appare come un doloroso incedere entro le contraddizioni dell’illusorietà, generante perciò individui isolati e stanchi, oppure scettici altrettanto dissugati ed aridi. Se i Sei personaggi ci hanno dato un esempio della contraddizione tra la pura forma e la vita, se Enrico IV incarna la solitudine angosciata, Leone Gala de Il giuoco delle parti concretizza lo scetticismo dissugato, per dirla come Pirandello stesso.
«Leone. Ce lo -facciamo tutti, il male, a vicenda; e ciascuno a se stesso, poi… Per -forza! E’ la vita. Bisogna vuotarsene… Tu devi guardarti di te stesso, del sentimento che questo caso suscita subito in te e con cui t’assalta! Immediatamente ghermirlo e vuotarlo, trame il concetto, e allora puoi anche giocarci. Guarda, è come se t’arrivasse all’improvviso, non sai da dove, un uovo fresco… Se sei pronto, lo prendi, lo fori, e te lo bevi. Che ti resta in mano?
Guido. Il guscio vuoto.
Leone. E questo è il concetto! Lo infilzi nel pernio del tuo spillo e ti diverti a farlo girare, o, lieve ormai, te lo giuochi come una palla di celluloide, da una mano all’altra: là, là e là… poi paf! lo schiacci tra le mani e lo butti via.» (II gioco delle parti).
Per ovviare all’arida nullità dei gusci vuoti, all’angoscia del deserto interiore Pirandello giungerà alla stagione dei miti o delle utopie. Il mito sociale, presente ne La nuova colonia (1928), quello religioso in Lazzaro (1929), quello estetico nell’incompiuta opera I giganti della montagna. Sono opere notevoli anche se lontane dalla solida compattezza del grande teatro pirandelliano.
Il Pirandello poeta è là sul palcoscenico con i suoi grandi personaggi, da lui creati, chiamati alla vita, ed ora, come lui, vaganti alla ricerca d’un bandolo per questa vita.
La sua eredità
«Ma guai a chi non sa portare la sua maschera»
La vita, la morte, l’illusione
 «Ora bisogna sapere che a me non è mai bastato… narrare una particolare vicenda, gaia o triste, per il solo gusto di narrarla. Ci sono certi scrittori (e non pochi) che hanno questo gusto e, paghi, non cercano altro. Sono scrittori di natura più propriamente storica. Ma ve ne sono altri che, oltre questo gusto, sentono un più profondo bisogno spirituale, per cui non ammettono figure, vicende, paesaggi che non s’imbevano, per così dire, d’un particolare senso della vita, e non acquistino con esso un valore universale. Sono scrittori di natura più propriamente filosofica. Io ho la disgrazia d’appartenere a questi ultimi » (Sei personaggi in cerca d’autore, prefazione).
«Ora bisogna sapere che a me non è mai bastato… narrare una particolare vicenda, gaia o triste, per il solo gusto di narrarla. Ci sono certi scrittori (e non pochi) che hanno questo gusto e, paghi, non cercano altro. Sono scrittori di natura più propriamente storica. Ma ve ne sono altri che, oltre questo gusto, sentono un più profondo bisogno spirituale, per cui non ammettono figure, vicende, paesaggi che non s’imbevano, per così dire, d’un particolare senso della vita, e non acquistino con esso un valore universale. Sono scrittori di natura più propriamente filosofica. Io ho la disgrazia d’appartenere a questi ultimi » (Sei personaggi in cerca d’autore, prefazione).
La «disgrazia» di Pirandello, il suo «profondo bisogno spirituale», fa sì che tutta la sua opera sia improntata alla ricerca della verità. Qui troviamo perciò la sua profonda religiosità, il senso spiccato dell’umano, tanto più che questa investigazione, questo suo continuo, quasi ossessivo, rovellio interiore ha come termine una verità la cui natura è soprattutto morale ed è quindi, più che una verità, un valore. L’oggetto della ricerca pirandelliana è di conseguenza il senso della vita, il valore che solo la può giustificare. Di qui la disperazione per il vuoto, per quanto di oscuro la vita ci riserva.
Non c’è personaggio, vuoi di una novella, vuoi di un’opera teatrale che non tenda al «significato»: ed infatti è l’impatto col mistero della vita e della morte che popola il mondo pirandelliano delle ombre, dei fantasmi dell’illusione sino a giungere al punto in cui un personaggio di una commedia può proclamarsi più vivo d’un uomo reale: «…un personaggio ha veramente una vita sua… per cui è sempre «qualcuno». Mentre un uomo… può non essere «nessuno» (Sei personaggi). Che cos’è allora la vita? Che cos’è la morte? Che cosa ci può permettere di non essere «nessuno»? Questi interrogativi se li pone il protagonista della novella La carriola e, nell’atto stesso di porseli, comprende la finzione, l’artificiosa costruzione che sta dietro la rispettabilità del suo essere avvocato e professore di diritto.
«Ma come? Io questo? Io cosi? Ma quando mai? — E ho nausea, orrore, odio di questo che non sono io, che non sono mai stato io » (Novelle per un anno – La carriola). La scoperta di non essere per gli altri quel che, sino ad un certo punto, si è creduto d’essere, è anche l’inizio del dramma liberatorio e tragico di Vitangelo Moscarda; è l’inizio del cammino che lo porterà a riconoscersi come uno, nessuno, centomila. Questa è la disintegrazione individuale operata da Pirandello, lo scoprirsi tanti e nessuno, la coerenza individuale che si smarrisce, parcellizzando ciascuno in migliaia di «sé».
Moscarda si propone di scoprire se stesso, di rompere, distruggere quel suo «io» che gli altri avevano costruito, ma finirà per passare per pazzo e lo scatto sarà la solitudine, l’esser soli con se stessi. Ma se Moscarda lotta con la vita che gli gioca il brutto scherzo di rivelargli tanti se stessi quanti sono quelli che lo vedono e lo giudicano, Mattia Pascal lotta con la morte o meglio con le morti che, sempre vivo, riesce a procurarsi. Pur vedendole come una liberazione non riesce comunque a staccarsi dal peso della vita che lo precede, dall’ombra di sé che sempre pare inseguirlo. Ed a chi gli chiederà infine di rivelargli una volta per tutte la propria identità, egli risponderà d’essere il «fu Mattia Pascal»: accettazione de’illusorietà del nostro essere o pazzia?
Ma che cos’è poi la pazzia nell’opera pirandelliana: realtà o fantasma? Enrico IV trasforma la pazzia reale in un paravento contro la vita per cui, col procedere del dramma, i pazzi paiono essere coloro che, apparentemente normali, assecondano un finto folle che fa credere d’essere un re. Diego Spina nel Lazzaro « …sarà un santo — dice Deodata, la governante — ma se qualche volta me ne dimentico e bado a quello che dice, a quello che fa, Dio mi perdoni, con quegli occhi mi pare un matto veramente ».
 A proposito sembra calare la sentenza di Flaminio Salvo ne I vecchi e i giovani: «Conosci Don Cosmo Laurentano? Se sapessi quanta ragione ha quel matto!». Come decretare d’altronde il discrimine entro il quale definire il pazzo ed il normale, il vero ed il falso se la verità è essa pure illusione? Se essa è molteplice come molteplici sono gli individui che la fabbricano? Alla fine, comunque, per tutti rimane il deserto interiore, la drammatica solitudine nei confronti di una vita che è mistero inconoscibile.
A proposito sembra calare la sentenza di Flaminio Salvo ne I vecchi e i giovani: «Conosci Don Cosmo Laurentano? Se sapessi quanta ragione ha quel matto!». Come decretare d’altronde il discrimine entro il quale definire il pazzo ed il normale, il vero ed il falso se la verità è essa pure illusione? Se essa è molteplice come molteplici sono gli individui che la fabbricano? Alla fine, comunque, per tutti rimane il deserto interiore, la drammatica solitudine nei confronti di una vita che è mistero inconoscibile.
«Ogni creazione, ogni visione della vita, ogni rivelazione dello spirito, porta con sé necessariamente problemi, questioni, contraddizioni logiche tanto più decise ed evidenti quanto più è organica e comprensiva: e ciò semplicemente perché allo spirito è congenito il mistero, e guardare con occhi nuovi, esprimere schiettamente, riorganizzare la vita è riprospettare la vita nel mistero» (Teatro nuovo e teatro vecchio – in Saggi). Un mistero entro il quale Pirandello non cessa di condurre la ricerca, il suo ardito scandaglio per imporre il proprio anelito alla libertà, la propria nostalgia e la propria speranza nei confronti di una vita autentica e vera e che invece pare confondersi con i fantasmi e con i sogni che si sostituiscono alla realtà.
La ricerca di Dio
In questo cammino di speranza Pirandello ci offre infine la cosiddetta stagione dei miti, là dove il mito sociale, religioso ed estetico tendono a sublimarsi in altrettante opere teatrali. Tra esse troviamo Lazzaro, dramma che ci aiuta a comprendere il problema religioso in Pirandello. In Lazzaro incontriamo un padre bigotto e cieco sino al masochismo, i due figli costretti l’uno in seminario, l’altra in un convento di suore e la madre che ribellandosi all’ascetismo ipocondriaco del marito rifugge da una vita falsa e ricostruisce in ampagna una propria famiglia, nella serenità e nella gioia.
La chiave del dramma scatta allorché Diego Spina (il padre), dichiarato morto, viene riportato in vita da una puntura miracolosa del dottor Gionni. Venuta a saper casualmente del «miracolo» occorsogli, Diego perde ogni certezza: se per qualche tempo è risultato esser morto, come mai ora, vivo, non ricorda nulla dell’aldilà? Ciò che ci aspetta lassù, oltre la vita, allora non esiste? E’ il figlio Lucio che, già abbandonata la veste, recupera in questo frangente la fede: è la fede in un Dio che è carità; un Dio che va vissuto in questa vita, che è in noi ed in tutto quello che facciamo; un Dio per il quale bisogna credere, non sapere.
Lucio si offre per ridare al padre ed a tutti gli altri l’illusione di una possibile vita oltre la vita, nella certezza che non si può rinunciare a questa per quella. Questo Dio che invita a vivere senza attendere una vita a venire (l’illusione della quale ha di per sé già un senso) non è certo il Dio cristiano; in Pirandello Dio è il tutto di questo mondo di cui mai si potrà penetrare il mistero. La Chiesa è vista quasi esclusivamente come istituzione umana e non come casa del Padre.
 L’incapacità dello scrittore di uscire da sé, di affidarsi a Chi solo gli può far «vivere» questo mistero, genera questa barriera. Il credere è vissuto in Pirandello come un inconscio desiderio non come un fatto reale. Comprendiamo allora come mai il «vecchio Dio» della novella omonima si lamenti della condizione in cui è ridotto: «Sto qui a guardia delle panche» e rida di chi lo cerca tra le stelle senza averlo nel cuore. «Bisogna ch’io mi risolva a lasciare la città e mi restringa a fare il Padreterno nelle campagne» (Novelle per un anno – II vecchio Dio).
L’incapacità dello scrittore di uscire da sé, di affidarsi a Chi solo gli può far «vivere» questo mistero, genera questa barriera. Il credere è vissuto in Pirandello come un inconscio desiderio non come un fatto reale. Comprendiamo allora come mai il «vecchio Dio» della novella omonima si lamenti della condizione in cui è ridotto: «Sto qui a guardia delle panche» e rida di chi lo cerca tra le stelle senza averlo nel cuore. «Bisogna ch’io mi risolva a lasciare la città e mi restringa a fare il Padreterno nelle campagne» (Novelle per un anno – II vecchio Dio).
E’ illuminante, ancora, a questo proposito, quanto leggiamo in All’uscita: «Come casa di Dio è senza dubbio infinitamente più grande e più ricco il mondo, che una chiesa; incomparabilmente più nobile e prezioso d’ogni altare, lo spirito dell’uomo in adorazione del mistero divino. Ma questa è la sorte di tutti i sentimenti che si vogliono costruire una casa: si rimpiccioliscono, per forza, e diventano anche un poco puerili, per la loro vanità. E’ la sorte stessa di quell’infinito che è in noi, quando per alcun tempo si finisce in quest’apparenza che si chiama uomo, labile forma su questo volubile granello di terra perduto nei cieli». Pirandello quindi sembra identificare Dio nel Tutto universalmente inteso, senza specificarlo nel Dio cattolico o comunque cristiano; la vita eterna è anch’essa cerne la vita terrena un mistero nella cui illusorietà è possibile credere anche se poi è con la nostra vita che dobbiamo vedercela.
A Gesù che gli chiede di rivivere in lui, il protagonista della novella Sogno di Natale risponde che il proprio tormento è qui sulla terra. «Qui, senza esequie e senza posa, debbo da mane a sera rompermi la testa ».
Quale allora l’eredità pirandelliana? Solo ombre, solo fantasmi di una vita che è divenuta mistero per un io illusorio e frantumato, incapace di affidarsi ad un Dio che non sia tutt’uno con questo mistero? Assolutamente no.
Innanzitutto Pirandello è calato visceralmente dentro la sua opera e mai per puro «divertissement». Egli ci testimonia una lezione ricca di un profondo impegno morale e civile, tesa ad opporsi ad un mondo e ad una società la cui «materialità» andava sempre più aumentando. Basterà ricordare la condanna all’imbestialimento umano insita nei Giganti della montagna. L’uomo nella corsa al grasso benessere della materia diviene incapace dì accogliere, di sentire valori spirituali quali quelli dell’arte. Invano, nell’ultimo lavoro pirandelliano, la compagnia teatrale della contessa, con l’aiuto degli scalognati (che tutto hanno perché nulla possiedono), tenta di rappresentare al popolo dei giganti, (tronfi del loro galoppante benessere) il messaggio poetico racchiuso dentro La favola del figlio cambiato.
L’uomo è divenuto cieco e sordo ai valori dell’arte, dello spirito. Pirandello pagherà la lotta contro questa involuzione della società con la solitudine che fu di tanti suoi personaggi ed anche sua. E’ comunque questo il suo ultimo messaggio, ulteriore dimostrazione di come, pur nelle perplessità e nelle angosce egli fosse attaccato alla cristallina purezza di una vita autentica. Da qui e dalla ricerca mai smessa del motivo per cui può valer la pena vivere, sgorga la sua profonda religiosità.
«In un mondo che invita ad una vita facile, Pirandello c’invita ad una vita difficile; perché solo così potremo vincere sul serio il mostro dell’angoscia e della contraddizione, per vivere nella difficoltà della libertà: in un mondo a statura d’uomo, a misura d’uomo, secondo l’incrollabile dignità dell’uomo» (5).
|
NOTE
(1) Corrado Alvaro, Prefazione a Novelle per un anno, Mondadori, pp. 7-9.
(2) Giovanni Macchia, Luigi Pirandello, in Storia della letteratura italiana, Garzanti, pp. 463-464.
(3) Leone De Castris, Storia di Pirandello, Laterza, pag. 133.
(4) V. Boarini, P. Bonfiglioli, Avanguardia e Restaurazione, Zanichelli, pag. 201.
(5) Ruggero Jacobbi, Umanità di Pirandello, «II Veltro», Giugno 1963.
OPERE DI PIRANDELLO
Novelle per un anno, Mondadori, Milano, voll. 2
Tutti i romanzi, Mondadori, Milano
Maschere nude, Mondadori, Milano, voll. 2
Saggi, poesie, scritti vari, Mondadori, Milano
CENNI BIBLIOGRAFICI
LEONE DE CASTRIS, II decadentismo italiano. Svevo, Pirandello, D’Annunzio, De Donato, Bari
LEONE DE CASTRIS, Storia di Pirandello, Laterza, Bari
LUCIO LUGNANI, Pirandello, Letteratura e teatro, Firenze, La Nuova Italia
ETTORE MAZZALI, Pirandello, Ed. Il Castoro, Firenze, La Nuova Italia
GIUSEPPE GIACALONE, Luigi Pirandello, La Scuola, Brescia
GASPARE GIUDICI, Luigi Pirandello, UTET, Torino
GIOVANNI MACCHIA, «Saggio su Pirandello» in La caduta della luna, Milano, Mondatori
GIOVANNI MACCHIA, Luigi Pirandello, in Storia della letteratura italiana, vol. IX, Garzanti, Milano, pag. 441.
FERDINANDO VIRDIA Invito alla lettura di Pirandello, Milano, Mursia
RENATO BARILLI, La linea Svevo-Pirandello, Milano, Mursia
FRANCA ANGELINI FRAJESE, II teatro del novecento da Pirandello a Dario Fo, Bari, Laterza
// romanzo di Pirandello, a c. di Enzo Lunetta, Palermo, Palumbo







