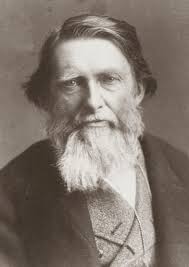Strumenti culturali di Litterae Communionis n.4
I GRANDI DELLA CULTURA MODERNA RIVISITATI
«La configurazione di una cosa non è solamente l’immagine della sua natura: è il segreto del suo destino e il tracciato della sua storia»
Testo di Marta Morazzoni
La sua vita
«L’arte è la più austera scuola di vita»
La figura di Marcel Proust, singolarmente intrecciata alla finzione dei personaggi del suo romanzo, ha sempre suscitato una certa curiosità un po’ superficiale, legata alla iconografia della sua opera, alle facce dei suoi modelli, uomini facilmente riconoscibili dietro i nomi inventati della Recherche, tanto più che spesso erano esponenti di rilievo del bel mondo di una Francia belle-epoque.
La ricerca della fotografia della duchessa di Guermantes, alias contessa di Greffuhle, o dell’enigmatico barone di Charlus, duca di Montesquiou, o di quel meraviglioso personaggio di Swann-Haas è, in ultima analisi, solo una forma di pettegolezzo un po’ più raffinata della media. Chissà se Proust immaginava di scatenare nei posteri, oltre che nei suoi contemporanei, questa curiosità d’alta classe? Probabilmente sì, ma con sicurezza non amava l’idea che il suo nome di scrittore rimanesse legato agli eventi della sua vita, se non per il filo esile, eppure tenacissimo della sua opera.
Per questo, nel tracciarne la biografia, preferisco mantenermi nei limiti di un’arida, stretta cronaca, affidando invece al materiale immenso e trasparente dell’arte il compito di parlare più esplicitamente di Marcel Proust.
 Nasce il 10 luglio 1871 ad Auteil, alla periferia di Parigi, nella casa del prozio materno Louis Weil; la madre, Jeanse Weil, è figlia di un, ricco agente di cambio israelita, mentre il padre, il dottor Adrien Proust, è già un affermato medico, ispettore generale dei servizi sanitari francesi e docente di igiene alla Facoltà di Medicina di Parigi.
Nasce il 10 luglio 1871 ad Auteil, alla periferia di Parigi, nella casa del prozio materno Louis Weil; la madre, Jeanse Weil, è figlia di un, ricco agente di cambio israelita, mentre il padre, il dottor Adrien Proust, è già un affermato medico, ispettore generale dei servizi sanitari francesi e docente di igiene alla Facoltà di Medicina di Parigi.
L’infanzia di Marcel Proust si svolge in rue des Malesherbes, a Parigi, con l’interruzione delle vacanze estive a Illiers, presso i parenti del padre. Il clima familiare sarebbe stato particolarmente determinante nella maturazione del giovane, e tanto più lo sarebbe stata l’influenza materna, poiché la signora Proust aveva indovinato nel più grande dei due figli (Robert era di due anni più giovane di Marcel) una natura sensibilissima e particolare.
A questo si aggiunga la salute precaria del bambino, che a nove anni accusava il primo grave attacco d’asma, malattia da cui non si liberò mai, che determinò per certi versi lo strano corso della sua esistenza e, secondo alcune versioni di stampo psicanalitico, venne usata dal giovane come arma inconscia di ricatto e come leva sull’affetto materno.
Frequentò il liceo Condocet a Parigi e, dato il ceto abbastanza elevato della famiglia e la fama di cui il dottor Proust già godeva nel bel mondo parigino, annovera tra le sue amicizie giovanili alcuni dei nomi più in vista del tempo, quali Antoniette e Lucia Paure, figlie del futuro presidente della Repubblica. È al liceo che Proust comincia a manifestare la sua vocazione letteraria ed insieme quel particolare piacere e curiosità di entrare nei salotti migliori di Parigi, rivelando una innata propensione alla vita di società ed una straordinaria capacità di affascinare e attrarre i protagonisti di questa élite un po’ fatua e un po’ intellettuale.
In questo ambiente incontra Madame Strauss, moglie in prime nozze del compositore George Bizet, e Charles Haas, strana figura di esteta e raffinato cultore dell’arte, sulla cui personalità Proust forgerà poi il personaggio di Swann.
I primi frutti dell’attività letteraria di Proust arrivano nel 1892, quando si inserisce come collaboratore nella rivista «Le Banquest», fondata da un gruppo di amici, tra cui Jacques Bizet, Daniel Halévy, Robert Dreyfus e Leon Blum.
È in piena ascesa nel mondo dell’aristocratico Faubourg Saint-Germain, di cui ormai è un assiduo frequentatore, legato ai nomi più prestigiosi, tra cui appare anche lo stravagante ed estroso conte Robert de Montesquiou-Fesensac. Sono gli anni in cui comincia ad allargarsi a macchia d’olio l’interesse per il caso Dreyfus, il capitano arrestato con l’accusa di spionaggio e complicità con la Germania. Il caso si dovrebbe chiudere ufficialmente il 22 dicembre 1894 con la condanna del capitano e la deportazione all’isola del Diavolo. In realtà, da qui prende il via il vero e proprio caso Dreyfus, cui Proust partecipò con intensità e straordinario attivismo, tra le fila dei dreyfusisti.
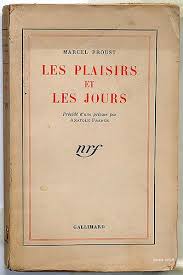 Nel 1896 esce il primo libro dello scrittore, una raccolta di novelle: Les plaisirs et les jours, in una edizione raffinatissima e costosa, con prefazione di Anatole France e illustrazioni di Madelaine Lemaire, mediocre pittrice, ma regina del mondo intellettuale parigino. È anche il momento in cui Proust si dedica ad una sporadica, ma attenta attività di critico letterario, oltre che all’avvio di una enorme, confusa bozza del grande romanzo «Jean Santeuil» che, rimasto incompiuto e disorganico, sarà poi in pratica la base su cui, anni dopo, lo scrittore imposterà la «Recherche».
Nel 1896 esce il primo libro dello scrittore, una raccolta di novelle: Les plaisirs et les jours, in una edizione raffinatissima e costosa, con prefazione di Anatole France e illustrazioni di Madelaine Lemaire, mediocre pittrice, ma regina del mondo intellettuale parigino. È anche il momento in cui Proust si dedica ad una sporadica, ma attenta attività di critico letterario, oltre che all’avvio di una enorme, confusa bozza del grande romanzo «Jean Santeuil» che, rimasto incompiuto e disorganico, sarà poi in pratica la base su cui, anni dopo, lo scrittore imposterà la «Recherche».
L’attività di critico letterario e soprattutto di attento estimatore dell’arte lo porta ad incontrarsi con le teorie estetiche dell’inglese John Ruskin, cui dedicherà tanta parte del suo tempo, impegnandosi nella traduzione francese di una sua opera «The Bible of Amiens». Un dato curioso: Proust non conosceva l’inglese, quindi il suo lavoro di traduzione (per altro perfetto e di una rara cura) avveniva per il tramite della madre e della scultrice Mary Nordlinger, cugina del suo grande amico, il musicista Reynaldo Hahn.
II 1900 è l’anno dei viaggi in Italia, soprattutto a Venezia, dove compie una sorta di pellegrinaggio ruskiniano, una verifica dal vivo delle teorie estetiche del critico inglese, oltre che incontrarsi per la prima volta dal vero con il mondo della pittura italiana, soprattutto giottesca. Questi viaggi alla ricerca dei grandi momenti dell’arte europea sono un tratto fondamentale dello stile di vita di Proust e si rinnoveranno, fin tanto che gli sarà possibile muoversi e affrontare le fatiche di lunghi trasferimenti.
Nel 1905 muore la signora Proust (due anni prima si era spento il padre Adrien Proust) e sarà questo uno dei momenti più dolorosi nella vita dello scrittore, che di lì a qualche tempo lascia l’appartamento della famiglia e si trasferisce in Boulevard Haussmann, dove farà istallare la famosa camera interamente rivestita di sughero e isolata da ogni rumore esterno.
È all’inizio del 1907, circa, che avvia la stesura, o forse semplicemente il progetto più organico del suo romanzo: sarà Reynaldo Hahn il primo a conoscere e leggere la trama di «Swann», di cui vengono poi pubblicati degli stralci su «Le figaro». La pubblicazione dell’intero libro avrà varie traversie e finirà per essere affidata a un editore minore, Bernard Grasset, che pubblica l’opera a spese dell’autore, dopo che i nomi più prestigiosi dell’editoria ne hanno rifiutato l’acquisto.
La vita intensamente sociale dello scrittore si va man mano riducendo ad un numero ristretto di amici, da cui per altro sembra in qualche caso difendersi, mentre i suoi ritmi di vita sono interamente sconvolti: dorme per la più parte della giornata e lavora la notte; accanto gli rimane solo la domestica Celeste Albaret con il marito Odillon. Nel 1914 muore in un incidente aereo ad Antibes il segretario-autista Alfred Agostinelli: è un altro momento tragico per Proust, profondamente legato al giovane, che, appassionato pilota d’aereo, volava con il patetico pseudonimo di Marcel Swann.
 Lo scoppio della prima guerra mondiale, nell’agosto del 1914, coinvolge e sconvolge il mondo e le amicizie di Proust; alcune delle persone a lui care, tra cui soprattutto Bertrand de Fénelon, muoiono al fronte; il fratello Robert è in prima linea come medico e rischia la vita in più di un frangente. A Parigi, Proust continua a lavorare al suo romanzo, apparentemente estraneo e indifferente alla tragedia che lo circonda, su cui invece lascerà delle pagine stupende e senza retorica sciovinista, nel «Temps retrouvé».
Lo scoppio della prima guerra mondiale, nell’agosto del 1914, coinvolge e sconvolge il mondo e le amicizie di Proust; alcune delle persone a lui care, tra cui soprattutto Bertrand de Fénelon, muoiono al fronte; il fratello Robert è in prima linea come medico e rischia la vita in più di un frangente. A Parigi, Proust continua a lavorare al suo romanzo, apparentemente estraneo e indifferente alla tragedia che lo circonda, su cui invece lascerà delle pagine stupende e senza retorica sciovinista, nel «Temps retrouvé».
Da qui in poi, la vita sempre più segregata e solitària di Proust sembra scandita solo dal ritmo della sua opera, che gli cresce tra le mani sempre più imponente. I vari volumi escono con regolarità, accolti con attenzione dalla critica, mentre la N.R.F., deposta ogni diffidenza, ne assume la pubblicazione. Al riconoscimento e alla fama dello scrittore ha contribuito soprattutto l’assegnazione del premio Goncourt, nel 1918, al libro «A l’ombre des jeunes filles en fleur».
Sta terminando la revisione definitiva della «Prigioniera» quando, nell’ottobre del ’22, si ammala di bronchite. Rifiutando qualsiasi assistenza medica, a dispetto delle insistenze del fratello Robert, cerca di resistere agli attacchi della malattia, particolarmente violenti e acuiti dall’asma, e continua la stesura della «Fuggitiva», che riuscirà a portare a termine. Muore il 18 novembre 1922
|
La sua opera
« … vedere l’universo con gli occhi di un altro »
«Io dico che la legge crudele dell’arte è che gli esseri umani muoiano e che noi stessi moriamo, dopo aver esaurito tutte le sofferenze, perché cresca l’erba non dell’oblio, ma della vita eterna, l’erba folta delle opere feconde, sulla quale le generazioni future verranno lietamente a fare le loro “colazioni sull’erba”, incuranti di chi dorme là sotto».
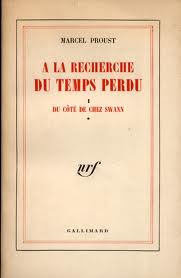 Sono le parole di una delle ultime pagine del Temps retrouvé, il libro cardine della Recherche du temps perdu, il grosso pilastro su cui poggia l’arcata della cattedrale proustiana, balzata fin qui da quelle prime parole, dalla memoria bambina de La strada di Swann. Non aveva altra eternità Proust, non ha avuto altra fede, che questa convinzione nella saldezza e nella salvezza dell’arte. Un’arte costruita dentro l’uomo, generata dalla sua vita, ma spinta da una sorta di prepotenza ad essa insita, che supera il limite e la precarietà dell’individuo e si impone nell’unica immortalità in cui Proust abbia creduto. «Incuranti di chi dorme là sotto» non è la voce del rammarico dell’artista dimenticato, ma il segno di un’opera, che non ha conosciuto, o l’ha conosciuto così bene da vincerlo, il limite del tempo.
Sono le parole di una delle ultime pagine del Temps retrouvé, il libro cardine della Recherche du temps perdu, il grosso pilastro su cui poggia l’arcata della cattedrale proustiana, balzata fin qui da quelle prime parole, dalla memoria bambina de La strada di Swann. Non aveva altra eternità Proust, non ha avuto altra fede, che questa convinzione nella saldezza e nella salvezza dell’arte. Un’arte costruita dentro l’uomo, generata dalla sua vita, ma spinta da una sorta di prepotenza ad essa insita, che supera il limite e la precarietà dell’individuo e si impone nell’unica immortalità in cui Proust abbia creduto. «Incuranti di chi dorme là sotto» non è la voce del rammarico dell’artista dimenticato, ma il segno di un’opera, che non ha conosciuto, o l’ha conosciuto così bene da vincerlo, il limite del tempo.
Nemico di ogni biografismo, ostile alla ricerca pettegola o benevola sulla vita del creatore, di cui deve far fede solo la sua creatura, Proust sembra aver ammonito, in uno dei suoi scritti critici in particolare, il Cantre Sainte-Beuve, a guardarsi da qualsiasi ricerca biografica su di lui, al di fuori o al di là della sua opera. E, leggendolo profondamente e accuratamente, penetrando la sostanza sottile come una madreperla della «Recherche», andando a scavare alla base di questa gigantesca cattedrale di parole, emerge e si delinea, prima appena accennata, poi sempre più ferma e nitida, la figura di Marcel Proust, nella Parigi dei primi del ‘900, elegante, raffinatissimo, un po’ dandy e permaloso.
E’ il quadro sommario che di lui si era fatto Andre Gide, il quale, dopo una lettura (o una non lettura, la cosa è ancora controversa) superficiale del primo libro della Recherche proposto dall’autore per la pubblicazione sulla Nouvelle Revue Francaise, si era tirato indietro, leggermente disgustato dal tono troppo estetizzante, dalla tematica frivola e mondana di questo affresco di vita parigina.
Non aver sentito come dietro la parvenza di una estetica raffinata e preziosa si nascondesse soprattutto la sostanza di una analisi tra le più rigorose sul mondo del ‘900 e, più ancora, il breviario di vita di un uomo, che aveva fatto dell’arte la ragione della sua esistenza, una sorta di inflessibile legge morale, senza pregiudizi e senza moralismi; non aver intuito come accanto all’eleganza formale ci fosse uno dei momenti più poeticamente e umanamente illuminati della letteratura novecentesca è stato uno dei casi più imbarazzanti di miopia della cultura europea. E lo stesso Gide, in seguito, ne avrebbe dovuto fare pubblica ammenda.
Era necessario, comunque, che passasse qualche tempo perché si capisse il nucleo dell’estetica proustiana, che diventa tutt’uno con la sua etica ed è contenuto in un unico assunto, in una rigorosa assenza di mezzi termini o deviazioni: Proust ha vissuto per dare, con un lavoro lento, artigianale nella sua impostazione, quest’unica, grande opera e (senza cadere per questo in romanticismi di sorta) è morto il giorno in cui, terminate di vedere le ultime bozze de La prigioniera, ha sentito il suo lavoro compiuto e dette le cose che gli premeva dire.
Suona strano a noi, esagerato e comunque insolito, abituati come siamo dal nostro contesto culturale a considerare il libro alla stregua di un qualsiasi altro prodotto di più o meno immediato consumo, ora che la dimensione della comunicazione (termine usato e abusato) passa, se passa, attraverso una serie di stratificazioni, per vie apparentemente più dirette, in realtà frantumate da ideologie e schemi aprioristici.
Proust, dicevo, ha vissuto per compiere questa unica opera, specchio di un cammino compiuto da un uomo per conoscere fino al conoscibile se stesso, imparando a guardarsi nel mondo dentro cui ha vissuto, imparando a sondare chi gli sta intorno con assoluta precisione, nella più impietosa delle maniere, ma anche nell’unica possibile.
Lo scrittore, che da giovane aveva conosciuto il gusto e l’abbandono all’esaltazione dell’arte e della bellezza, imparerà negli anni, con la fatica di una autodisciplina silenziosa e lenta, a cercare la lucidità. Un passaggio obbligato verso la maturazione, che gli insegnerà a temperare le passioni e gli entusiasmi senza inaridirsi, a ridimensionarli senza negarli, come avverrà del suo incontro con l’estetica di John Ruskin, incondizionatamente venerato prima, ricondotto poi, in una più acuta analisi, ad una dimensione meno esaltante, ma non per questo sminuendo la grande fisionomia del critico inglese.
E poiché in Proust qualsiasi esperienza letteraria ed estetica diventa un’esperienza di vita, da queste riletture nascerà la capacità di guardare con un tono distaccato, si direbbe disilluso, la realtà degli uomini. Il suo mondo, da quello gretto e provinciale del villaggio delle sue vacanze infantili, la Combray della «Recherche», a quello elegantissimo, snob e aristocratico della Parigi dei Guermantes, passa al vaglio di uno sguardo indagatore e sottile, uno sguardo che non lascia sfuggire nemmeno la più piccola pecca, registrata puntualmente da quell’«io» del Narratore, che è e non è Proust, ma certo è il cardine dell’analisi.
Il fascino ed il valore dell’opera sta qui, proprio nella spietatezza della lucidità dello scrittore, solo che si sappia individuare la magnanimità, che sta all’origine di tale inflessibile processo, magnanimità che significa saper eludere la tentazione ipocrita di un falso pietismo o di una inutile indulgenza. Il vaglio critico del Narratore lascia invece spazio all’infinita complessità dell’uomo e del personaggio. Cade la barriera manichea del bene e del male e rimane la fisionomia dell’individuo dalle sfumature infinite e mutevoli.
E’ crudele l’analisi proustiana quando denuda i suoi personaggi, quando sfronda le loro e le sue stesse illusioni; fuori dalla logica delle classi e dei ceti, lo scrittore ha conosciuto e studiato il singolo e, dal suo osservatorio, meno distaccato dal mondo di quanto non si creda, ha guardato, vivisezionato la mente e il cuore dei suoi protagonisti, dalla domestica Francoise, al duca e alla duchessa di Guermantes, ai suoi stessi genitori, senza riserva e senza scrupoli.
La linea del procedere narrativo, le divagazioni, gli sviluppi, in una parola quell’insospettata familiarità dentro la monumentalità della storia lascia in chi lo legge la sensazione e, in certo modo, la presunzione di un incontro diretto e reale, dove il coinvolgimento dello scrittore nel tema dell’opera diventa sempre più evidente, tanto che non ci sono ostacoli alla cui rimozione lui stesso non abbia indicato, prima o poi, la via. L’itinerario di questo viaggio, che ha il pregio unico di essere il cammino dentro la vita di un uomo e dentro il suo tempo, porta per un processo dapprima impercettibile e discreto, poi tenace ed evidente, ad una analisi di sé, della propria posizione di lettore, avvicinato con la cautela della squisita misura e raffinatezza, che è nelle parole e nei ritmi dello scrittore.
Come due capelli finissimi e intrecciati, la finzione del romanzo e la realtà della persona che sta dietro il Narratore si allacciano in due figure inindividuate, dando forma e figura ad un Tempo, che ha contemporaneamente la coscienza della propria corruttibilità e della sua strana immortalità. E’ un esercizio di pazienza, ma anche di affetto cercare di districare questi due capelli per risalire, dal cuore del poema proustiano, alla radice, andando a cercare l’origine dell’opera e facendo emergere le tracce nascoste di quei piccoli (piccoli in paragone alla magnificenza del capolavoro compiuto) passi, che hanno dato modo al giovane amante dell’arte, al raffinato esteta di una decadenza morente di diventare poeta nel senso più compiuto della parola.
L’unicità della creazione proustiana, l’aver lavorato per anni e anni nella silenziosa gestazione di un solo grande romanzo permette di compiere con lui l’esperienza inusitata del colloquio con una presenza reale; che il colloquio avvenga, per una convenzione tacita tra scrittore e lettore, attraverso le pagine di una storia più o meno simulata non toglie niente alla realtà dei due interlocutori. L’aver dato tempo, il tempo lunghissimo di sette libri fitti di nomi, di situazioni, di osservazioni, ha la configurazione di un dialogo, cui Proust per primo si è preparato, affinando in anni di tentativi, di esami e di ripensamenti la sua capacità di sondarsi e raccontare di una società e un mondo, che gli crescono intorno, mentre lui, sdoppiato nel ruolo di attore e spettatore, ne vive e ne osserva i mutamenti.
Per anni lo scrittore ha compiuto tentativi su tentativi, che somigliavano allo sforzo di un afasico, che deve parlare; questa ricerca senza drammi di una parola da dire ed il bisogno di dirla nella maggior perfezione possibile concentrano in un unico pensiero la vita dello scrittore. Affascinato dal suo mondo e dalla realtà nella sua infinita mutazione, vicino alla nobiltà morente e sfatta di una Francia sfiorita, sostenuto dal clima familiare di una ricca borghesia colta e positivista, ha sentito senza alcuna deformazione retorica, ma con la sottile tenacia della determinazione, di appartenere ad una sorta di nascosta aristocrazia mentale, e di avere perciò il diritto di guardare e partecipare con occhio critico alla realtà storica, senza esserne per questo né travolto, né sdegnosamente distaccato.
Seguirà il caso Dreyfus e lo farà con l’entusiasmo dell’età, ma la sua posizione di scrittore, evolvendosi nel tempo, rileggerà lo stesso episodio in due diverse connotazioni, nell’impetuosa passione del Jean Santeuil prima, nella Recherche poi, dove il polo dell’attenzione, leggermente deviato, permette di cogliere sfumature ed ironie, che molto più nitidamente dicono la posizione dell’autore, scevro da intransigenze e preconcetti ideologici.
Il cammino della maturazione dell’uomo e dello scrittore vanno di pari passo e le opere precedenti alla Recherche ne sono testimoni dirette. A partire dal primo libro pubblicato a circa venticinque anni, con l’aiuto benevolo e forse non convintissimo di Anatole France, Les Plaisirs et les jours, si cominciano ad individuare tracce ed elementi precisi, che indicano nel giovane il primo embrione dello scrittore, che si formerà nella convinzione di essere nato ad un compito preciso, un compito rigoroso e quasi scientifico.
Come suo padre era medico, uno dei medici più illustri e stimati di Parigi, così lui doveva essere scrittore. Non è strana sulla bocca dell’ateo Proust la parola vocazione, una vocazione profonda, tenace, sicura di sé oltre ogni possibile evidenza, anche quando si avvilisce nei momenti dell’insicurezza, nei momenti della stanchezza e della desolante impotenza poetica.
 «Come il seme, anch’io ero destinato a morire non appena si fosse sviluppata la pianta, per la quale scoprivo d’essere vissuto senza saperlo». Senza saperlo nella finzione letteraria, consciamente invece nella realtà dei fatti. Del resto, fuori della metafora del romanzo, il seme che muore quando la pianta cresce prende uno strano, non si sa se amaro o malinconico o trionfante risvolto di verità.
«Come il seme, anch’io ero destinato a morire non appena si fosse sviluppata la pianta, per la quale scoprivo d’essere vissuto senza saperlo». Senza saperlo nella finzione letteraria, consciamente invece nella realtà dei fatti. Del resto, fuori della metafora del romanzo, il seme che muore quando la pianta cresce prende uno strano, non si sa se amaro o malinconico o trionfante risvolto di verità.
La camera rivestita di sughero, dove Proust visse a letto gli ultimi otto anni, con le rare visite di qualche amico, la presenza costante, ma discreta e appartata della domestica Celeste Albaret, e soprattutto la morte immediatamente dopo il compimento dell’opera assomigliano così da vicino alla soffocazione del seme.
La convinzione di essere nato per scrivere, la sicurezza di avere una sorta di responsabilità verso la società del suo tempo e più ancora verso l’eternità gli permettono di non sentire alcuno scrupolo nel dedicare tutta la vita ad avvicinare la fatiscente mondanità del Faubourg Saint Germain, l’ambiente aristocratico e snob, con i suoi intellettuali e gli artisti, rinunciando ad incamminarsi nel binario di una possibile carriera, che romperebbe quel ritmo di vita tutto particolare, dall’apparenza dissipata e vuota.
Ho detto che Gide aveva guardato con la sufficienza dello scrittore impegnato all’opera del mondano e fatuo Marcel Proust. E di primo acchito il giudizio di Gide avrebbe potuto avere qualche fondamento: il precedente de Les plaisirs et les Jours non conteneva niente più di un intenso, troppo partecipato pathos da salotto, mezzo tra ironia e dramma, collocato in una società di amori finemente descritti, di passioni, di ambiguità trattenute da un evidente e falsamente disincantato pudore narrativo.
A venticinque anni Proust non osava ancora farsi prendere la mano dal mistero dell’analisi, dallo sguardo distaccato sulla complessità degli uomini. E soprattutto non è ancora maturo l’uomo, prima che lo scrittore, perché di quest’ultimo le novelle testimoniano un innegabile gusto narrativo e la sensibilità dell’osservazione: questo anche in quell’impalpabile Indifférent, che lo stesso autore avrebbe depennato dalla raccolta, ma sulla cui precisione di scrittura non ci sono dubbi.
Già da ora il giovane scrittore, vezzeggiato dagli amici e dagli ammirati frequentatori del salotto di M.me Lemaire, sa di non aver intenzione di raggiungere e nemmeno di cercare la fama; sembra anzi aver chiaro che la sua vicenda di artista, totalmente legata a quella dell’uomo, succhia dalla crescita dell’uno la linfa vitale anche all’altro e la vocazione, di cui parlavo prima, richiede tempi, che non sono quelli dell’immediato successo, ma piuttosto di una attesa qualche volta scoraggiante.
Quanto scoraggiante lo dimostrano le sue lettere, scritte negli ultimi anni del secolo, quando la stesura del Jean Santeuil, primo, enorme abbozzo della futura Recherche, si allunga di episodi, di considerazioni, ma non si compone in un dato organico, non trova la sua sintesi. I personaggi del grande capolavoro sono già annunciati qui, con l’ingenuità di sottili maschere, dietro lievissime alterazioni di nomi, che ogni tanto l’autore dimentica perfino di apportare, e che lasciano intravedere il modello con una trasparenza ingenua e nello stesso tempo presuntuosa.
Evidentemente immaturo per compiere la sintesi necessaria tra riflessione e narrazione, immaturo per cogliere (e quindi sciogliere) il nodo centrale della sua stessa personalità, si lascia andare alla deriva sulle scorie degli entusiasmi giovanili, si abbandona a conclusioni troppo affrettate ed esplicite, a compiaciute ed ironiche osservazioni di un mondo, di cui lui per primo è troppo parte integrante, tanto che lo guarda con una curiosità saputa e quasi bambina e perfino con invidia.
Diventeranno, questi, gli stupori del Narratore della Recherche, quando affronta per la prima volta quel vagheggiato luogo sacro, tempio del passato e della storia che è il salotto del Guermantes. Ma il Narratore è l’uomo maturo, che torna a visitare nella memoria le sue origini, di cui ha già sperimentato l’inconsistenza; quindi è capace di una fedeltà di ricostruzione, di uno sguardo retrospettivo sui miti crollati, senza paura della verità, senza remore nel raccontare l’enfasi del giovane ed inesperto snob dei primi successi mondani.
Il desiderio di una via di sbocco necessaria a liberare un respiro ancora trattenuto, ma vitale, prende la strada dei saggi critici, di brani scritti sui giornali, e pur nella loro brevità, di un grande interesse metodologico nel documentare la metodicità di studio e la concretezza della cultura dello scrittore. Tra i frammenti, gli articoli brevi, ma già lucidissimi (perché nella critica Proust raggiunge anticipatamente la maestria latente del grande scrittore), compare il saggio forse più importante di questi anni, dedicato a John Ruskin, il critico inglese morto nel 1900, amato come maestro di una concezione estetica particolare, del tutto in sintonia, anche se non perfettamente com-baciante, con la passionalità del francese, la cui apparente freddezza analitica non è che il risultato di una misura cercata a lungo, entro cui contenere e arginare il desiderio di comunicare la necessità intrinseca dell’arte.
La considerazione «Forse in arte l’entusiasmo è il criterio della verità» non significa lasciare libero sfogo all’emotività, ma raccogliere in una adesione attenta e critica la testimonianza di un altro e con questa misurarsi.
I saggi critici di Proust sono momenti di intensa vita vissuta: per quanto esteta sia stato, non ha mai misurato l’opera d’arte in funzione della bellezza, o almeno ha fatto di tale bellezza un dato necessario all’incontro tra artista e fruitore. Fa parte dell’introduzione al libro di Ruskin La Bibbia di Amiens nella traduzione francese dello stesso Proust, la declinazione del concetto di Bellezza, termine di riferimento dalle differenti implicazioni nella elaborazione estetica ruskiniana e proustiana, tanto più che il primo visse una profonda, esplicita tensione religiosa, mentre Proust non conobbe che il culto di un’arte elevata al massimo grado della perfezione e della essenzialità.
Ma, in nome sia di un profondo rispetto per la statura artistica del critico inglese, sia per quella affinità che permette di cogliere da due angoli visuali differenti una medesima sensazione o un’identica emozione, sarà proprio l’ateo Proust a difendere la religiosità artistica del credente Ruskin: «Per un’età di dilettanti e di estetizzanti, un adoratore della Bellezza è un uomo che, non praticando altro culto che il suo, non riconoscendo altra divinità che la Bellezza, trascorra la propria vita nel godimento procurato dalla contemplazione voluttuosa dell’opera d’arte.
Ora (…) la Bellezza non può essere amata in modo fecondo, se la si ama soltanto per i piaceri che da. E allo stesso modo che il cercare la felicità solo per la felicità non porta che alla noia e per trovarla non bisogna cercarla, il piacere estetico ci è dato in sovrappiù, se amiamo la Bellezza per lei stessa, come qualcosa di reale esistente fuori di noi ed infinitamente più importante della gioia che ci da». Ruskin in questo brano, che per altro non ne tradisce il carattere, è diventato una sorta di pretesto, uno schermo da cui si delinea con chiara decisione la prima definizione dell’estetica proustiana.
Sono, questi in cui scrive Proust, gli anni del grande fermento naturalista: l’eco della rivoluzione letteraria portata da Zola è più che mai presente nella cultura francese e si sta allargando a macchia d’olio nel mondo letterario europeo. E’ il momento in cui un convinto populismo auspica e lavora per una narrativa che deve arrivare alla gente degli strati più umili; non si parla ancora in termini di massa, ma il concetto è già latente. Il popolo è il centro dell’interesse, nasce la polemica contro la torre d’avorio dell’intellettuale e dell’artista e si grida a gran voce il nome della realtà, l’adesione al criterio del realismo.
La posizione di Proust è per lo meno anomala e coraggiosa, al di sopra delle parti. Nessuna concezione ad un pur ben intenzionato populismo: prima di tutto l’uomo è un individuo, la sua realtà passa attraverso un setaccio finissimo di emozioni, di sensazioni, di immagini, che sono solo esperienze individuali, tanto più, quindi, uniche ed irripetibili.
Un, mondo di segni sconosciuti. E «quanto al libro interiore di tali segni sconosciuti (…) nessuno poteva aiutarmi con nessuna regola a decifrarlo: perché la sua lettura consiste in un atto di creazione in cui nessuno può sostituirci e collaborare con noi. Quanti si guardano, perciò, da tale lettura?». Allora non rimane che scegliere tra l’andare allo scandaglio di sé, operazione così dolorosa e ingrata, ma necessaria, o l’abbandonare l’impresa e cercare la compagnia di una folla, che non è che un rifugio di scampati al compito primo di ogni uomo, che sta nel conoscere il mondo, conoscendo per prima cosa se stessi.
«E’ l’istinto a dettare il dovere e l’intelligenza fornisce i pretesti per eluderlo. Solo che nell’arte le scuse non valgono (…) il che fa sì che l’arte è il fatto più reale, la più austera scuola di vita, ed il vero Giudizio finale». Forse pochi credenti hanno sentito così imperioso ed imprescindibile questo Giudizio, tanto da vivere solo in funzione di quel momento. Questa porta stretta, l’unica via di salvezza, che pure è il caso raro, destinato a pochi eletti, è una sorta di fonte inesauribile e vicina, solo che si abbia il coraggio di toccarla. Perché, se è di pochi rispondere ad un appello tanto imperioso, potrebbe essere di molti decifrare, riconoscere in un dato esterno quella specie di richiamo indistinto, lontano e magari soffocato, che è nella memoria di ogni uomo, come un archetipo sconosciuto.
 La condizione di chi non lo sa riconoscere e tradurre è fatta di una perduta nostalgia: «Le belle cose che scriveremo sono in noi indistinte, come il ricordo di un’aria che ci incanti, senza che riusciamo a ritrovarne il tracciato, a canticchiarla, e nemmeno a darne il disegno quantitativo, a dire se ci sono pause o serie di note rapide. Coloro che sono ossessionati da questo ricordo confuso di verità che non hanno mai conosciute sono uomini intellettualmente dotati.
La condizione di chi non lo sa riconoscere e tradurre è fatta di una perduta nostalgia: «Le belle cose che scriveremo sono in noi indistinte, come il ricordo di un’aria che ci incanti, senza che riusciamo a ritrovarne il tracciato, a canticchiarla, e nemmeno a darne il disegno quantitativo, a dire se ci sono pause o serie di note rapide. Coloro che sono ossessionati da questo ricordo confuso di verità che non hanno mai conosciute sono uomini intellettualmente dotati.
Ma, se si appagano di dire che odono un’aria deliziosa, essi nulla indicano agli altri, non hanno talento. Il talento è come una sorta di memoria capace di permettere loro di finire col ravvicinare a sé quell’aria indistinta, di sentirla con chiarezza, di annotarla, di riprodurla, di cantarla. Giunge un’età in cui il talento si indebolisce insieme con la memoria, e in cui il muscolo mentale che accosta i ricordi interni a quelli esterni non ha più forza. Talvolta questa età dura l’intera vita, per mancanza di esercizio, per troppo rapida contentezza di sé. E nessuno conoscerà mai, nemmeno chi la sente, l’aria che ci perseguitava con il suo ritmo inafferrabile ed incantevole».
Ma il rapporto che si apre tra chi ha decifrato questa musica, chi ha riconosciuto nell’esilio la patria perduta da cui viene ogni artista, e chi, nel tramite dell’artista stesso, l’ha avvicinata e sentita sua, è il punto di partenza per il cammino verso la Verità.
Proust, che ha tenuto fede, nel corso della sua opera, al principio della noncuranza dell’autore nei riguardi del pubblico, irridendo chi cercava di accattivarselo con ogni mezzo, di fatto ha raggiunto per questa via e nella maniera più diretta il suo interlocutore, senza avvolgerlo in una fascia massificante, scovandolo piuttosto, singolo individuo con le sue peculiarità e la sua sensibilità, per chiamarlo ad un confronto faccia e faccia: «… io non avrei domandato loro né di lodarmi, né di biasimarmi, ma soltanto di dirmi se è proprio così, se le parole che essi leggono dentro di sé sono proprio quelle che io ho scritto».
E’ un richiamo esplicito, un invito a parlare di quello che la capacità poetica di un altro risveglia e illumina. L’arte è diventata il concreto trait d’union tra uomo e uomo: amarla non fa parte dell’esaltazione passeggera di un momento, come non è il frutto di una immediata faciloneria: «Forse, se fosse in potere di tutti essere colpiti dall’amore per una opera d’arte come è in potere di tutti (almeno sembra) di essere colpiti dall’amore per una persona dell’altro sesso (parlo dell’amore véro), ci si renderebbe conto che il vero amore per un’opera d’arte è raro e che gli innumeri godimenti artistici di cui parlano le persone dotate e dalla vita armoniosamente regolata sono ben inferiori a tale amore».
Ma questo amore può nascere, e è più duraturo, più radicato, quando è il frutto di una assimilazione lenta, di una frequentazione, che fa del capolavoro un fatto scoperto lentamente, giorno per giorno, nato nel cuore di chi lo incontra, così come è nato nelle mani di chi lo ha creato, attraverso una ricerca paziente e reciproca, condotta passo a passo fino a svelare il mistero della creatura e del suo creatore.
Vale la pena di percorre insieme a Proust la delicatezza della sua scoperta di uno dei più bei monumenti del gotico francese, la cattedrale di Amiens, preparata nella mente dello scrittore dalla lettura di Ruskin. «Era una splendida giornata, ed io ero arrivato nell’ora in cui il sole fa la sua visita quotidiana alla Vergine, un tempo dorata, e che ora esso indora solo negli istanti in cui le restituisce, nei giorni in cui brilla, quasi uno splendore diverso, fuggevole e più dolce. (…). Era l’ora della visita alla Vergine; e a quella carezza momentanea essa sembrava rivolgere il suo sorriso secolare».
 L’imponenza della cattedrale e la dolcezza della statua della Madonna prendono forma e si innalzano (perché è una vera e propria elevazione dalla sfera estetica a quella del sentimento) dalla immobilità della pietra all’amichevole premura di una vera e propria accoglienza. Chi, tornando a visitare una città, a vedere un quadro o a sentire una musica già conosciuta, non ha vissuto questa dimensione dell’attesa prima e dell’incontro poi? Un sentimento ben più saldo della curiosità, soprattutto della curiosità artistica e dotta, e che rende la seconda volta tanto più dolce di quella prima, che pure aveva l’entusiasmo della sensazione nuova e della scoperta, ma non ancora la tenacia della memoria e dell’affetto, la dimestichezza della frequentazione, necessaria nel rapporto con un oggetto o con un luogo, come nel rapporto con una persona.
L’imponenza della cattedrale e la dolcezza della statua della Madonna prendono forma e si innalzano (perché è una vera e propria elevazione dalla sfera estetica a quella del sentimento) dalla immobilità della pietra all’amichevole premura di una vera e propria accoglienza. Chi, tornando a visitare una città, a vedere un quadro o a sentire una musica già conosciuta, non ha vissuto questa dimensione dell’attesa prima e dell’incontro poi? Un sentimento ben più saldo della curiosità, soprattutto della curiosità artistica e dotta, e che rende la seconda volta tanto più dolce di quella prima, che pure aveva l’entusiasmo della sensazione nuova e della scoperta, ma non ancora la tenacia della memoria e dell’affetto, la dimestichezza della frequentazione, necessaria nel rapporto con un oggetto o con un luogo, come nel rapporto con una persona.
E’, in certo senso, questa la chiave di volta (una delle tante dell’immenso mondo della Recherche) di quel groviglio lentamente dipanato di memorie e di ritorni, quella capacità totale di godere della natura e della creatività dell’uomo. Quel piacere delle cose, che circa negli stessi anni D’Annunzio esibiva sotto forma di un estetismo pesante e morboso, sensuale e torbido, in Proust è un continuo inno alla complessità dell’uomo, alla fluidità che gli scorre intorno, alla bellezza innegabile della materia e al piacere, liberante, consapevole, di gustarla. Il senso oscuro del peccato, della colpa e della ribellione sorda, che nel nostro poeta genera l’avvinghiante pastosità del vero, bellissimo eppure sterile, trova nella poetica di Proust una dimensione cristallina.
Eppure proprio Proust ha conosciuto con esperienza diretta, cercata e condotta fino alle estreme conseguenze, la degradazione dell’uomo; l’ha sperimentata su di sé, provando a cercare il piacere fisico fino alla abiezione. Ed è sconcertante e sconvolgente la lucidità con cui ha vissuto la discesa in quella specie di palude, che sarà la «Sodoma e Gomorra» della Recherche. Non è una discesa dantesca agli inferi: troppo coinvolto e direttamente nel viluppo del male e della degenerazione, la sentirà come un’esperienza profondamente personale. Ma, dentro il dramma di una tale profanazione di sé, mantiene, se non un distacco, certo la straordinaria preveggenza del suo destino.
La redenzione da questo inferno gli verrà, e non sarà un atto di superbia, dalla consapevolezza presente nel momento stesso dell’abbandono, così che l’uomo vive la sua storia in simbiosi con lo scrittore e, nella capacità di raccontare e di analizzare il male, trova la sua via di uscita. C’è una sorta di ritrovata purificazione o di mai perduta purezza, anche nei brani più sordidi della vita dello scrittore, che danno il loro frutto in alcuni dei personaggi del poema, quali l’enigmatica figura della figlia di Vinteuil, che ha profanato e insultato il padre morto, sputando sul suo ritratto prima di abbandonarsi ai piaceri illeciti con una sua compagna; gesto ripugnante, ma a suo modo carico di una struggente e disperata tenerezza, di un ignorato desiderio di perdono, prima ancora che del senso della colpa.
La tenerezza e quasi la sacralità che faranno sì che l’opera musicale di Vinteuil, sconosciuta e frammentata, venga ricomposta dalle due donne con un lavoro paziente, che renderà all’oscuro insegnante di provincia la fama postuma di un grande musicista. La Sonata di Vinteuil ed il Settimino corrono per tutta l’opera di Proust come un sottofondo musicale, talora assopito, poi perentoriamente emergente, di uno smalto inintaccato e purissimo. Certo, qualcosa nell’oscura scienza del male che Proust ha conosciuto con esperienza diretta gli ha insegnato ad andare al di là dell’apparenza prima, della stessa sostanza poi, per riconoscere il sostrato fragilissimo e mutevole dell’uomo.
Non ne poteva trarre nessuna fiducia, nessun ottimismo: le sue affermazioni in proposito sono dure, perentorie: «(L’amicizia) è una cosa così da poco, che provo fatica a comprendere che uomini di qualche genialità, come per esempio Nietzsche, abbiano avuto l’ingenuità di attribuire un certo valore intellettuale e, di conseguenza, di rifiutarsi a certe amicizie con cui non poteva accordarsi la stima intellettuale.
Sì, sono sempre stato stupito alla idea di un uomo che spingeva a sincerità con se stesso fino a distaccarsi, per scrupolo di coscienza, dalla musica di Wagner, che si era immaginato che la verità può attuarsi in un modo d’espressione per natura così confuso e inadeguato, come sono in genere i nostri atti esterni e in particolare le amicizie, e che ci possa essere un significato valido qualsiasi nel fatto di lasciare il proprio lavoro per andare a trovare un amico e piangere con lui sulla falsa notizia dell’incendio del Louvre.
Tutto lo sforzo dell’amicizia consiste nel farci sacrificare la sola parte reale e incomunicabile (se non per mezzo dell’arte) di noi stessi, ad un’« io » superficiale il quale non trova — come l’altro — la sua gioia in se stesso, ma trova un intenerimento confuso nel sentirsi sostenuto da puntelli esterni, ospitato da un’individualità estranea, dove, felice di quella protezione che gli viene data, esala il suo benessere in approvazioni gratuite e si meraviglia di qualità, che chiamerebbe difetti e cercherebbe di correggere in sé. D’altronde gli spregiatori dell’amicizia possono, senza illusioni e non senza rimorsi, essere i migliori amici del mondo ».
Chi affronta una tale demolizione dell’amicizia di fatto per tutta la vita ne ha coltivato un tenace sentimento e ha cercato con risvolti di tenerezza femminea la compagnia degli altri. La stessa amarezza e lo stesso senso di impotenza e di irraggiungibilità è nella concezione dell’amore, di ogni amore, da quello filiale a quello tra i due sessi.
Eppure, dalla disillusione e dalla coscienza della realtà delle cose, Proust ha dedotto, accanto ad un rispetto integro per l’amore in tutte le sue forme e sfaccettature, anche una penetrante capacità di comprensione per chi ama, qualunque sia l’oggetto dell’amore: tra le righe del romanzo passano, vagliati uno ad uno, non solo i terribili traumi e i tormenti della gelosia, ma tutto il complesso meccanismo che porta un essere verso un altro e lo imprigiona in una spira, che sfugge totalmente alla realtà fisica dell’oggetto amato, per non nutrirsi che di se stessa. Una specie di oscura, inconscia solitudine, celata da una speranza inutile e disillusa.
Com’è terribile e vera, qui, la convinzione dello scrittore che la realtà dell’uomo e dell’artista vivono una casuale vicinanza, due persone differenti in un medesimo corpo; e delle due all’artista è data la lucidità, che all’uomo è negata, così che quest’ultimo continua ad inseguire quello che l’altro sa irraggiungibile e assente.
Sul tema dell’amore si riinnesta invece la saldezza concreta dell’arte. La dimestichezza con il mistero si compone e si spezza nel momento in cui l’arte, come la Vergine amienoise, diventa un tema accanto all’amore, accanto al ritmo quotidiano, alla memoria. La Sonata di Vinteuil in Swann è più presente ancora della stessa Odette, la donna amata disperatamente; la bellezza di Venezia è legata all’amore del Narratore per Albertine, come lo sono i dipinti del Carpaccio, da cui sono nati i tessuti delle vestaglie di Fortuny, regalati ad Albertine poco prima della sua morte.
E’ quell’andare a cercare nei volti di tutti i giorni il tratto che li accomuna al grande dipinto che fa dell’arte una realtà e la introduce nella vita. Il raffinato cultore di pittura, Charles Swann, si innamora di Odette, la mondana d’alta classe bella di una bellezza sfiorita e sfatta, solo quando riconosce in lei i lineamenti della Sefora del Botticelli. Per una strana alchimia, arte e vita, immaginazione e realtà si compenetrano e fanno il tema di fondo della sinfonia proustiana, prendono una concretezza simile alla realtà dei personaggi del romanzo, quando sfumano e si sfaldano o si compongono nelle trasfigurazioni della memoria e dell’impressione.
Tutto consiste nella mente dell’uomo, nella sua capacità di incamerare momenti e impressioni, che erano rimasti inerti, fin quando un niente li ha fatti tornare alla realtà con la stessa freschezza del momento vissuto. Perché non c’è intelligenza e razionalità nella memoria, ma una sintesi folgorante, che permea il presente del passato e lo riconduce non come ricordo, ma come presenza. E’ uno strano, ingovernabile potere di resurrezione, che arriva improvviso e porta con sé la stessa felicità di un ritorno reale, della stessa realtà della vita.
Solo uno è il tormento doloroso e irrisolto dell’artista: come un re Mida alla rovescia, perde, distrugge l’oro delle cose nel momento stesso in cui allunga le mani a prenderle, e l’attimo del desiderio non si compie mai nella felicità del possesso. E’ la logica che accompagna la vicenda della Recherche e torna come una spirale ad aprire e chiudere ogni storia individuale, nei particolari più minuti del racconto, come nei suoi «larghi» più ariosi.
Dall’amore di Swann, agli incontri giovanili del Narratore, alla tremenda esperienza di possesso e di annullamento con Albertine, alle inutili immagini evocate nel bambino dal nome mitico e calmo dei Guermantes: tutto diventa evanescente, sfumato e inconsistente, come le figure della sua lanterna magica, nell’attimo in cui la soglia del desiderio è varcata e la realtà si delinea nella totale nullificazione.
Swann sposerà Odette, quando il suo amore per la donna è svanito nel ricordo, così il Narratore ritroverà Gilberte, quando l’«io» che l’ha amata è morto. Si ripete all’infinito il tema della morte, delle tante morti, cui seguono resurrezioni senza eternità, che preludono alla successiva fine. La paura della morte, che il ‘900 ha sentito e sente ancora con particolare violenza e ha cercato perciò di esorcizzare e negare, in Proust prende l’aspetto domestico di una fine sperimentata di giorno in giorno, ogni volta che un desiderio prepotente ci abbandona.
L’uomo che riemerge è una creatura totalmente nuova, che, guardandosi intorno, riconosce i contorni e la consistenza delle cose, ma non ne sente più il sapore antico, di cui non percepisce che una fredda nostalgia. L’eternità che l’uomo crede di desiderare non è che un errore di prospettiva, la cristallizzazione di un momento destinato a esaurirsi. La stessa paura della fine fisica si risolve in questo conflitto di memoria e dimenticanza.
Proust, dicevo all’inizio, è uno dei momenti più illuminati del nostro ‘900 e su questo punto, soprattutto, la sua profondità di analisi arriva ad abbattere, annullare quel residuo di compiaciuto romanticismo, che percorre tanta parte della letteratura europea; lui, così affascinato dalle assonanze, dalla musicalità della poesia, sensibile all’estremo alla raffinatezza stilistica, non ha mai perso di vista il confine di una assoluta austerità. Il mondo morente dell’Europa ai bordi della guerra, che sta trascinando la sua fine in uno splendido corteo funebre, emerge senza veli ed eufemismi, ma senza compiacimenti moraleggianti verso l’incedere superbo, di chi si incammina verso la sua condanna.
Sono per molta parte le sue radici culturali a dare allo scrittore questa penetrante lucidità, insieme alla purezza dello stile e al piacere di comporre, parola per parola, la frase e l’immagine. Permeato dalla storia letteraria della Francia, attraverso sé fa riemergere i ritmi, i suoni e le armonie di una lingua, che è con tutta evidenza il filo che lega, nei secoli, una tradizione nel senso più alto della parola. Sono esplicite a questo proposito le sue analisi critiche (i saggi dedicati a Baudelaire sono la declinazione in prosa del canto del poeta): nella precisione di affronto della musicalità del verso, della sintonia tra ritmo e contenuto c’è un continuo confronto con il poeta.
La lettura di un’opera significa anzitutto andare alla ricerca dei suoi temi meno scoperti, scovarli nei sottintesi, rovesciarli per cercarne il codice più segreto e mediare da questa scoperta il passaggio ad una creatività nuova. Dai racconti di George Sand, alle Memorie d’oltretomba di Chateaubriand, fino alla lettura dei suoi contemporanei, in particolare M.me de Noailées, Proust non ha fatto che addentrarsi in un lago sempre più profondo e vasto, cercando di sentirne le correnti.
Uomo di cultura enorme, ha vissuto la sua erudizione come una necessità, l’inevitabile percorso alla decifrazione della sua origine e quindi della sua continuità. Quel lavoro che chiederà a buon diritto ai suoi lettori, è stato l’impegno continuo della sua maturazione intellettuale. E’ stato anche l’amore alle opere di chi lo aveva preceduto, la sensibilità al loro valore a farne lo stupendo continuatore. «(…) si può rifare quello che si ama solo ripudiandolo. (…) Senza dubbio, quando, si è innamorati di un’opera, si vorrebbe fare qualcosa del tutto simile; ma bisogna rinunciare al proprio amore del momento e pensare non alle proprie predilezioni, ad una verità che non si chieda quali siano le nostre preferenze. E solo a patto di seguirla ci può accadere di incontrare di nuovo quel che avevamo abbandonato e di scrivere, immemori di loro. Le mille e una notte o i Memoires di Saint Simon di un’altra epoca».
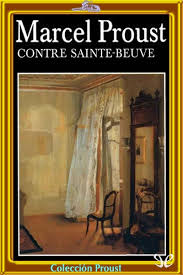 Il saggio Contre Sainte Beuve, scritto prima di concepire la Recherche, si apre con una strana osservazione: «Ogni giorno attribuisco sempre minor valore all’intelligenza. Ogni giorno mi rendo sempre meglio conto che solo indipendentemente da essa lo scrittore può cogliere nuovamente qualcosa delle sue impressioni, ossia qualcosa di lui stesso e la sola materia dell’Arte». Nate da un’intelligenza straordinaria, queste parole sono la evocazione di una forza indecifrata alla sua origine, la forza di una comunicazione di sé necessaria, tanto da trovare le vie più indirette, più strane e riposte per farsi sentire.
Il saggio Contre Sainte Beuve, scritto prima di concepire la Recherche, si apre con una strana osservazione: «Ogni giorno attribuisco sempre minor valore all’intelligenza. Ogni giorno mi rendo sempre meglio conto che solo indipendentemente da essa lo scrittore può cogliere nuovamente qualcosa delle sue impressioni, ossia qualcosa di lui stesso e la sola materia dell’Arte». Nate da un’intelligenza straordinaria, queste parole sono la evocazione di una forza indecifrata alla sua origine, la forza di una comunicazione di sé necessaria, tanto da trovare le vie più indirette, più strane e riposte per farsi sentire.
Saranno, nell’opera definitiva, «le intermittenze del cuore», da cui si snoderanno le immagini, le ricostruzioni, la sostanza del poema proustiano. Le evidenze schiaccianti sono tali proprio nella misura in cui la loro trasparenza non chiede che di essere penetrata per se stessa, non si perde in teorizzazioni, in spiegazioni. Soprattutto non ha paura di non essere capita. Per questo Proust non ha voluto dire niente di sé, se non dietro il velo sottile di questa sua discretissima, ironica «assenza».
|
BIBLIOGRAFIA
PROUST, La recherche du temp perdu, Einaudi 1973
PROUST, Jean Santeuil, Einaudi 1976
PROUST, Les plaisirs et les jours, Sougarco 1968
PROUST, Cantre Sainte-Beuve, Einaudi 1974
PROUST,, Giornate di lettura, Einaudi 1958
M.PROUST, L’indifferente, Einaudi 1978 Correspondence de Marcel Proust, Plon 1976
PAINTER, Proust, Feltrinelli 1979
ALBARET, Il Signor Proust, Rizzoli 1974