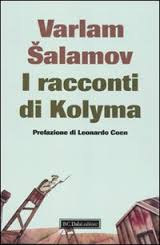Pubblicati in Italia i «Racconti di Kolyma» dove lo scrittore descrive i suoi diciassette anni di lavori forzati
Salamov e la sua tragica odissea dal gulag al manicomio
di Cristina Bongiorno
Se qualcuno dà una spinta a chi sta cadendo, normalmente viene chiamato farabutto; invece la letteratura sovietica lo elegge a eroe. Inaugura il nuovo stile di vita nel 1929 Maksim Gor’kij, che, con la descrizione di Solovki, forgia il primo modello di letteratura apologetica dei Gulag. Non gli basta giustificarlo. Ne afferma la necessità e l’utilità: rieducare «il popolo che vuole mangiare il più possibile e lavorare il meno possibile»… «è un’opera importantissima e meravigliosa»:
Concezione insolita nella letteratura russa, solitamente filantropica.
Anton Cechov, visitando nel 1890 Sachalin, l’«isola di sofferenza» dei galeotti situata a nord del Giappone, aveva provato vergogna e compassione e s’era convinto «che nel giro di cinquanta o cent’anni, le condanne a vita saranno considerate con lo stesso orrore che può suscitare in noi, oggi, un genere di pena come l’asportazione delle narici…».
Ma — benché discordi — sia Gor’kij sia Cechov si trovano nella posizione privilegiata degli spettatori. L’anello di congiunzione mancante è costituito da Varlam Salamov, condannato al Gulag come intellettuale per sopravviverci come deportato, che distilla diciassette anni di lavori forzati in circa centocinquanta scabri Racconti di Kolyma, un terzo dei quali in Italia sono stati appena pubblicati (Adelphi). Altre edizioni, sempre parziali, sono uscite nel 1976 (Savelli) e nel 1992 (Sellerio). L’edizione integrale russa ha dovuto aspettare fino al 1992.
La Sachalin di Cechov è gradevole come una stazione termale in confronto al circondario nord-orientale della Siberia detto Kolyma dal fiume che vi scorre, una lastra di ghiaccio percorsa al massimo da piccole tribù nomadi come i ciukci, gli evenki, gli jakuti. La capitale è Magadan e quando fa caldo, in luglio, la gente gira in cappotto, se c’è la luce del crepuscolo vuol dire che è pieno giorno. Kolyma suscita l’interesse dei russi solo nel nostro secolo, quando si diffonde la notizia che è ricca d’oro. Nell’autunno 1929, sul golfo di Nogaev (Mare di Ochotsk) viene costruito il primo insediamento di base. Allora vi si arrivava solo per mare da Vladivostok o da Machodka, navigando otto-dieci giorni verso nord.
L’11 novembre 1931, il comitato centrale del Partito comunista approva la mozione di creare nel Kolyma il Dalstroj, un monopolio per l’estrazione di oro, argento e altri metalli. Tre mesi più tardi nel golfo di Nogaev entra la nave «Sachalin». A bordo ha viaggiato il primo direttore della colonia penale: il comunista lettone, generale della Gpu (polizia politica, in seguito cambierà nome diventando Nkvd e Kgb), Edvard Berzin. Ha trentanove anni. Ne vivrà altri cinque, in tempo perché il suo destino da aguzzino incroci quello da vittima di Salamov, trent’anni, alla sua seconda condanna.
Questa volta, è il 1937, data che segna l’inizio delle grandi purghe, è accusato di «attività controrivoluzionaria trotzkista», e deve scontare la pena in uno dei centosessanta campi che si sono meritati l’appellativo di «crematorio bianco». Sui cancelli fanno bella mostra le parole di Stalin: «Il lavoro è una questione d’onore, di coraggio e d’eroismo».
«Il giorno lavorativo — scrive Salamov — dura sedici ore. La gente dorme in piedi appoggiandosi alle vanghe. Non può né sedersi, né sdraiarsi: li fucilerebbero sul posto… Buio biancastro con una tinta blu della notte invernale, 60 gradi sotto zero. L’orchestra delle trombe d’argento suona le marce davanti alla fila dei detenuti semimorti. Nella luce gialla delle enormi torce di benzina una guardia legge la lista dei nomi dei detenuti fucilati per non aver raggiunto la norma della produttività».
L’arrivo di Berzin dimostra che l’inferno non è fantasia di teologi e poeti. Kolyma passerà alla storia delle vergogne del XX secolo. Eppure persino Berzin, agli occhi di Stalin è troppo buono; convocato a Mosca, viene arrestato e mandato davanti al plotone d’esecuzione. Al suo posto, sulla nave «Mikolaj Ezov» arrivano i due nuovi padroni: il colonnello Karp Pavlov (suicidatosi nel 1956) e il suo vice, capo dei campi della morte, il colonnello Stepan Garanin. Ha trentanove anni (ne vivrà ancora uno), indossa un pelliccia d’orso e tiene costantemente la mano sulla pistola infilata nella fondina di legno.
Garanin, secondo l’umore, faceva fuori da una a varie decine di persone al giorno. Intanto canta. Si è calcolato che con Pavlov abbia ucciso quarantamila prigionieri. Berija, il numero due del Cremlino, lo fa fucilare come spia giapponese, ma c’è da giurare che quel fabbro ferraio figlio di un contadino ucraino non ha più la pallida idea di dove si trovi il Giappone.
Come si vede, è insensato fare progetti sul futuro. La fantasia avveniristica di un condannato non si spinge oltre i due giorni di vita, dimostra Salamov nel raccontare la follia del Gulag nella sua routine. Lo scrittore odia i criminali, non trova neanche una parola indulgente nei loro confronti, ma nello stesso tempo, e usando il loro stesso gergo, fa vedere la particolarità del «mondo della mala», l’unica forza organizzata esistente nel campo. Legati da una severa «legge», i criminali in prigione e nei campi si sentono a casa, sono i padroni. Oltre alla loro implacabilità, alla loro bestiale crudeltà, è anche questa compattezza a renderli forti non solo nei confronti dei condannati politici, ma anche dell’amministrazione
A loro volta, le canaglie che dirigono i Gulag hanno la catena della speranza solo un po’ più lunga dei prigionieri. Contagiati dal culto della personalità prendono a battezzare con il proprio nome piazze, fabbriche, scuole, financo città. Berzin si dedica la prima strada di Magadan e Jagoda il parco della Cultura. Tre anni più tardi entrambi sono passati per le armi.
Via Berzin è ribattezzata via Stalin e il parco Jagoda prende il nome del nuovo capo dell’Nkvd, Ezov. Un anno dopo anche Ezov viene fucilato e il parco assume il nome di Stalin. Nel 1956 via Stalin diventa via Marx e parco Stalin diventa Lenin. Per non infierire ulteriormente sul senso dell’orientamento della cittadinanza, i dirigenti degli anni Novanta pensano bene di dare, d’ora in poi, alle strade della «dorata Magadan» — come la glorificava una canzone propagandistica dell’epoca — nomi apolitici.
Ai tempi di Salamov, Magadan funziona soprattutto come camera di decompressione per gli esiliati che, scontata la pena, attendono di essere riammessi, forse, nel consorzio umano, e risiedono in casette di legno dominate dalle torri di guardia, anch’ esse di legno. Tutt’ora gli edifici in muratura si contano sulle dita. E’ per questo motivo che nel Kolyma, nascosto tra boschi e colline di fango, il mondo del lager si sta sgretolando: non sono rimasti che pali ammuffiti, pezzi di rotaie, chiodi e fili di ferro. Picconi, scodelle, vanghe, mattoni, assi, sono stati rubati da prigionieri, da guardie, dalla popolazione locale.
L’unico museo incorruttibile è rappresentato dalla memoria. Ha tenuto in vita molti, come Salamov, l’impegno alla testimonianza, ma pochi hanno potuto renderla. Alcuni, autori di struggenti canzoni nate e tramandate nei campi (Chants du Goulag. incise da Dina Vernyj per Chant du monde, ’75) restano anonimi.
«Sono uno dei quei fossili che appaiono per caso per portare al mondo, intanto, un segreto geologico», dirà Io scrittore reduce, poco prima di morire il 17 gennaio 1982 nel manicomio dove è internato da due giorni. Era diventato sordo, quasi cieco, malato di «ansia di cibo» che accumula nella dispensa dove si decompone con disgusto dei vicini.
Anni prima Aleksandr Solzhenicyn ha proposto a Salamov di scrivere insieme Arcipelago Gulag. Ma lui rifiuta, temendo l’espulsione dall’ospizio dei poveri che lo accoglie. E poi, quanto c’era da dire Salamov l’ha già formulato con uno stile che domina l’orrore del freddo, della fame della paura, della depravazione dei capi che contagia i detenuti, attraverso la castità della parola