 Tratto da: Pensare la storia, San Paolo, Milano 1992, p.243.
Tratto da: Pensare la storia, San Paolo, Milano 1992, p.243.
di Vittorio Messori
Converrà continuare il discorso iniziato nel precedente frammento: riflettere su Roma e il suo destino nell’epoca moderna non è certamente un esercizio provinciale e neppure soltanto italiano, visto il mistero di universalità che – dagli inizi della sua storia – è legato all’insediamento sul Tevere.
L’Italia “laica” ha avuto un atteggiamento ambivalente davanti alla Città Eterna: da un lato il mito di Roma, nutrito di ricordi, conditi con non poca retorica, dell’antichità classica. Dall’altro, l’avversione per ciò che quel luogo era divenuto con i papi e per ciò che, dunque, significava per un cattolicesimo identificato come il nemico principale da battere perché colonna dell’oscurantismo, nocciolo duro della reazione, trincea della resistenza ai “Lumi” della Scienza e del Progresso.
 Questa avversione per la città-simbolo della vicenda cristiana si estendeva (e si estende), un po’ razzisticamente, verso i romani. Giordano Bruno Guerrì, nell’incredibile articolo da cui siamo partiti qui sopra, sentenzia: “lì papa si è ben guardato dal dire che lo sfascio di una città non può dipendere solo da chi l’amministra e che occorre la complicità di chi ci abita: il peggior male di Roma è la romanità dei romani, ovvero quell’accidia arrogante e spocchiosa che non è certo genetica, ma che si è formata in secoli di dominio papale”.
Questa avversione per la città-simbolo della vicenda cristiana si estendeva (e si estende), un po’ razzisticamente, verso i romani. Giordano Bruno Guerrì, nell’incredibile articolo da cui siamo partiti qui sopra, sentenzia: “lì papa si è ben guardato dal dire che lo sfascio di una città non può dipendere solo da chi l’amministra e che occorre la complicità di chi ci abita: il peggior male di Roma è la romanità dei romani, ovvero quell’accidia arrogante e spocchiosa che non è certo genetica, ma che si è formata in secoli di dominio papale”.
La Chiesa, dunque, come corruttrice di anime e di caratteri. Ancora Guerri: “Ci vuole la faccia tosta di Wojtyla per prendersela con una città i cui mali, tutt’altro che recenti, sono stati metodicamente preparati dai suoi predecessori nel corso dei secoli.
Roma era certamente più fetida di oggi quando le miserabili catapecchie del popolino si addossavano alle mille chiese fastose, quando i papa-re angariavano la città per arricchirsi. impotentirsi, michelangiolarsi: impiccando, arrostendo sui roghi. immiserendo”.
 Siamo, come si vede, a una sorta di revival anticlericale. davvero sconcertante nella sua ingenua ripetitività ottocentesca che ignora la realtà effettiva, ben diversa, mostrata dagli studi storici. Certo, sorprende in modo particolare, in un intellettuale contemporaneo, considerare una colpa storica della Chiesa il “michelangiolarsi”. L’avere cioè, con il costante amore per le arti, permesso agli artisti di esprimersi non lesinando loro i mezzi e a Roma, ridotta a rovine coperte di ortiche, di assumere una bellezza che neppure la “nuova” Italia, dopo il 1870, malgrado ce la mettesse tutta, riuscì a distruggere del tutto.
Siamo, come si vede, a una sorta di revival anticlericale. davvero sconcertante nella sua ingenua ripetitività ottocentesca che ignora la realtà effettiva, ben diversa, mostrata dagli studi storici. Certo, sorprende in modo particolare, in un intellettuale contemporaneo, considerare una colpa storica della Chiesa il “michelangiolarsi”. L’avere cioè, con il costante amore per le arti, permesso agli artisti di esprimersi non lesinando loro i mezzi e a Roma, ridotta a rovine coperte di ortiche, di assumere una bellezza che neppure la “nuova” Italia, dopo il 1870, malgrado ce la mettesse tutta, riuscì a distruggere del tutto.
Bellezza che, richiamando da tutto il mondo chi è sensibile alle arti, si è rivelata poi per la città anche il migliore e il più duraturo degli investimenti economici. I Guerri pensano forse che un solo turista si muoverebbe per visitare ciò che dopo il 1870 l’Italia – per oltre mezzo secolo polemicamente anticlericale – ha edificato sui Sette Colli?
 Quanto alle “miserabili catapecchie del popolino” nella città prima della breccia di Porta Pia, è ben noto (come ci hanno detto Marx, Engels e tutto il movimento socialista e umanitario), che, nello stesso periodo, il “popolino” dei Paesi protestanti – dunque acerrimi nemici del “papismo” toccati dalla rivoluzione industriale, godeva il suo comfort sereno nelle villette con giardino e pianoforte dei sobborghi operai di Manchester, di Londra, di Parigi, di Berlino.
Quanto alle “miserabili catapecchie del popolino” nella città prima della breccia di Porta Pia, è ben noto (come ci hanno detto Marx, Engels e tutto il movimento socialista e umanitario), che, nello stesso periodo, il “popolino” dei Paesi protestanti – dunque acerrimi nemici del “papismo” toccati dalla rivoluzione industriale, godeva il suo comfort sereno nelle villette con giardino e pianoforte dei sobborghi operai di Manchester, di Londra, di Parigi, di Berlino.
Quel “popolino” – che là, tra quelle brume, chiamavano “proletariato” – non si addensava attorno a “chiese fastose” ma a quelle nude, terribili, disumane cattedrali che erano opifici e fabbriche; templi innalzati dalla nuova casta sacerdotale, la borghesia, ai soli dei che ormai riconoscesse: il Denaro, il Profitto, la Produzione.
In realtà, in una certa cultura continua ad agire, magari inconsciamente, il rancore verso i romani per non avere fatto nulla per accelerare l’arrivo della “Ragione e del Progresso” all’interno delle Mura Aureliane. Cerchiamo di ripassare un poco quella storia che oggi sembrano ignorare anche tanti “storici”.
 Nel marzo del 1861, aprendosi il primo parlamento del Regno non più di Sardegna ma d’Italia, la Roma ancora papale è acclamata, simbolicamente, capitale d’Italia. Cavour (che mai volle visitare Roma) è troppo realista per cedere alle declamazioni dei retori sulla mitologia dell’Urbe e sui suoi ricordi imperiali: a lui, quella votazione serve per bloccare sul nascere l’antico municipalismo (già molte città, da Milano a Napoli, avanzavano candidature) e per lasciare a tempo indefinito la capitale nella sua Torino, pur così decentrata e malamata dai sudditi del nuovo Regno.
Nel marzo del 1861, aprendosi il primo parlamento del Regno non più di Sardegna ma d’Italia, la Roma ancora papale è acclamata, simbolicamente, capitale d’Italia. Cavour (che mai volle visitare Roma) è troppo realista per cedere alle declamazioni dei retori sulla mitologia dell’Urbe e sui suoi ricordi imperiali: a lui, quella votazione serve per bloccare sul nascere l’antico municipalismo (già molte città, da Milano a Napoli, avanzavano candidature) e per lasciare a tempo indefinito la capitale nella sua Torino, pur così decentrata e malamata dai sudditi del nuovo Regno.
Cavour sa che quella proclamazione è platonica e che lo resterà: la Francia di Napoleone III presidia in armi la Città Eterna e minaccia guerra in caso di occupazione; anche le altre potenze europee, a cominciare dall’Austria cattolica e dalla stessa Prussia protestante, si oppongono alle pretese Italiane. Con la Convenzione con la Francia nel settembre 1864, il Regno, impegnandosi a trasferire la capitale a Firenze, sembra prendere atto definitivamente della impossibilità di installarsi sul Tevere.
 Due anni dopo, nel 1866, onorando quella Convenzione, la Francia ritira le sue truppe da Roma, lasciando solo un presidio internazionale (composto, tra l’altro, da giovani volontari delle famiglie cattoliche di tutta l’Europa e addirittura delle Americhe: non solo il Risorgimento ma anche “l’altra parte” ebbe l’equivalente delle “camicie rosse” garibaldine).
Due anni dopo, nel 1866, onorando quella Convenzione, la Francia ritira le sue truppe da Roma, lasciando solo un presidio internazionale (composto, tra l’altro, da giovani volontari delle famiglie cattoliche di tutta l’Europa e addirittura delle Americhe: non solo il Risorgimento ma anche “l’altra parte” ebbe l’equivalente delle “camicie rosse” garibaldine).
Nel 1870, schiacciato a Sedan dai prussiani il secondo impero napoleonico (e irritata l’Austria dalla proclamazione, fatta dal Vaticano I, dell’infallibilità papale), l’Italia ha mano libera per occupare Roma da dove i francesi si sono ritirati e per trasferirvi, l’anno seguente, la capitale. Ebbene: poco si riflette sulla grave sconfitta morale, sulla insanabile delusione del nazionalismo borghese, dovute al fatto che il 20 settembre i cannoni di Raffaele Cadorna dovettero sparare quattro ore per aprire una breccia nelle mura e fare irruzione in una città che aspettava muta, inerte, come rassegnata.
 I dieci anni dal 1860 al 1870 erano stati, infatti, un testardo quanto inutile sforzo per ottenere l’insurrezione dei romani contro il papa, dando così al governo italiano un pretesto per intervenire. Fino al 1866 i patrioti si consolarono dicendo che la causa della mancata rivolta era la presenza dei francesi. Partiti questi, Garibaldi pensò che il momento fosse giunto ma, penetrato nell’autunno del 1867 in quel che restava dello Stato Pontificio, trovò una popolazione niente affatto festante, bensì largamente ostile (come egli stesso ammise).
I dieci anni dal 1860 al 1870 erano stati, infatti, un testardo quanto inutile sforzo per ottenere l’insurrezione dei romani contro il papa, dando così al governo italiano un pretesto per intervenire. Fino al 1866 i patrioti si consolarono dicendo che la causa della mancata rivolta era la presenza dei francesi. Partiti questi, Garibaldi pensò che il momento fosse giunto ma, penetrato nell’autunno del 1867 in quel che restava dello Stato Pontificio, trovò una popolazione niente affatto festante, bensì largamente ostile (come egli stesso ammise).
Riuscì a Spingersi sin quasi sotto le mura di Roma, fidando nella insurrezione che gli era stata promessa e per la quale il governo italiano non aveva lesinato aiuti in denaro e in armi. “Ci basterebbero solo dieci schioppettate dei romani!”, gemeva, a Firenze, il capo del Governo, Giovanni Lanza. Ma quelle schioppettate non ci furono; anzi, non mancarono i popolani laziali che si arruolarono volontari per contrastare l’invasione garibaldina.
 I ‘congiurati”, pagati dal governo dì Firenze e da Garibaldi, spiegarono poi che la promessa rivoluzione contro il papa non era stata fatta perché, la sera convenuta, si era messo a piovere.
I ‘congiurati”, pagati dal governo dì Firenze e da Garibaldi, spiegarono poi che la promessa rivoluzione contro il papa non era stata fatta perché, la sera convenuta, si era messo a piovere.
Così, a Mentana, i pontifici e i francesi mettono in fuga i garibaldini e l’esercito italiano non può intervenire (come era stato programmato) prendendo a pretesto morale la rivolta degli abitanti del Lazio e di Roma che non ci fu. Lo stesso accade nel 1870, quando la Francia sconfitta e poi in preda al marasma della Comune richiama il suo presidio.
Anche stavolta si cerca di suscitare un insurrezione; ma anche stavolta denari, sforzi, agenti provocatori si rivelano inutili. Tanto che ancora il 10 settembre, quando già le truppe di Cadorna convergono sulla città, Pio IX, acclamatissimo dal popolo, si reca a inaugurare una fontana sulla piazza di Termini. E, irrompendo dieci giorni dopo da Porta Pia su quella che sarà, appunto, la via XX Settembre, i bersaglieri trovano strade deserte, imposte chiuse, una città che sembra considerarsi più invasa che “liberata”. E che sempre distinguerà tra essa e gli “italiani”, chiamati buzzurri, cioè forestieri rozzi e non invitati.
 Un bello smacco per la retorica nazionalista e laicista: questa delusione è tra i motivi di una tenace avversione contro i romani, colpevoli di non avere voluto muovere un dito per togliersi di dosso quella che (stando allo schema) sarebbe stata “l’intollerabile oppressione papalina”. Un disprezzo “laico” che si aggraverà ancora perché, nel 1943, fuggito dal Quirinale il nipote del re giunto nel 1870, e dissoltosi non solo il governo ma persino lo Stato entrato a cannonate, i romani si strinsero di nuovo attorno al papa, ridandogli spontaneamente l’antica autorità; e, partiti i tedeschi, si riversarono in massa a piazza San Pietro per acclamarlo come “difensore della città” che, unico tra i potenti, non aveva abbandonato.
Un bello smacco per la retorica nazionalista e laicista: questa delusione è tra i motivi di una tenace avversione contro i romani, colpevoli di non avere voluto muovere un dito per togliersi di dosso quella che (stando allo schema) sarebbe stata “l’intollerabile oppressione papalina”. Un disprezzo “laico” che si aggraverà ancora perché, nel 1943, fuggito dal Quirinale il nipote del re giunto nel 1870, e dissoltosi non solo il governo ma persino lo Stato entrato a cannonate, i romani si strinsero di nuovo attorno al papa, ridandogli spontaneamente l’antica autorità; e, partiti i tedeschi, si riversarono in massa a piazza San Pietro per acclamarlo come “difensore della città” che, unico tra i potenti, non aveva abbandonato.
Fu, questo, un finale coerente con gli inizi, con quel lontano 1793 in cui in Francia regnava il Terrore dei giacobini, i quali inviarono nella Roma papale – con funzioni di propagandista e di provocatore coperto dalla immunità diplomatica – Hugon de Bassville, tanto mediocre cantore della Rivoluzione quanto fazioso e virulento miscredente. Bassville, come sintetizza uno storico contemporaneo, “in occasione delle principali cerimonie religiose, accompagnato da servitori e guardie del corpo, era solito mescolarsi ai fedeli e, nei momenti di maggior devozione, si faceva beffe a gran voce dei sacramenti, dei celebranti e dei luoghi e oggetti di culto e invitava, bestemmiando, a devastare le chiese e a consegnargli i sacerdoti affinché, tradotti a Parigi, venissero decapitati”.
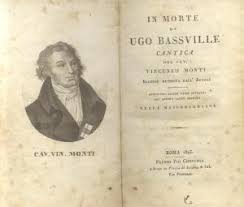 A fronte della eccessiva tolleranza del papa, che si limitava a proteste cui dalla Francia si rispondeva con sarcasmo, intervenne il popolo, quello vero (e non “la plebaglia” come ancora si legge in enciclopedie e testi scolastici), il popolo credente che, ferito nel suo sentimento religioso, un bel giorno perse la pazienza e alle bestemmie ripetute per l’ennesima volta proruppe in tumulti che culminarono con il linciaggio di Bassville.
A fronte della eccessiva tolleranza del papa, che si limitava a proteste cui dalla Francia si rispondeva con sarcasmo, intervenne il popolo, quello vero (e non “la plebaglia” come ancora si legge in enciclopedie e testi scolastici), il popolo credente che, ferito nel suo sentimento religioso, un bel giorno perse la pazienza e alle bestemmie ripetute per l’ennesima volta proruppe in tumulti che culminarono con il linciaggio di Bassville.
Ne seguì la dichiarazione di guerra della Francia giacobina allo Stato pontificio: dichiarazione, per il momento, platonica, visto che a Parigi c’era ben altro da fare in quei mesi che muovere a battaglia contro il papa. Ma Napoleone non dimenticò e anche per questo, quando giunse in Italia, calcò particolarmente la mano contro Roma.
Ma questa, con l’uccisione del giacobino blasfemo Bassville, si assicurò un primato: era stata la prima città italiana a dimostrare, e violentemente, contro la Rivoluzione. Deve esserci anche questo nel subconscio degli “illuminati” che disprezzano il popolo romano. I Guerri, dunque, non hanno torto: come non detestare gente che massacrò Bassville, che non volle scacciare Pio IX e che ritrovò in Pio XII un “papa-re” cui essere grata?




