Il mondo si è accorto di essere nelle mani della Cina per troppe cose. Farmaci, tecnologia, terre rare. È la via alternativa alle armi scelta da Pechino per conquistare la leadership planetaria. Dopo Trump, tocca a Biden organizzare la resistenza
Rodolfo Casadei
Secondo l’ex presidente boliviano Evo Morales la Cina ha già vinto la terza guerra mondiale senza sparare un colpo, cioè seguendo i dettami del più famoso stratega della storia cinese, il generale-filosofo Sun Tzu, che nel V secolo a.C. scriveva che la vera arte della guerra consiste nel «sottomettere il nemico senza combattere».
 Secondo il neo-presidente americano Joe Biden le cose non stanno così, ma nel suo primo intervento ufficiale sulla sicurezza strategica nazionale ammette che «la Cina è l’unico competitore potenzialmente capace di combinare potere economico, diplomatico, militare e tecnologico per lanciare una prolungata sfida alla stabilità dell’ordine internazionale aperto». Da cui la necessità, per gli Stati Uniti, di controbattere l’Opa sul ruolo di potenza egemone mondiale lanciata da Pechino con una strategia altrettanto attenta alle forme di superiorità non militari.
Secondo il neo-presidente americano Joe Biden le cose non stanno così, ma nel suo primo intervento ufficiale sulla sicurezza strategica nazionale ammette che «la Cina è l’unico competitore potenzialmente capace di combinare potere economico, diplomatico, militare e tecnologico per lanciare una prolungata sfida alla stabilità dell’ordine internazionale aperto». Da cui la necessità, per gli Stati Uniti, di controbattere l’Opa sul ruolo di potenza egemone mondiale lanciata da Pechino con una strategia altrettanto attenta alle forme di superiorità non militari.
Cosa che non sarà affatto facile, considerata la rete di dipendenze economiche, infrastrutturali, tecnologiche con decine di paesi nel mondo che Pechino ha saputo creare nell’ultimo decennio e che sta pazientemente e costantemente rafforzando.
 Risparmiata in gran parte dal Covid, nel 2020 la Cina ha consolidato la sua ascesa. È stata l’unica fra le principali economie a registrare una crescita del Pil (+2,3 per cento); è diventata il primo paese al mondo per investimenti esteri diretti (Fdi) con 163 miliardi di dollari contro i 134 degli Stati Uniti (che l’anno prima avevano ricevuto 251 miliardi di Fdi contro i 140 della Cina); si è confermata primo paese al mondo per attivo di bilancia commerciale con la cifra record di 535 miliardi di dollari, il 27 per cento in più del 2019.
Risparmiata in gran parte dal Covid, nel 2020 la Cina ha consolidato la sua ascesa. È stata l’unica fra le principali economie a registrare una crescita del Pil (+2,3 per cento); è diventata il primo paese al mondo per investimenti esteri diretti (Fdi) con 163 miliardi di dollari contro i 134 degli Stati Uniti (che l’anno prima avevano ricevuto 251 miliardi di Fdi contro i 140 della Cina); si è confermata primo paese al mondo per attivo di bilancia commerciale con la cifra record di 535 miliardi di dollari, il 27 per cento in più del 2019.
Ma a preoccupare Washington – e non solo Washington – ancora più dei numeri dell’eccellenza cinese è la realtà di una crescente dipendenza dei sistemi di valore internazionali dalle produzioni, tecnologie e infrastrutture cinesi.
L’emergenza sanitaria del coronavirus e la controversa emergenza ambientale-energetica hanno generalizzato la consapevolezza che la Cina detiene il quasi monopolio mondiale di intere filiere che vanno dai dispositivi di protezione personale alle terre rare, alle batterie agli ioni di litio, ai princìpi attivi degli antibiotici, eccetera.
 Non si può evitare di passare dalla Cina quando si tratta di mascherine protettive (92 per cento di quelle importate nei paesi dell’Unione Europea l’anno scorso), di motori elettrici (più del 70 per cento della capacità manifatturiera globale di batterie per veicoli elettrici si trova in Cina), di medicinali generici (il 70 per cento delle molecole utilizzate per produrli arrivano dalla Cina, e per quanto riguarda gli antibiotici la dipendenza dalla produzione cinese per i loro princìpi attivi si colloca fra l’80 e il 90 per cento); infine non si può evitare di passare dalla Cina per quasi tutto ciò che va dai cellulari alle automobili, agli armamenti di ultima generazione (caccia F-35, sistemi di guida dei missili, sommergibili nucleari), perché il 90 per cento della produzione delle terre rare indispensabili per questi manufatti tecnologici è realizzata in Cina.
Non si può evitare di passare dalla Cina quando si tratta di mascherine protettive (92 per cento di quelle importate nei paesi dell’Unione Europea l’anno scorso), di motori elettrici (più del 70 per cento della capacità manifatturiera globale di batterie per veicoli elettrici si trova in Cina), di medicinali generici (il 70 per cento delle molecole utilizzate per produrli arrivano dalla Cina, e per quanto riguarda gli antibiotici la dipendenza dalla produzione cinese per i loro princìpi attivi si colloca fra l’80 e il 90 per cento); infine non si può evitare di passare dalla Cina per quasi tutto ciò che va dai cellulari alle automobili, agli armamenti di ultima generazione (caccia F-35, sistemi di guida dei missili, sommergibili nucleari), perché il 90 per cento della produzione delle terre rare indispensabili per questi manufatti tecnologici è realizzata in Cina.
Il cavallo di Troia di Xi Jinping
La Cina ha quasi raggiunto gli Stati Uniti per quanto riguarda la spesa nella ricerca (532,8 miliardi di dollari nel 2019 contro i 596,5 americani) ed è già superiore alla somma dei quattro paesi che le stanno dietro, cioè Germania, Giappone, Corea del Sud e India. E l’anno scorso per la prima volta ha superato gli Stati Uniti per depositi di domande di brevetto internazionale.
 L’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale ha registrato 58.990 domande di origine cinese e 57.840 di origine americana. L’obiettivo del presidente Xi Jinping è di fare della Cina la potenza leader mondiale in materia di tecnologia entro il 2049, cosa che ne determinerebbe automaticamente lo status di potenza egemone su scala globale.
L’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale ha registrato 58.990 domande di origine cinese e 57.840 di origine americana. L’obiettivo del presidente Xi Jinping è di fare della Cina la potenza leader mondiale in materia di tecnologia entro il 2049, cosa che ne determinerebbe automaticamente lo status di potenza egemone su scala globale.
Perché, come scrivono Christopher Darby e Sarah Seewall su Foreign Affairs, «la Cina immagina un mondo di competizione fra grandi potenze dove non è necessario sparare un solo colpo. La supremazia tecnologica garantisce la capacità di dominare l’infrastruttura civile che da essa dipende, assicurando enorme influenza. Questa è la principale motivazione dietro alle esportazioni di Pechino funzionali alle infrastrutture civili tecnologicamente avanzate. I paesi che comprano sistemi cinesi forse pensano che stanno semplicemente ricevendo reti elettriche, tecnologia sanitaria o sistemi di pagamento online, ma in realtà forse stanno mettendo infrastrutture nazionali strategiche e dati dei propri cittadini nelle mani di Pechino. Tali esportazioni dunque sono il cavallo di Troia della Cina».
La controffensiva americana era già iniziata sotto l’amministrazione Trump, con i dazi sull’acciaio e altre merci cinesi, il boicottaggio di Huawei, la messa al bando di 260 aziende implicate nella politica di “fusione militare-civile” del regime di Pechino, l’embargo sulle vendite di tecnologie sensibili, in particolare i semiconduttori.
 L’amministrazione Biden si prefigge di renderla più sistematica, creando alleanze di paesi dedite al contrasto del predominio cinese in questo o quell’ambito dello sviluppo tecnologico. L’idea di un’alleanza delle “tecno-democrazie” da contrapporre ai paesi tecno-autoritari era già stata avanzata da un articolo apparso su Foreign Affairs nell’ottobre scorso, alla vigilia delle presidenziali americane, mentre nella primavera dell’anno scorso era stato il governo britannico di Boris Johnson a proporre a Washington un’alleanza di 10 democrazie (i paesi del G7 più Australia, Corea del Sud e India) per la creazione di un pool di fornitori di attrezzature per G5 alternativo alla Cina.
L’amministrazione Biden si prefigge di renderla più sistematica, creando alleanze di paesi dedite al contrasto del predominio cinese in questo o quell’ambito dello sviluppo tecnologico. L’idea di un’alleanza delle “tecno-democrazie” da contrapporre ai paesi tecno-autoritari era già stata avanzata da un articolo apparso su Foreign Affairs nell’ottobre scorso, alla vigilia delle presidenziali americane, mentre nella primavera dell’anno scorso era stato il governo britannico di Boris Johnson a proporre a Washington un’alleanza di 10 democrazie (i paesi del G7 più Australia, Corea del Sud e India) per la creazione di un pool di fornitori di attrezzature per G5 alternativo alla Cina.
L’idea sembra avere fatto breccia nella nuova amministrazione, che intenderebbe estenderla all’intero arco delle tecnologie avanzate: intelligenza artificiale, big data, 5G (cioè quinta generazione delle tecnologie della telefonia mobile), nanotecnologia, biotecnologia, robotica, internet delle cose e computing quantistico.
Dal microchip al 5G
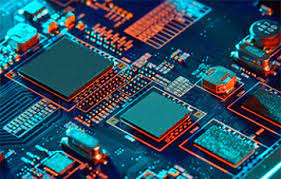 Il primo obiettivo della controffensiva è di mantenere la Cina il più a lungo possibile dipendente dai microprocessori di provenienza estera, e di lavorare costantemente al potenziamento di tale tecnologia perché Pechino si trovi perennemente a rincorrere. Nel 2020 solo il 6 per cento dei microchip presenti nei prodotti tecnologici cinesi era di origine interamente nazionale: tutti gli altri erano stati importati o prodotti in Cina da ditte straniere.
Il primo obiettivo della controffensiva è di mantenere la Cina il più a lungo possibile dipendente dai microprocessori di provenienza estera, e di lavorare costantemente al potenziamento di tale tecnologia perché Pechino si trovi perennemente a rincorrere. Nel 2020 solo il 6 per cento dei microchip presenti nei prodotti tecnologici cinesi era di origine interamente nazionale: tutti gli altri erano stati importati o prodotti in Cina da ditte straniere.
Il governo cinese ha speso decine di miliardi di dollari negli ultimi due decenni per promuovere un’industria domestica dei microchip di livello mondiale, ma finora con scarsi risultati. L’amministrazione Biden vuole conservare questo stato di fatto, calcando le orme di Trump, che aveva convinto l’Olanda a non vendere alla Smic, la più grande produttrice cinese di microchip, le apparecchiature e la tecnologia per la lavorazione dei semiconduttori che avrebbe permesso alla Cina di produrre microprocessori all’avanguardia.
Attualmente a detenere il know-how in questo settore sono tre paesi: Stati Uniti, Giappone e Olanda; un’alleanza in funzione anticinese dovrebbe comprendere anche i produttori di microchip di Europa occidentale, Corea del Sud e Taiwan, e a quel punto si potrebbe immaginare anche di ri-localizzare le produzioni attualmente delocalizzate in Cina.
 Più difficile sarà limitare la crescente influenza cinese in altri campi. La campagna condotta da Trump contro la partecipazione di Huawei e di altre imprese cinesi allo sviluppo delle reti G5 ha ottenuto risultati limitati, che difficilmente Biden riuscirà ad ampliare: solo nel Regno Unito, in Australia, Svezia e Repubblica Ceca i cinesi sono stati tagliati fuori da aste e servizi relativi alla telefonia di quinta generazione, tutti gli altri paesi hanno tenuto aperta la porta a partecipazioni compatibili con la sicurezza nazionale e con quella dei dati degli utenti.
Più difficile sarà limitare la crescente influenza cinese in altri campi. La campagna condotta da Trump contro la partecipazione di Huawei e di altre imprese cinesi allo sviluppo delle reti G5 ha ottenuto risultati limitati, che difficilmente Biden riuscirà ad ampliare: solo nel Regno Unito, in Australia, Svezia e Repubblica Ceca i cinesi sono stati tagliati fuori da aste e servizi relativi alla telefonia di quinta generazione, tutti gli altri paesi hanno tenuto aperta la porta a partecipazioni compatibili con la sicurezza nazionale e con quella dei dati degli utenti.
I 75 miliardi di dollari di sconti fiscali, prestiti, sovvenzioni, condizioni di favore negli investimenti fondiari che lo Stato cinese ha riversato su Huawei, hanno permesso alla compagnia di conquistare vantaggi competitivi difficilmente recuperabili dai suoi principali concorrenti, finnici e sudcoreani.
Discorso simile vale per l’intelligenza artificiale: nel solo 2018 la Cina avrebbe speso per la ricerca e sviluppo in materia di intelligenza artificiale non-militare 5,7 miliardi di dollari contro 1 miliardo degli Stati Uniti; i ricercatori cinesi attualmente pubblicano più articoli sulle riviste scientifiche dei ricercatori americani.
Miniere di dati e di materie prime
Ma gli investimenti non sono l’unico motivo dell’ascesa cinese: un fattore decisivo è l’accesso a quantità inimmaginabili di dati. Pechino ha favorito la crescita di grandi imprese che raccolgono enormi quantità di informazioni sui loro utenti. Si pensi a giganti dell’e-commerce come Alibaba, a Tencent che ha sviluppato la app multiuso WeChat, a Baidu, secondo motore di ricerca al mondo, a Dji che domina il mercato dei droni in vendita ai privati, a SenseTime, che fornisce tecnologie per il riconoscimento facciale al sistema di videosorveglianza cinese e che è considerata l’azienda privata di intelligenza artificiale di maggior valore.
Tutte queste compagnie per legge devono collaborare con l’intelligence dello Stato. Le informazioni che raccolgono riguardano in misura crescente persone che vivono fuori dalla Cina. Le loro app, normalmente interconnesse, raccolgono dati di utenti stranieri riguardanti le loro finanze, le cronologie delle loro ricerche in internet, il luogo in cui si trovano, eccetera.
 L’altro fronte sul quale gli Stati Uniti sono determinati a combattere è quello delle terre rare, anche se finora l’unico alleato deciso ad assumersi impegni che hanno trovato è l’Australia, che subì un paio di anni fa un blocco temporaneo delle importazioni dalla Cina a causa di una controversia con Pechino. Nel 2020 la Cina ha segnato un altro record, estraendo 140 mila tonnellate di terre rare, il 6 per cento in più dell’anno prima.
L’altro fronte sul quale gli Stati Uniti sono determinati a combattere è quello delle terre rare, anche se finora l’unico alleato deciso ad assumersi impegni che hanno trovato è l’Australia, che subì un paio di anni fa un blocco temporaneo delle importazioni dalla Cina a causa di una controversia con Pechino. Nel 2020 la Cina ha segnato un altro record, estraendo 140 mila tonnellate di terre rare, il 6 per cento in più dell’anno prima.
Sotto la presidenza Trump il Pentagono ha investito 12,7 milioni di dollari nell’unica miniera per l’estrazione delle terre rare negli Stati Uniti, quella di Mountain Pass in California, per processare sul posto i minerali anziché inviarli ad impianti che si trovano in Cina.
Il 1° febbraio scorso altri 30 milioni di dollari del bilancio del Pentagono sono stati impegnati per la creazione di due siti per la lavorazione delle terre rare, uno per le leggere e uno per le pesanti, in una cittadina del Texas. A portare avanti il progetto sono l’americana Blue Line e l’australiana Lynas Rare Earths, la più grande impresa di estrazione e lavorazione di terre rare non cinese, operativa in Australia e in Malaysia. Quando gli impianti saranno realizzati, la compagnia australiana vanterà un quarto di tutto il mercato mondiale.
Il tiro mancino dell’Europa
 Sulle orme dell’amministrazione Trump, Biden si sta impegnando a rafforzare la cooperazione del cosiddetto Quad, il gruppo di paesi formato da Stati Uniti, Giappone, India e Australia inaugurato nel 2007 soprattutto per desiderio di Tokyo per il contenimento della Cina e subito andato in crisi.
Sulle orme dell’amministrazione Trump, Biden si sta impegnando a rafforzare la cooperazione del cosiddetto Quad, il gruppo di paesi formato da Stati Uniti, Giappone, India e Australia inaugurato nel 2007 soprattutto per desiderio di Tokyo per il contenimento della Cina e subito andato in crisi.
Con Trump presidente il Dialogo per la sicurezza quadrilaterale (questo il nome completo dell’organizzazione) ha ripreso a funzionare a pieno regime, con esercitazioni militari che gli hanno meritato l’appellativo di “Nato asiatica”. Biden vorrebbe farne anche un foro dove si prendono decisioni strategiche su questioni come i semiconduttori.
Più difficile sarà per gli americani coinvolgere nel fronte anticinese l’Unione Europea, che si è affrettata a firmare un accordo sugli investimenti con Pechino proprio nel momento del passaggio delle consegne da Trump a Biden. Accordo che Chris Patten, ultimo governatore britannico di Hong Kong ed ex commissario europeo, commentò così: «L’Unione Europea sputa in faccia ai diritti umani e mostra di avere una visione delirante dell’affidabilità in campo internazionale del Partito comunista cinese».





