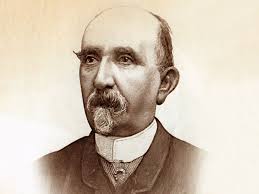Avvenire venerdì 28 settembre 1990
Il cardinale Giacomo Biffi ha commemorato l’autore dei celebre burattino a 100 anni dalla morte. E’ stata l’occasione per ritornare sulla crisi della società italiana all’indomani dell’unificazione nazionale
di Giacomo Biffi
«La nostra ipotesi è che questo prodigio letterario tra le sue premesse, se non la sua spiegazione esauriente nella crisi che colpisce la nazione italiana contestualmente al Risorgimento» questa convinzione è alla base della commemorazione di Carlo Collodi nel centenario della morte voluta ieri a Bologna dal Centro culturale «Enrico Manfredini», con il patrocinio della Fondazione nazionale Cario Collodi. «Pinocchio e la questione italiana» è appunto il tema della rievocazione fatta dall’arcivescovo di Bologna, il cardinale Giacomo Biffi. Il disagio sociale di Collodi nei primi anni dell’unità Italiana, ha spiegato Biffi, nascono dai miti dell’Illuminismo cui si era largamente ispirato il rivolgimento politico del nostro Paese. Della conferenza di Biffi pubblichiamo ampi stralci.
___________________
E’ certo che, una volta compiuta l’unità d’Italia, a poco a poco si insinua e si afferma nella sua coscienza una crisi che si fa col passar degli anni sempre più inquietante e severa. Egli non arriva mai a rinnegare gli ideali per i quali aveva anche pagato di persona; ma senza dubbio non è soddisfatto della forma in cui essi si sono inverati. Più seriamente e più radicalmente, non li ritiene più rispondenti alle aspirazioni più semplici ed essenziali dell’uomo. Non è soltanto deluso della meschinità e della scarsa attenzione sociale del nuovo Stato unitario; sono piuttosto gli stessi miti dell’illuminismo, cui si è largamente ispirato il rivolgimento politico della penisola, a non persuaderlo più. Come del resto non lo hanno mai persuaso i miti più recenti del socialismo nelle sue varie versioni, per le quali egli non nasconde la sua antipatia.
 Resta in lui un amore rabbioso per l’uomo e una infinita compassione per la sua varia miseria; ma non c’è più la fede in alcuna delle, ricette che in quei decenni si offrivano come rimedio miracoloso ai guai dell’umanità dolorante. Si mostra perfino scettico sul grande dogma illuministico dell’istruzione delle masse, che in quel tempo aveva ispirato la legge Coppino sull’istruzione obbligatoria. Non crede neppure più al tanto decantato «magistero della storia». «Chi crede oggi nella storia, dove non c’è di vero altro che le date, quando le date son vere? La storia, diciamolo una volta per tutte, è scritta unicamente per uso dei maestri di scuola, che non la sanno insegnare; e per disperazione degli scolari che non hanno voglia d’impararla».
Resta in lui un amore rabbioso per l’uomo e una infinita compassione per la sua varia miseria; ma non c’è più la fede in alcuna delle, ricette che in quei decenni si offrivano come rimedio miracoloso ai guai dell’umanità dolorante. Si mostra perfino scettico sul grande dogma illuministico dell’istruzione delle masse, che in quel tempo aveva ispirato la legge Coppino sull’istruzione obbligatoria. Non crede neppure più al tanto decantato «magistero della storia». «Chi crede oggi nella storia, dove non c’è di vero altro che le date, quando le date son vere? La storia, diciamolo una volta per tutte, è scritta unicamente per uso dei maestri di scuola, che non la sanno insegnare; e per disperazione degli scolari che non hanno voglia d’impararla».
Arriva a descrivere così i risultati della «rivoluzione illuministica»: «A furia di illuminazione, la religione è sparita, la superstizione e il beghinismo sono rimasti: l’istruzione è andata avanti a piè zoppo, la pretenzione e la presunzione hanno viaggiato col vapore». È, come si vede, una grande amarezza che lo turbava nell’intimo e lo rodeva. Anche esternamente questo suo malessere si lasciava percepire. Nota il nipote, Paolo Lorenzini «Non era più del suo umore di una volta, appariva chiuso, taciturno, malinconico, per quanto avesse sempre pronta la barzelletta e la facezia quando si animava un poco».
 In questo contesto, dopo gli anni avventurosi e un po’ selvaggi diventa significativo e quasi emblematico il suo ritorno in famiglia accanto alla madre, nel 1860. La madre morirà solo quattro anni prima del figlio, nel 1886, quando già il fatale burattino aveva cominciato la sua corsa nel mondo. In tutto quel tempo, l’influsso di Angiolina sul figlio è intenso e senza cadute. Sempre a testimonianza dei familiari, Carlo «non si coricò una sera senza chiederle un bacio e la sua benedizione… Spesso sottoponeva al giudizio di lei i suoi lavori, facendo tesoro dei consigli che si permetteva di dargli».
In questo contesto, dopo gli anni avventurosi e un po’ selvaggi diventa significativo e quasi emblematico il suo ritorno in famiglia accanto alla madre, nel 1860. La madre morirà solo quattro anni prima del figlio, nel 1886, quando già il fatale burattino aveva cominciato la sua corsa nel mondo. In tutto quel tempo, l’influsso di Angiolina sul figlio è intenso e senza cadute. Sempre a testimonianza dei familiari, Carlo «non si coricò una sera senza chiederle un bacio e la sua benedizione… Spesso sottoponeva al giudizio di lei i suoi lavori, facendo tesoro dei consigli che si permetteva di dargli».
Non si è tenuto finora nella dovuta considerazione, a mio giudizio, che la crisi ideologica e spirituale del Lorenzini è all’origine del suo capolavoro e può gettare una luce decisiva sull’enigma di un libro che è un vero e proprio «caso» nella storia della letteratura universale. Il «caso» — scriveva già qualche anno fa —nasce dalla sproporzione, almeno apparente, tra la modestia esteriore dell’opera e il suo successo, che è senza confini e senza eclissi Una storia cominciata senza un disegno compiuto, condotta avanti di malavoglia, pubblicata a puntate con scadenze irregolari, interrotta due volte, che riesce a imporsi all’attenzione di tutti, è tradotta in quasi tutte le lingue e provoca una serie senza fine di dotti studi e di disquisizioni sottili La nostra ipotesi è che questo prodigio letterario ha le sue premesse, se non la sua spiegazione esauriente, nella crisi che colpisce la nazione italiana contestualmente al Risorgimento.
 Perché questo prima di tutto bisogna capire bene: la crisi del Collodi non può essere ridotta a qualcosa di puramente intimo e personale, quasi a un fenomeno patologico soggettivo. Egli l’ha avvertita più acutamente di altri, ma essa era iscritta nella vicenda stessa del Risorgimento italiano. Nella sua componente politicamente vincitrice il movimento risorgimentale impose alle genti della penisola una ideologia obiettivamente in contrasto con quella cultura cattolica, che fino a quel momento aveva costituito praticamente l’anima e l’ispirazione di tutte le costumanze, le manifestazioni artistiche, le forme corali di festa, di culto della bellezza, di vita
Perché questo prima di tutto bisogna capire bene: la crisi del Collodi non può essere ridotta a qualcosa di puramente intimo e personale, quasi a un fenomeno patologico soggettivo. Egli l’ha avvertita più acutamente di altri, ma essa era iscritta nella vicenda stessa del Risorgimento italiano. Nella sua componente politicamente vincitrice il movimento risorgimentale impose alle genti della penisola una ideologia obiettivamente in contrasto con quella cultura cattolica, che fino a quel momento aveva costituito praticamente l’anima e l’ispirazione di tutte le costumanze, le manifestazioni artistiche, le forme corali di festa, di culto della bellezza, di vita
Tutto ciò che il popolo italiano percepiva come davvero suo o nasceva dalla visione cristiana o almeno ne era vigorosamente contrassegnato. Come era allora possibile che diventasse davvero popolare una unificazione e un rivolgimento compiuti senza giovarsi di questa forza spirituale antica e sempre viva, e anzi addirittura per molti aspetti in sua opposizione? Ci si illuse di poter far leva sul fascino della vetusta romanità. Ma il surrogato di questo mito — con tutta la sua fredda retorica, con tutti i suoi elmi di Scipio, i suoi labari e le sue coorti — non poteva toccare il cuore degli italiani tutt’al più riusciva a esaltare le nostalgie di qualche insegnante di latino e a infierire i versi di qualche vate classicheggiante.
Sotto questo profilo il fascismo può essere letto come prosecuzione, esasperazione e dissolvimento di questo tentativo senza speranza di dare una radice storica e una patente di nobiltà a un’ideologia recente ed estranea.
 A differenza dell’Irlanda e della Polonia l’Italia non ha saputo trovare nel suo originale cattolicesimo il principio di identità nazionale; principio che era del tutto illusorio pensare di trovare altrove. Perciò la nostra identità nazionale rimane, dopo l’unità, un problema che non appare mai del tutto risolto. Va detto che la nostra storiografia non è stata a questo proposito particolarmente perspicace. Ha studiato si nelle loro manifestazioni di vertice, le molteplici tensioni tra la Chiesa e lo Stato sabaudo, ma non ha mai prestato sufficiente attenzione alla grande e vitale realtà del cattolicesimo popolare, fino a che non è stata costretta ad occuparsene dai risultati delle elezioni di questo secondo dopo guerra, le prime veramente libere e universali. Ed è naturale che tali risultati siano apparsi una sorpresa, quando non addirittura una prevaricazione, agli occhi di chi non aveva mai voluto prendere in considerazione la realtà italiana nella sua intera verità.
A differenza dell’Irlanda e della Polonia l’Italia non ha saputo trovare nel suo originale cattolicesimo il principio di identità nazionale; principio che era del tutto illusorio pensare di trovare altrove. Perciò la nostra identità nazionale rimane, dopo l’unità, un problema che non appare mai del tutto risolto. Va detto che la nostra storiografia non è stata a questo proposito particolarmente perspicace. Ha studiato si nelle loro manifestazioni di vertice, le molteplici tensioni tra la Chiesa e lo Stato sabaudo, ma non ha mai prestato sufficiente attenzione alla grande e vitale realtà del cattolicesimo popolare, fino a che non è stata costretta ad occuparsene dai risultati delle elezioni di questo secondo dopo guerra, le prime veramente libere e universali. Ed è naturale che tali risultati siano apparsi una sorpresa, quando non addirittura una prevaricazione, agli occhi di chi non aveva mai voluto prendere in considerazione la realtà italiana nella sua intera verità.
Ma ciò che non è stato finora studiato da nessuno è il malessere spirituale profondo, soggiacente al dramma degli accadimenti politici che ha colpito le genti italiane durante tutta la vicenda risorgimentale e pos-risorgimentale. Eppure questo malessere è un fatto, e un fatto gravido di persistenti conseguenze. Non si trascura impunemente, talvolta addirittura irridendolo, il patrimonio di convinzioni ereditato dai padri, custodito nelle grandi opere che fanno belle le nostre città, sotteso a tutte le nostre antiche istituzioni sociali (come le università, gli ospedali le «misericordie», i monti di pegno, le confraternite ecc.).
 L’anima d’Italia ne è rimasta ferita, e molti dei nostri guai nazionali trovano qui una delle cause decisive. Privato dalla cultura ufficiale di una sicura e tradizionalmente accettata scala di valori, il nostro popolo dà spesso l’impressione di essere senza convinzioni e indifferente di fronte ai doveri verso la collettività. Esautorata dal pubblico potere la norma secolare cattolica di comportamento, anche le leggi civili faticano a essere percepiti dagli italiani come vincolanti Scosse nella loro appartenenza ecclesiale, le genti italiane sono andate mendicando altre appartenenze totalizzanti; sicché in questa stessa crisi spirituale ottocentesca può forse trovare qualche spiegazione sia l’infatuazione fascista sia l’anomalia storica del successo tra noi dell’ideologia comunista senza riscontro nel mondo libero ed evoluto.
L’anima d’Italia ne è rimasta ferita, e molti dei nostri guai nazionali trovano qui una delle cause decisive. Privato dalla cultura ufficiale di una sicura e tradizionalmente accettata scala di valori, il nostro popolo dà spesso l’impressione di essere senza convinzioni e indifferente di fronte ai doveri verso la collettività. Esautorata dal pubblico potere la norma secolare cattolica di comportamento, anche le leggi civili faticano a essere percepiti dagli italiani come vincolanti Scosse nella loro appartenenza ecclesiale, le genti italiane sono andate mendicando altre appartenenze totalizzanti; sicché in questa stessa crisi spirituale ottocentesca può forse trovare qualche spiegazione sia l’infatuazione fascista sia l’anomalia storica del successo tra noi dell’ideologia comunista senza riscontro nel mondo libero ed evoluto.
Sarebbe inutile dire se la ragionevolezza avesse più ampia cittadinanza in questo mondo, che riflessioni come la nostra non vogliono affetto né rimettere in discussione l’unità nazionale (che è irreversibile e ci è cara) né rimpiangere il potere temporale (la cui fine è stata provvidenziale per la Chiesa). Si tratta solo di accostarsi a una pagina della nostra storia — che è tra le più decisive se non tra le più splendenti — senza schematismi ideologici e senza esaltazioni acritiche, indegne di uno spirito davvero libero e davvero spregiudicato.
 Anche se non percepita o addirittura censurata dalla cultura ufficiale, la tragedia di un popolo, che, all’atto di connettersi politicamente, spiritualmente si lacera e si immiserisce, non è passata del tutto inosservata negli anni in cui si andava consumando. Perfino nella lontana Russia c’è chi dimostra di rendersene conto, almeno per qualche aspetto. Dostoevskij nel 1877 pare avvedersi a suo modo di questo deterioramento, quando scrive, «Il popolo italiano si sente depositario di un’idea universale e chi non lo sa lo intuisce. La scienza, l’arte italiana sono piene di quell’idea grande. Ebbene, che cosa ha ottenuto il conte di Cavour? Un piccolo regno di secondo ordine, che non ha importanza mondiale, senza ambizioni, imborghesito».
Anche se non percepita o addirittura censurata dalla cultura ufficiale, la tragedia di un popolo, che, all’atto di connettersi politicamente, spiritualmente si lacera e si immiserisce, non è passata del tutto inosservata negli anni in cui si andava consumando. Perfino nella lontana Russia c’è chi dimostra di rendersene conto, almeno per qualche aspetto. Dostoevskij nel 1877 pare avvedersi a suo modo di questo deterioramento, quando scrive, «Il popolo italiano si sente depositario di un’idea universale e chi non lo sa lo intuisce. La scienza, l’arte italiana sono piene di quell’idea grande. Ebbene, che cosa ha ottenuto il conte di Cavour? Un piccolo regno di secondo ordine, che non ha importanza mondiale, senza ambizioni, imborghesito».
Ma qualche momento di lucidità c’è anche in alcuni di quelli che erano stati attivi nel processo risorgimentale. Nei «Pensieri» di Francesco Crispi — chi lo crederebbe? — a un certo punto si legge: «Il Cattolicesimo, oltre la potente e mirabile gerarchia, che tiene stretto i fedeli intorno al capo, ha, ai fini della sua missione, l’educazione, l’insegnamento, la beneficenza, l’apostolato. Che abbiamo noi fatto, in 34 anni, nel Regno d’Italia, per fare i cittadini e soldati, uomini e patrioti?».
 E Ferdinando Martini scriveva al Carducci– «Le rivoluzioni politiche le quali non accompagnino un rinnovamento religioso perdono di vista l’origine loro, e i primi intenti finiscono a scatenare ogni istinto delle plebi di ciò io sono convinto da un pezzo. Ma dopo il male che noi, tutti noi tutti noi caro Giosuè, abbiam fatto, siamo in grado di provvedere a rimedi? A chi predichiamo? Noi borghesia volteriana, siam noi che abbiamo fatto i miscredenti, intanto che il Papa custodisce i male credenti ora alle plebi che chiedono le parole cui affidarsi perché non credono più all’ai di là, torneranno fuori a parlare di Dio, che ieri abbiamo negato! Non ci prestano fede: parlo delle plebi di città e de’ borghi le rurali di un Dio senza riti, senza preti, non sanno che farsi A tutto il male che noi (non tu od io, noi certo) abbiamo fatto per spensierata superbia, le bombe son troppo scarso compenso: abbiam voluto distruggere e non abbiamo saputo nulla edificare. La scuola doveva, nelle chiacchiere dei pedagoghi sostituire la Chiesa. Una bella sostituzione! Te la raccomando…».
E Ferdinando Martini scriveva al Carducci– «Le rivoluzioni politiche le quali non accompagnino un rinnovamento religioso perdono di vista l’origine loro, e i primi intenti finiscono a scatenare ogni istinto delle plebi di ciò io sono convinto da un pezzo. Ma dopo il male che noi, tutti noi tutti noi caro Giosuè, abbiam fatto, siamo in grado di provvedere a rimedi? A chi predichiamo? Noi borghesia volteriana, siam noi che abbiamo fatto i miscredenti, intanto che il Papa custodisce i male credenti ora alle plebi che chiedono le parole cui affidarsi perché non credono più all’ai di là, torneranno fuori a parlare di Dio, che ieri abbiamo negato! Non ci prestano fede: parlo delle plebi di città e de’ borghi le rurali di un Dio senza riti, senza preti, non sanno che farsi A tutto il male che noi (non tu od io, noi certo) abbiamo fatto per spensierata superbia, le bombe son troppo scarso compenso: abbiam voluto distruggere e non abbiamo saputo nulla edificare. La scuola doveva, nelle chiacchiere dei pedagoghi sostituire la Chiesa. Una bella sostituzione! Te la raccomando…».
Con la stessa amarezza il Collodi negli anni della sua «crisi», si rivolge ai dirigenti della nuova Italia: «Voi credendo in buona fede di ragionare, avete sragionato così: per rigenerare i popoli. Bisogna istruirli bisogna emanciparli dall’ignoranza: in una parola bisogna illuminare le masse! Illuminiamo dunque le masse… Con qual profitto?».
Come supera il Lorenzini questa sua crisi di uomo, di cittadino, di osservatore attento dei mai sociali? Da pubblicista, animatore e collaboratore di vari giornali si era rivolto soprattutto alla classe di quelli che contano, a quanti erano occupati nell’azione politica Ma a un certo punto il suo pessimismo — o meglio il pessimismo del suo realismo — lo persuade dell’inutilità di questo impegno. Egli decide allora di cambiare destinatari e di spendere le sue fatiche non più per gli adulti, non più per i personaggi importanti sì sulla scena pubblica ma ormai ideologicamente fissati e sclerotizzati senza rimedio, per i ragazzi che possiedono un’umanità ancora nativamente fresca e aperta alla verità.
 Il passaggio si colloca nel 1875, nel suo quarantanovesimo anno di età, quando, su richiesta dei librai-editori Alessandro e Felice Poggi appronta una nuova versione dei famosi «Contes» di Charles Perrault che difatti compaiono lo stesso anno col titolo italiano «I racconti delle fate». Dopo questa pubblicazione si dedicherà totalmente alla così detta letteratura infantile, nella quale si produrrà non più con traduzioni ma con apprezzate opere originali.
Il passaggio si colloca nel 1875, nel suo quarantanovesimo anno di età, quando, su richiesta dei librai-editori Alessandro e Felice Poggi appronta una nuova versione dei famosi «Contes» di Charles Perrault che difatti compaiono lo stesso anno col titolo italiano «I racconti delle fate». Dopo questa pubblicazione si dedicherà totalmente alla così detta letteratura infantile, nella quale si produrrà non più con traduzioni ma con apprezzate opere originali.
Giuseppe Decollanz ha colto bene il significato di questa «svolta» collodiana: «La creazione artistica —scrive — è il suo rifugio politico… è la sua reazione all’illiberalità della politica contemporanea, in nome di un più alto ideale di umanità e di democrazia… Ed è al tempo stesso la presa di coscienza di un uomo che aveva finalmente risolto i propri dissidi spirituali, le proprie ansie, isolandosi nella contemplazione di un mondo disincantato e al tempo stesso così fortemente allegorico, qual è appunto quella della favola»
Tutto ciò è molto giusto e vale per tutta la produzione collodiana degli ultimi quindici anni di vita, ma non è sufficiente a darci piena ragione di «Pinocchio» e del suo fascino misterioso.