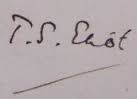Strumenti culturali di Litterae Communionis n.6
I GRANDI DELLA CULTURA MODERNA RIVISITATI
«Senza indugio, senza fretta / Costruiremo il principio e la fine della strada / Ne costruiamo il senso: / Una chiesa per tutti / E un mestiere per ciascuno / Ognuno al suo lavoro»
Testo di Giancarlo Gioielli
La sua vita
«E noi viviamo, noi respiriamo soltanto se bruciamo e bruciamo».
S. Eliot. Si diceva classico, anglocattolico, monarchico. Si diceva discepolo di Ezra Pound, «il miglior fabbro» Ezra Pound il fascista, Ezra Pound il traditore, Ezra Pound il pazzo. Ezra visse, e pagò, tutte le tensioni del suo tempo. Si immerse nel caos delle parole e delle idee. Scelse, rischiò, anche troppo per un poeta. Il suo tempo lo condannò e anche allora Ezra accettò il martirio evocato dalle sue stesse parole. Lo accettò e pagò i suoi errori con la stessa dignità e con lo stesso orrore per la scelta facile, liberatoria, con cui aveva sbagliato.
La vita di Eliot fu molto diversa da quella di chi aveva scelto come suo maestro: un «poeta da università» fu definito, e la definizione per noi abituati a rigettare ciò che sa di accademico, di formale, di erudito vuoto di ogni tensione vitale e morale, suona denigratoria. Strana concezione questa che rigetta l’ateneo nel campo del Freddo, del Vacuo e che paga al nostro tempo lo scotto di una cultura separata dalla vita, di una non-cultura quindi, di cui l’università sarebbe, ed è, la somma, la sintesi e il motore.
Eppure Eliot fu poeta di università, se la sua vita si svolse tra Harvard è Oxford, se esami, lauree e seminari eliotiani la fanno da padrone nelle facoltà di letteratura inglese. Eppure nessuno oserebbe affermare proprio in Eliot mancanza di senso e di tensione morale, se, al contrario, tutta la sua opera emerge impregnata, assillata dalla coscienza dell’Assoluto. Se persino il disordine che lo preme ai fianchi è sentito e avvertito come mancanza di ordine, di significato, e quindi visto e conosciuto solo in rapporto a ciò che Resta, a ciò che è Stabile, alla Rocca, infine.
Ed è questa tensione che vogliamo rintracciare, riscoprire; per questa tensione, per questa coscienza della Presenza come unica e vera cosa tallonante la cultura, la civiltà e, soprattutto, la vita che lo abbiamo cercato e scelto per il nostro itinerario.
* * *
 26 settembre 1888: a St. Luis nel Missouri nasce Thomas Stearns Eliot. Religione, cultura, orgoglio aristocratico per la propria origine anglosassone si distillano nel giovane: nel suo albero genealogico vi sono i primi coloni che da un piccolo villaggio del Somerset, in Gran Bretagna, si trasferirono nel 1670 nel Massachusetts, dove tentarono l’avventura del Nuovo Mondo recando la risentita moralità inglese come bagaglio. Solidi mercanti, studiosi, vescovi. Di Henry Eliot e Charlotte Chauncy Stearns, Thomas fu il settimo e ultimo figlio. Respirò nell’aria della famiglia la passione per l’arte, per la cultura, ma soprattutto per l’Inghilterra.
26 settembre 1888: a St. Luis nel Missouri nasce Thomas Stearns Eliot. Religione, cultura, orgoglio aristocratico per la propria origine anglosassone si distillano nel giovane: nel suo albero genealogico vi sono i primi coloni che da un piccolo villaggio del Somerset, in Gran Bretagna, si trasferirono nel 1670 nel Massachusetts, dove tentarono l’avventura del Nuovo Mondo recando la risentita moralità inglese come bagaglio. Solidi mercanti, studiosi, vescovi. Di Henry Eliot e Charlotte Chauncy Stearns, Thomas fu il settimo e ultimo figlio. Respirò nell’aria della famiglia la passione per l’arte, per la cultura, ma soprattutto per l’Inghilterra.
Quando andò a studiare ad Harvard (la prestigiosa università di cui duecento e più anni prima un suo antenato aveva rifiutato la carica di preside per non abbandonare la piccola comunità religiosa che da lui, vescovo, dipendeva), i compagni di studi lo definivano «inglese per tutto e in tutto, tranne che per l’accento e per la nazionalità» ma qualche anno più tardi conquisterà entrambi. Ad Harvard legge Longfellow e Charles Eliot Norton, assiste alle lezioni di Santayana e Babbitt. Erano gli anni del « secondo rinascimento americano» ed Harvard ne era la musa. Qui conosce Donne e i poeti metafisici del ‘600, ma soprattutto legge, frequenta, studia, ama Dante.
«La tradizione è cosa di significato molto più ampio: essa non può venire acquistata in eredità; se la volete possedere dovete conquistarla con grande fatica» scriverà poi, e questi sono gli anni dove alla confluenza delle due civiltà, inglese e americana, si forma in lui quel senso storico «che si può considerare come strettamente indispensabile a chiunque voglia continuare a fare poesia dopo i venticinque anni», quel senso storico che «implica non solo la intuizione dell’esser passato del passato, ma anche quella della sua presenza; il senso storico costringe l’uomo non solamente a scrivere con la propria generazione nelle sue ceneri, ma con il sentimento che tutta la letteratura d’Europa, dopo Omero, e con essa tutta la letteratura del nostro paese, ha una simultanea esistenza e forma un ordine simultaneo».
Fu allora forse che concepì la poesia «come unità vivente di tutte le poesie che sono state scritte». È di questi anni infine la lettura di due libri fondamentali: II movimento simbolista in letteratura di Arthur Symons e Spirito della letteratura romanza di Ezra Pound che gli spalanca il mondo della Provenza, dei suoi trobadori e degli stilnovisti italiani.
Poeta di università, lo definimmo principiando queste pagine, e tra le università troviamo scandita la sua parabola poetica ed umana. Dopo Harvard è la Sorbona, Parigi. È il 1910, negli atenei del quartiere latino insegna Henri Bergson. Per un anno Eliot ne segue le lezioni, studia lettere e filosofia, approfondisce gli studi sul simbolismo francese. Dopo un anno torna ad Harvard. Metafisica, logica, psicologia insieme all’Indi e al Sanscrito sono le materie che attirano i suoi interessi. Fino al 1914 vi insegnerà filosofia.
 Alla vigilia della prima guerra mondiale si trasferisce in Gran Bretagna: è ancora una università ad accoglierlo, la più prestigiosa nel mondo britannico, Oxford. Collabora a riviste letterarie, insegna come dice lui stesso «francese, latino, aritmetica, nuoto, geografia, storia, pallacanestro». Compaiono ora le sue poesie prima sulle riviste letterarie più qualificate, poi in volume. Si tratta del Canto di amore di J. Alfred Prufrock che viene ospitato anche sul «Catholic Anthology» diretto da Ezra Pound. Insieme ad altre «osservazioni» vedrà la luce in un volume nel 1917. È dello stesso anno il primo libro di critica sull’amico Ezra Pound.
Alla vigilia della prima guerra mondiale si trasferisce in Gran Bretagna: è ancora una università ad accoglierlo, la più prestigiosa nel mondo britannico, Oxford. Collabora a riviste letterarie, insegna come dice lui stesso «francese, latino, aritmetica, nuoto, geografia, storia, pallacanestro». Compaiono ora le sue poesie prima sulle riviste letterarie più qualificate, poi in volume. Si tratta del Canto di amore di J. Alfred Prufrock che viene ospitato anche sul «Catholic Anthology» diretto da Ezra Pound. Insieme ad altre «osservazioni» vedrà la luce in un volume nel 1917. È dello stesso anno il primo libro di critica sull’amico Ezra Pound.
Il 1918 è l’anno in cui Thomas abbandona l’insegnamento, vuole arruolarsi nella marina americana ma viene riformato, trova un impiego nella banca Lloyds. Intanto le sue poesie iniziano a circolare, le notano Leonard e Virginia Woolf che ne curano una edizione su carta a mano per la Hogarth Press. Dirige «The Egoist», un giornale di critica, letteratura e poesia che, nato sull’onda del nascente femminismo, era stato trasformato da Ezra Pound nel portavoce di una nuova poetica aperta a suggestioni orientali, «gaia, secca, sofisticata».
Il 1922 vede la nascita di «Criterion» un periodico letterario che Eliot dirigerà fino alla vigilia della seconda guerra mondiale. L’importanza di «Criterion» crescerà sempre più sia per quanto riguarda l’evoluzione della poetica di Eliot, sia per il ruolo che assumerà nella letteratura inglese del primo “novecento. Sarà il primo periodico anglosassone ad aprire le porte a suggestioni letterarie di respiro europeo ospitando Proust, Valery, Rivière, Maurras. Sarà qui che vedrà la luce The Waste Lana, la Terra desolata, nel ’22. La prima stesura era dell’anno precedente, quando Eliot fu costretto ad un periodo di riposo in Svizzera.
Parleremo dopo, e più ampiamente di questa opera che fu limata a Parigi da Pound. Da questo momento la sua produzione, il suo dettato saranno sempre più assillati, premuti dalla abissale proporzione che si apre tra il Destino, l’Ordine, il Senso e il mondo che finisce, «non con uno schianto ma con un piagnisteo», come scriverà nel ’25 in The Hollow Man, gli Uomini Vuoti. Affronta il campo dell’editoria e a lui va il merito di aver indirizzato la casa editrice Faber e Gywer verso quell’impulso attualissimo e moderno che per decenni conserverà.
Anno per anno, si sgranano uno dopo l’altro Il viaggio dei magi, (’27), Il canto di Simeone (’28), Animula (’29); Marina (’30). Sono gli Ariel Poems, ricchi di echi danteschi che si accentuano nel Mercoledì delle ceneri, che chiude il decennio ’20-30 consacrando la fama di poeta e la carriera universitaria di Eliot, che culminano con le lezioni di Harvard dove è chiamato ad occupare la cattedra di Charles Eliot Norton, di fronte a quei banchi che lo videro studente. Sono gli anni dei «té evasivi», come li chiamerà poi, quando in ossequio alla consuetudine degli atenei americani doveva ricevere gli studenti che «fissavano estasiati il poeta taciturno che mangiava la torta».
Ma si annuncia la stagione teatrale di Eliot. La parola stilnovistica, ricca di dotte e ardite densità, tende a farsi partecipata, corale. Cerca uno spazio, e lo trova, nel teatro. Ed è subito forma drammatica e poetica, partecipazione sì, ma altrettanto densa e carica della pregnanza della parola poetica, altrettanto ricca di echi, altrettanto critica.
 Nel ’32 aveva già scritto un dramma Sweeney agonista o meglio «un melodramma aristofanesco», per dirla con lui. Nel ’34 è la Rocca, la «straniera, la visitata da Dio». Un anno dopo vede la luce Assassinio nella Cattedrale. È forse il vertice del dramma religioso eliotiano. Verrà via via modificato nel ’36, nel ’37 e nel ’38. Nel 1951 diventerà una pellicola cinematografica. Tra il ’41 e il ’43 escono i Quattro quartetti. Nascono intanto opere di studio e di critica letteraria, nonché riflessioni, conferenze e discorsi pubblici: Saggi elisabettiani, L’idea di una società cristiana, La musica della poesia. Nel ’47 muore sua moglie Vivien Haigh-Wood; l’anno dopo, l’anno in cui pubblica le Note per una definizione della cultura, vince il Nobel per la letteratura.
Nel ’32 aveva già scritto un dramma Sweeney agonista o meglio «un melodramma aristofanesco», per dirla con lui. Nel ’34 è la Rocca, la «straniera, la visitata da Dio». Un anno dopo vede la luce Assassinio nella Cattedrale. È forse il vertice del dramma religioso eliotiano. Verrà via via modificato nel ’36, nel ’37 e nel ’38. Nel 1951 diventerà una pellicola cinematografica. Tra il ’41 e il ’43 escono i Quattro quartetti. Nascono intanto opere di studio e di critica letteraria, nonché riflessioni, conferenze e discorsi pubblici: Saggi elisabettiani, L’idea di una società cristiana, La musica della poesia. Nel ’47 muore sua moglie Vivien Haigh-Wood; l’anno dopo, l’anno in cui pubblica le Note per una definizione della cultura, vince il Nobel per la letteratura.
La stagione teatrale, che era ripresa nel ’39 con Riunione di famiglia, continua negli anni ’50 con Cocktail party (’50), L’impiegato di fiducia (’53) e L’anziano statista (’59). Nel ’54 vince il premio Goethe. Nel ’57 sposa la sua segretaria Valerie Fletcher. Continua la sua opera di direttore letterario della Faber e Faber, la ex Faber e Gywer, tiene conferenze e prepara trasmissioni radio per la Bbc. Muore il 4 gennaio del 1965.
La sua opera
«Disserrate le porte! aprite le porte!».
«Sembra nella natura delle cose — scrive Eliot — che i poeti del nostro stadio di civiltà debbano essere difficili. La nostra civiltà ha aspetti assai vari e complessi… e il poeta deve diventare sempre più capace di sintesi, più allusivo, più indiretto, così da poter sforzare, slogare se è necessario, il linguaggio, in vista del significato che cerca». Ed è un fatto che ogni poesia, oserei dire ogni verso, si colloca alla confluenza di una tal serie di riferimenti, allusioni, sintesi da renderlo spesso talmente denso, che la stessa opacità diventa ostacolo alla comprensione. Ma la difficoltà del « leggere Eliot » è, forse, spostata, diversa, rispetto a quella cui ci ha abituato tanta poesia contemporanea.
La «Foresta di simboli» eliotiana non tende a creare uno spazio di suggestione, di fascinazione che promana dalla parola e nel cui solco si colloca l’intuizione, l’aggancio con il lettore che di questa fascinazione si fa complice ancor prima che interprete. I «sacri sigilli» eliotiani sono di natura diversa dai decadenti scrigni. La fatica è estetica, sì, ma contemporaneamente intellettuale, (là dove per intellettuale si intenda la fatica di una lettura intelligente pronta a cogliere il particolare e la ricchezza dell’ingrediente, ma tesa alla luce di un significativo sintetico, unitario, che di questo particolare, di questo ingrediente, fa chiave, segno e cifra).
Lettura intellettuale dunque, ma non intellettualistica. Oseremmo dire lettura di «fede», se non si temesse d’essere letti anche qui in modo distorto e quindi falsato. Ma intelligenza di fede come capacità di cogliere una parabola umana nel suo tendere al senso, al Verbo, e poi di questo farsi lampada, scrigno. Allora sì: sia intelligenza di «fede», dunque, perché «di fede» è la tensione, la spada che trapassa, che giudica e che condanna. È lotta questa, poetica; carica di personale assunzione, dunque, di volontario rischio. E sarà lotta drammatica perché nel teatro, non sappiamo in verità quanto, la realtà di questo agone vorrà diventare coro.
Ripercorriamo dunque il cammino di Eliot, questa volta attraverso la sua stessa voce. Salteremo, per forza di cose, e pur scusandoci per lo scarso rigore filosofico, le prime poesie, scritte tra l’inverno e la primavera del ’10, tra il sedicesimo e il ventiduesimo compleanno del poeta. Interessa tuttavia di questo periodo quel senso dell’ironia, quell’addensarsi già di ricordi e citazioni implicite, e soprattutto quel senso del presente che attira a sé passato e futuro, il tempo come meta-storia insomma, che più avanti troverà ben altri sviluppi. («Se tempo e spazio come i saggi dicono, sono cose che mai potranno esistere »).
O quella sensazione che fa della vita sempre e comunque una scelta, una tensione assoluta, fino a sfiorare l’ombra di una retorica in cui forse leggiamo più ironia di quanta effettivamente sia lecito reperire («Ritti presso la sponda che tutti conosciamo per un momento esitiamo dubbiosi, poi con un canto sulle labbra salpiamo… ». Al momento di ottenere il diploma: 1905).
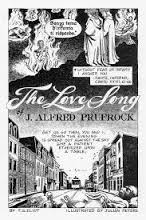 La prima composizione che segnala la statura poetica di Eliot all’attenzione della critica è il Canto di amore di J. Alfred Prufrock, cui premessa è una citazione di sapore dantesco, e tanto piacque ad Ezra Pound che oltre ad ospitarla sul suo «Catholic Anthology» ne scrisse: «Dopo tanto lavoro contemporaneo che è meramente artificiale, e tanto che è valido nelle intenzioni, ma per impotenza incompiuto e incompleto, e tante opere i cui difetti sono dovuti a pura ignoranza, cui un anno di studio avrebbe potuto rimediare, è un conforto incontrare un’opera d’arte compiuta; spontanea, malgrado la sua sottigliezza intellettuale, e priva di ogni pretesa ».
La prima composizione che segnala la statura poetica di Eliot all’attenzione della critica è il Canto di amore di J. Alfred Prufrock, cui premessa è una citazione di sapore dantesco, e tanto piacque ad Ezra Pound che oltre ad ospitarla sul suo «Catholic Anthology» ne scrisse: «Dopo tanto lavoro contemporaneo che è meramente artificiale, e tanto che è valido nelle intenzioni, ma per impotenza incompiuto e incompleto, e tante opere i cui difetti sono dovuti a pura ignoranza, cui un anno di studio avrebbe potuto rimediare, è un conforto incontrare un’opera d’arte compiuta; spontanea, malgrado la sua sottigliezza intellettuale, e priva di ogni pretesa ».
Di ironia si è parlato, e ironici sono i suoi versi, o meglio, ironico è il meccanismo che affronta e fa scattare immagini di vita quotidiana, che assumono però il sapore di immagini mitiche, e poi simboliche, comunque al di là del tempo; dentro e fuori la quotidianità da cui sono tratte.
«Divento vecchio, divento vecchio… Porterò i pantaloni arrotolati in fondo. Dividerò i capelli sulla nuca? Avrò il coraggio di mangiare una pesca? Porterò pantaloni di flanella bianca, e camminerò sulla spiaggia. Ho udito le sirene cantare l’una all’altra. Non credo che canteranno per me. Le ho viste al largo cavalcare l’onde, pettinare le candide chiome dell’onde risospinte quando il vento rigonfia l’acque bianche e nere. Ci siamo troppo attardati nelle camere del mare con le figlie del mare incoronate d’alghe rosse e brune finché le voci umane si svegliano e anneghiamo».
Questo è Prufrock ma le sue domande non sono da Principe Amleto, «né era destinato ad esserlo. Io sono un cortigiano, sono uno utile forse ad ingrassare il corteo, a dar l’avvio a una scena o due, ad avvisare il principe: uno strumento facile di certo, deferente, felice di mostrarsi utile, prudente, cauto, meticoloso; pieno di nobili sentenze, un po’ ottuso, talvolta in verità quasi ridicolo e qualche volta, quasi, il Buffone».
Prufrock conosce i desideri e la vigliaccheria paralizzante, ma nemmeno nel mare ha la forza di essere protagonista («quasi», «talvolta »), o di «essere», comunque e semplicemente. Come il fatto che apre la poesia e le sirene che la chiudono lancia la sua voce come un desiderio costante di agire, di turbare l’ordine placido e infingardo; ma è il solo pensiero di questo turbamento, fin nel minimo, che lo paralizza. («Oserò turbare l’universo?)». Il cambiamento non può avvenire, il solo pensiero, la sola ipotesi sconvolgerebbe quell’inattivo equilibrio raggiunto con la pura passività. Passività di domande, sia ben chiaro, prima ancora che di azione; passività di scelta, e quindi di vita. Tanto «ci sarà tempo ».
Il contrario, dunque, di una vita eroica, affrontata nel coraggio della decisione, della scelta quotidiana. La rinuncia non è, non può essere per Prufrock gesto voluto di libera scelta, ma è la non scelta, la paralisi di chi si attarda ad «ascoltare le figlie del mare nelle camere del mare». Canteranno al largo queste, ma non per lui. E intanto «ci sarà tempo». «Tempo per te e tempo per me / e tempo anche per cento indecisioni / e per cento visioni e revisioni / prima di prendere un té con il pane abbrustolito». La crisi del valore è totale perché comparata ad un’unica costante relativa. Non c’è tempo e quindi storia, ma solo un’unica, immensa non-storia, un unico immenso non-avvenimento.
Come nella terra desolata o nella aridità degli uomini vuoti, gli uomini impagliati che appoggiano l’un l’altro la testa piena di paglia. Una vita di cui aveva parlato nelle poesie più giovani «essere calvo e un po’ grigio, languido fastidioso floscio, attende, con il cappello e con i guanti in mano, tutto a puntino in abito e cravatta (soltanto un po’ seccato del ritardo) sulla soglia dell’Assoluto». La poesia, non a caso di certo, si chiamò Spleen.
La stessa indolenza che accompagna il Ritratto di signora fin dalla citazione che apre la pagina: « Hai fornicato / Ma fu in un altro paese e oltre tutto la ragazza è morta». Una poesia cullata sul ritmo di Chopin, tra té e lillà in «un’estasi di tabacco», in cui si insinua una «nota falsa», un «tam tam sordo che assurdamente martella il suo preludio», ma la musica, e il fumo che scende già dai tetti «trova il suo tono giusto con un morendo».
Strane tracce lasciano di sé queste presenze, che pure nel vuoto sono martellate da una domanda. Come Prufrock o il paradossale Mr. Apollinax fanno parte di una cultura, di una coscienza che non riusciamo a scrollarci di dosso, attorniati da fumose ombre che lasciano dietro sé un fumo e un’ombra ancor più flebile, dissolvente. La vedova Phlaccus, il Professore e la Signora Cheetah, in cui resta solo il ricordo di «uno spicchio di limone» e di «un amaretto mordicchiato».
E come Prufrock si imponeva nella prima raccolta di poesie, nel ’17, un altro personaggio compare a far da guida nella raccolta del ’20. Gerontion è un «vecchio, la testa intronata fra spazi di vento», un vecchio, infine, «sospinto dagli alisei in un angolo dì sonno»: la sua «casa in affitto»; nemmeno Gerontion ha combattuto «agitando una daga e morso dalle mosche» la sua «è una casa in rovina», non ha lottato «nella calda pioggia» «col ginocchio affondato dentro paludi salmastre».
Sogna, e i sogni sono presi per miracoli. «Vogliamo vedere un segno», grida. «Dacci un segno» aveva gridato qualcuno mille e mille anni prima, e il grido risuona nella sua mente ventosa. «La parola in una parola, fasciata di tenebra». Il Verbo. «Cristo la tigre».
Per Gerontion la storia gli ha donato «troppo tardi ciò in cui più non si crede o, se ancora ci crediamo, soltanto nel ricordo come passioni riconsiderate». Eppure la «tigre balza nell’anno nuovo. Ci divora». Gerontion vive la coscienza di ciò che è, ma irrigidito in una «casa in affìtto» è come «se non potesse più essere».
Ha perso. «Ho perso la bellezza nel terrore, il terrore nella ricerca. Ho perduto la mia passione: perché dovrei conservarla se ciò che si conserva si contamina? Ho perduto la vista e l’odorato, l’udito, il gusto e il tatto: come li potrò usare per esserti più accanto?».
E ancora in queste poesie gioca il meccanismo dell’ironia, ma se prima funzionava ingrandendo a dismisura e privilegiando gli atti banali e meschini di Prufrock, ora rimpicciolisce e degrada quanto tradizionalmente è rappresentato in maniera sublime e aulica: «L’ombra allungata di un uomo è storia disse Emerson, che non aveva visto la silouette di Sweeney a gambe larghe al sole», «dove sono le aquile e le trombe? Sepolti in mondi di profonda neve. Su focaccine imburrate e su croccanti piangono moltitudini che si struggono in centinaia di ristoranti A.B.C. ».
 Gerontion e Prufrock, dunque, come figure paradossali di una enigmatica condizione di vita. Ma preme alle porte un poemetto che intere generazioni prenderanno a simbolo di sé: La Terra desolata. Fu concepito durante un viaggio in Provenza e steso quasi di getto a Losanna, nel ’20, ma prima di vedere la luce passò sotto le forbici di Ezra Pound che lo resero ancor più enigmatico e allusivo.
Gerontion e Prufrock, dunque, come figure paradossali di una enigmatica condizione di vita. Ma preme alle porte un poemetto che intere generazioni prenderanno a simbolo di sé: La Terra desolata. Fu concepito durante un viaggio in Provenza e steso quasi di getto a Losanna, nel ’20, ma prima di vedere la luce passò sotto le forbici di Ezra Pound che lo resero ancor più enigmatico e allusivo.
Si divide in cinque sezioni composta tuttavia ognuna dalla intersezione dei personaggi e dei luoghi delle altre. Ne esce una costante tensione verso il mito; meglio, la creazione di una vera e propria terra mitica che diventa la somma di ogni mito e di ogni tensione. Parlarne è difficile, come ardua è la lettura. La Terra desolata è scritto in una lingua che occorre conoscere, densa di riferimenti e di allusioni, di «segni» di altre lingue, di altri miti, di altre letture e di altre poesie. Ciò che se ne genera è una sorta di «summa» sul modello sempre saldamente presente in Eliot della Divina Commedia.
Vero è che il poema dantesco è leggibile anche senza note o senza uno studio attento (e persine talvolta noioso) dei mille e mille riferimenti che lo compongono, ma chi si azzarderebbe a tale impresa senza aver la coscienza di precludersi in tal modo la comprensione del testo? Vero è che la Commedia è ugualmente scritta dai suoi mille riferimenti non detti (si. pensi alle citazioni del poeta provenzale Arnaud, che non a caso ricompaiono nella Terra desolata), e dalle sue mille frasi incomprensibili senza il sussidio di una paziente opera di disseppellimento.
C’è un «prima» del testo che sta alla scrittura come il vocabolario sta alla stesura normale del testo. Sono i rimandi, i richiami espliciti o impliciti a qualcosa che l’autore e il lettore sanno, ma che nel testo non è scritta. Eppure questo «non scritto» è la condizione perché lo scritto sia leggibile. Chi non conoscerà il «prima», ciò che sta a monte del testo e costituisce la condizione perché tu possa iniziare la lettura: «O voi che avete gli intelletti sani mirate la dottrina che s’asconde sotto il velame de li versi strani»), non potrà leggere, o, se leggerà, non potrà capire.
Nella Commedia dicevamo, questo meccanismo, bene o tanto presente in qualsiasi poesia, diventa il motore stesso della lettura: ce ne rendiamo talmente conto che il primo approccio al testo della Commedia è la lettura delle note, la spiegazione cioè di quel «prima» indispensabile alla lettura. Anzi in alcuni casi addirittura le «parole» della Commedia sono questi fatti, questi termini referenziali. Le note sono prima di tutto un vocabolario.
Si trasporti questo in un tempo dove il comun referente, la coscienza del cosmo medioevale, sia scomparso, si consideri invece la poesia di tempi e spazi mitici, dalle leggende del re pescatore, del Graal, del Marinaio Fenicio Annegato, seguendo poi via via lo svolgersi dei tarocchi, il Sermone del Fuoco di Budda e poi saghe, miti e leggende del Nord e dell’età cristiana e si avrà la materia, le parole, della Terra desolata. Un enigma fumoso, quindi, una poesia illeggibile? Piuttosto l’addensarsi di una cultura che attende da tempo immemorabile la possibilità di una nascita, di una rigenerazione.
Filo conduttore dei miti è l’impossibilità di una nascita, di una fecondazione. L’acqua, simbolo di fecondità, scompare per cedere ad una eterna attesa, di là dal tempo e di là dallo spazio, in una situazione mitica quindi. Perché, avvenga, accada, qualcosa: il canto del gallo e lo scroscio improvviso, sulle macerie della civiltà crollata e poi «l’umida raffica apportatrice di pioggia». Perché la barca riprenda il via.
L’ermetismo della poesia non è tuttavia accostabile ad un edonismo aristocratico, è piuttosto il «trobar clus» di Arnaud d’Aniel (non a caso si cita Dante che cita Arnaud), un «trobar clus» che Chiede e chiama a sé una attenzione cerebrale. Non il coinvolgimento dei sentimenti quindi, subito, ma la fatica della lettura e la ricostruzione del geroglifico. Il geroglifico ha, però, il suo significato, e il decifrarlo, quando è data la stele di Rosetta o chi per lei (e Eliot stesso nelle note, la da), diventa la riconquista faticosa del viaggio poetico, e quindi ri-creazione del testo. Leggere Eliot, come Dante, vuoi dire ri-crearlo.
La lettura, faticosissima, è affascinante. Pochi passi poetici come questo indicano il desiderio, assoluto, che qualcosa Accada. Che venga un tempo e una verità di rigenerazione. È tutta l’Europa che lo grida, tutta la nostra cultura, tutto il nostro tempo. È vero che la struttura mitica tende a trasferire nel mito, quindi oltre il tempo e al di là del tempo, la Terra desolata, ma è altrettanta vero che è la cultura nostra che viene assunta nel mito.
È Tiresia che appare o il mercante di Smirne, ma nella carne di una dattilografa o di un impiegato di un’agenzia di locazione, mentre è sul «London Brindge» che scorre la folla «Ch’i’ non avrei mai creduto che morte tante ne avesse disfatte». Il parallelo è inevitabilmente Dante. Il tempo della Commedia è l’Eterno, sì, ma materiato della cultura del suo tempo. Di volti, nomi e personaggi del suo tempo (non saranno Siena e Maremma, ma «Highbury mi fé’. Disfecemi Richmond e Kew»).
Abitanti in un certo senso emblematici della Terra desolata si rivelano gli Uomini vuoti del 1925. C’è un affinarsi verso una apparizione religiosa, verso la comparsa della Rocca che va di pari passo con l’avvenire di una coralità nelle parole che tendono a farsi partecipate, corali quindi e poi drammatiche.
La centralità, come al solito, non è il male ma è la mancanza di «essere», di bene, quindi, e perciò la mancanza di significato. La vita vuota e piena di nulla. Gli uomini di paglia sono figure senza forma, ombre senza colore, forza paralizzata, gesto privo di moto. È la stessa indolenza paralizzante di Prufrock divenuta landa, patria e perciò coro.
 È la «terra di immagini di pietra che ricevono la supplica di un morto, sotto lo scintillio di una stella che si va spegnendo». È « l’incubo di occhi che sono come luce di sole su una colonna infranta, occhi che in sogno non oso incontrare». Appare, con un ritmo lento ma implacabile, l’Ombra, «fra la concezione e la creazione, e la responsione, fra il desiderio e lo spasmo, fra la potenza e l’esistenza, fra l’essenza e la discendenza», ma una voce ripete «perché Tuo è il mondo». Quasi estranea, si attende che irrompa sulla scena. « Ma non c’è schianto, perché il mondo finisce non con uno schianto ma con un piagnisteo».
È la «terra di immagini di pietra che ricevono la supplica di un morto, sotto lo scintillio di una stella che si va spegnendo». È « l’incubo di occhi che sono come luce di sole su una colonna infranta, occhi che in sogno non oso incontrare». Appare, con un ritmo lento ma implacabile, l’Ombra, «fra la concezione e la creazione, e la responsione, fra il desiderio e lo spasmo, fra la potenza e l’esistenza, fra l’essenza e la discendenza», ma una voce ripete «perché Tuo è il mondo». Quasi estranea, si attende che irrompa sulla scena. « Ma non c’è schianto, perché il mondo finisce non con uno schianto ma con un piagnisteo».
La pausa ora del lavoro creativo che sta tra la Terra Desolata e il Mercoledì delle ceneri acquista significato nelle parole dello stesso Eliot. «So per esperienza personale che, a metà della propria vita, uno si trova davanti ad una triplice scelta: rinunciare a scrivere, ripetersi con, forse, un maggior grado di virtuosismo, oppure, con uno sforzo del pensiero, adattarsi a questa “età di mezzo” trovando un altro modo di lavorare».
Si fa più intensa la meditazione religiosa. Si intersecano in questo periodo alcuni frammenti teatrali (la parola tende alla forma drammatica), l’idea del Mercoledì delle ceneri e i primi Ariel Poems. I due frammenti che costituiscono il tentativo di dramma, Sweeney agonista, sono una manipolazione grottesca della stessa aridità mortale, della noia e della vuotezza della Terra Desolata. «L’intera vita — ha scritto un critico — vi appare ridotta al meccanismo fisiologico di “birth, copulation and death”»; come nelle parole di Sweeney: «nascita, copula e morte: tutto qui, tutto qui».
Nasce una rappresentazione parodistica, da «music-hall». L’uomo è ridotto a un fantoccio gesticolante. Ma in un’altra direzione doveva approfondirsi la meditazione, dopo aver esplorato la Terra Desolata, i suoi abitanti e i suoi modi di vita.
Gli Ariel Poems riportano alla centralità la persona, la sua attesa, l’inquietudine che nasce in chi ha visto e conosciuto: «Tornammo ai nostri regni, ai nostri luoghi, ma ormai non più tranquilli nelle antiche leggi, -fra un popolo straniero che è rimasto aggrappato ai propri idoli. Io sarei lieto di un’altra morte». E dopo i Magi, scossi da un avvenimento, da una Nascita e da una Morte che «avevo pensato differenti» c’è il canto liberatorio che invoca la pace di chi sa che la salvezza è avvenuta, «non pronunciante e impronunciata ancora». La vita si ferma sul limitare tra le scale dei santi e la stanchezza «della mia vita, della vita di quelli che verranno»: il cantico di Simeone.
E poi Animula: l’anima semplicetta che «esce di mano a Dio». Il mondo la carica di fardelli e il tempo la rende «irresoluta e egoista, deforme, zoppicante, incapace di spingersi in avanti come di retrocedere, timorosa della calda realtà del bene offerto». Eppure c’è spazio per una preghiera: « prega per noi e nell’ora della nostra nascita».
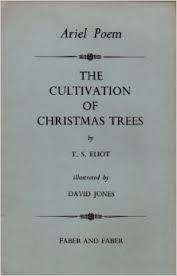 Marina conclude gli Ariel poems, con il desiderio dell’aprirsi a «questa forma, questo volto, questa vita» che «vive per vivere in un mondo di tempo che mi supera». «Potessi rimettere la mia vita per questa vita, la mia parola per ciò che non è detto, il risvegliato, le labbra aperte, la speranza, i bastimenti nuovi».
Marina conclude gli Ariel poems, con il desiderio dell’aprirsi a «questa forma, questo volto, questa vita» che «vive per vivere in un mondo di tempo che mi supera». «Potessi rimettere la mia vita per questa vita, la mia parola per ciò che non è detto, il risvegliato, le labbra aperte, la speranza, i bastimenti nuovi».
Mercoledì delle ceneri appare il necessario passaggio verso una poesia di salde e nette certezze, di azione meditata ma, in un certo senso, eroica, gonfia della coscienza che è avvenuto il «punto di intersezione del senza tempo col tempo». È il momento del pentimento, della macerazione, ma come possibilità di rigenerazione. La scala ne è il simbolo e la struttura. L’ascesa purificatrice è resa con la idea biblica prima ancora che dantesca della ascesa della scala.
Ad ogni giro è la lotta con la tentazione: dapprima il disgusto di sé, della propria degradazione, poi l’indulgenza, la mitica visione pastorale, poi una forza che spinge in alto: al di là della forza e della natura umana, la preghiera: «Non sopportare che io sia separato, e a te giunge il mio grido». Una poesia per cui si potrebbe ripetere quanto detto per la Terra Desolata, ma certo più chiara, più luminosa e quindi trasparente è l’aurea che si genera. Il movimento stavolta è tutto allegorico, e reca più netto in trasparenza i suoi significati
Il nuovo complesso di immagini è correlato ad una natura smagliante, tersa, in sostituzione delle squallide prospettive urbane. Ritornano i simboli luminosi della iconografia medioevale, le rose, i giardini, la fontana, i bestiari (il leopardo bianco, l’unicorno e l’aquila, ma anche i simboli biblici, l’aquila di Isaia); anche la versificazione è più fluida, più sciolta.
La lotta è tra la volontà di volere e il ricordo del passato, la coscienza della Sua volontade, «che è nostra pace» e il non poter sperare di «ritornar giammai» tra Cavalcanti e Dante. Ciò che vince non è la volontà di salire, ma la volontà di preghiera, la volontà di accettare che le ossa disperse siano rigenerate («Signore non sono degno, Signore non sono degno ma di’ soltanto una parola»).
L’aquila che non voleva volare («perché l’aquila antica dovrebbe spalancare le sue ali?», si leva a volo «alla sommità del cielo». È con questa immagine che si aprono i Cori della Rocca, primo dramma che assieme alla Cattedrale gli fu commissionato dal vescovo anglicano e dalla confraternita degli Amici di Canterbury. Ne restano i cori, spesso trascurati da letture frettolose. Il centro del cosmo e della storia è significato presente, voluto e affermato. La parola si è distesa, si è fatta coro, forma partecipata a tutti.
Eliot stesso aveva detto del teatro teorizzando le diverse fruibilità di livelli: «In un dramma di Shakespeare si possono cogliere vari livelli di significato. Per lo spettatore più sprovveduto c’è la trama, per quello più meditativo il personaggio e il suo conflitto, per il letterato le parole e i periodi, per quello di maggior sensibilità musicale il ritmo, per gli spettatori di più grande sensibilità e comprensione un significato che si rivela gradualmente».
 Il teatro di Eliot tiene conto di tutti i livelli di fruizione. Ma in particolare nella Rocca emerge ciò che guiderà Becket nella Cattedrale. La coscienza della Chiesa come luogo della Memoria, e luogo della Presenza. La Rocca, ciò che sta saldo, ricorda la Verità, richiama il significato che «tutta la coscienza moderna ha allontanato». «Il ciclo senza fine dell’idea e dell’azione, l’invenzione infinita, l’esperimento infinito, portano conoscenza del moto, non della immobilità, conoscenza del linguaggio ma non del Silenzio, conoscenza delle parole e ignoranza del Verbo. Tutta la nostra conoscenza ci porta più vicino alla nostra ignoranza, tutta la nostra ignoranza ci porta più vicino alla morte. Ma più vicini alla morte non più vicini a Dio.
Il teatro di Eliot tiene conto di tutti i livelli di fruizione. Ma in particolare nella Rocca emerge ciò che guiderà Becket nella Cattedrale. La coscienza della Chiesa come luogo della Memoria, e luogo della Presenza. La Rocca, ciò che sta saldo, ricorda la Verità, richiama il significato che «tutta la coscienza moderna ha allontanato». «Il ciclo senza fine dell’idea e dell’azione, l’invenzione infinita, l’esperimento infinito, portano conoscenza del moto, non della immobilità, conoscenza del linguaggio ma non del Silenzio, conoscenza delle parole e ignoranza del Verbo. Tutta la nostra conoscenza ci porta più vicino alla nostra ignoranza, tutta la nostra ignoranza ci porta più vicino alla morte. Ma più vicini alla morte non più vicini a Dio.
Dov’è la vita che abbiamo perduto vivendo?
Dov’è la saggezza che abbiamo perduto sapendo?
Dov’è la sapienza che abbiamo perduto nella informazione?
I cicli del cielo in venti secoli ci portano più lontani da Dio e più vicini alla polvere».
Nella società che grida «Abbiamo troppe chiese e troppe poche osterie» avanza la Rocca. «Colei che veglia, la Straniera. Colei che vede ciò che è accaduto, colei che vede ciò che accadrà, colei che critica». «La visitata da Dio, nella quale è innata la verità». E la Rocca ricorda che il Buono è colui che costruisce, mostra chi lavora, svela il lavoro degli altri, affinchè il mondo, «renda perfetta la sua volontà».
Gli operai costruiscono con un nuovo linguaggio: «C’è un lavoro comune, una chiesa per tutti e un impiego per ciascuno. Ognuno al suo lavoro ». Il ritmo si fa catechetico, accessibile, facilmente riconoscibile e ripercorribile dalla solitudine. Il coro si coinvolge in un ascolto. Lo spettatore diventa coreuta perché attirato in una consonanza di fede e di verità. La voce del poeta si stacca dal coro dei fedeli per rendere questo più conscio di sé, e uscendone si arricchisce e arricchisce. Perché un’altra voce si stacchi e renda più alto il grado di consapevolezza.
«Così i vostri padri furono fatti concittadini dei santi, della casa di Dio, edificati sopra le fondamenta degli apostoli e dei profeti, Cristo Gesù stesso essendo la pietra angolare». «Che vita è la vostra se non avete vita in comune? Non esiste vita se non nella comunità e non esiste comunità se non nella lode di Dio. Persino l’anacoreta in solitudine, per il quale i giorni e le notti ripetono le lodi di Dio, prega per la Chiesa, il Corpo di Cristo incarnato».
Il movimento da catechetico si fa sapienziale: «In principio Dio creò il mondo Deserto e vuoto. Deserto e vuoto. E tenebre erano sopra la faccia dell’abisso». E viene ripercorsa la storia dell’uomo, di nuovo in uno spazio mitico: si sgretola il tempo: «Preghiere scritte in cilindri girevoli, adorazione di morti, negazione di questo mondo, affermazione di riti il cui senso è dimenticato».
Quindi nel tempo «in un momento predeterminato, un momento nel tempo e del tempo, un momento non fuori dal tempo, ma nel tempo, in ciò che noi chiamiamo storia: sezionando, bisecando il mondo del tempo, un momento nel tempo ma non come un momento di tempo, un momento del tempo ma il mondo fu creato attraverso quel momento: poiché senza significato non c’è tempo, e quel momento diede significato al tempo».
Torna qui il tema del Tempo, della Storia. Ma è alla luce del significato che questa può esistere. Un significato non voluto e affermato come opzione, come scelta dell’uomo che si costruisce lo spazio e la terra perché il senso avvenga, e i codici con cui decifrare la sua rivelazione. Ma un significato che esiste perché c’è. Voluto e affermato perché avvenuto.
La nozione del tempo diventa la affermazione della possibilità di una storia, dello svolgersi di una storia .di salvezza. Proprio per questo, perché avvenuto in uno spazio e in un tempo determinato, perché fattosi carne («Verbum caro factumest»), il Figlio dell’uomo diviene guida per tutti, anzi ognuno diviene parte di lui, della sua storia.
E ognuno diviene figlio e corpo della passione e della croce. «E il Figlio dell’uomo non fu crocefisso una volta per tutte, il sangue dei martiri non fu versato una volta per tutte, le vite dei Santi non vennero donate una volta per tutte. Ma il Figlio dell’uomo è sempre crocefisso e vi saranno sempre Martiri e Santi. E se il sangue dei martiri deve fluire sui gradini dobbiamo prima costruire i gradini; e se il tempio deve essere abbattuto dobbiamo prima costruire il tempio».
La Terra Desolata acquista significato allora solo in rapporto a questa presenza che si dilata: la Chiesa: « E’ la Chiesa che ha abbandonato l’umanità, o è l’umanità che ha abbandonato la Chiesa? Quando la Chiesa non è più considerata, e neanche contrastata, e gli uomini hanno dimenticato tutti gli dei, salvo l’Usura, la Lussuria e il potere».
 Anche i Cori terminano con una preghiera, questa volta meno tesa, meno carica di angoscia e solitudine, perché anche la Tenebra è bene se amata nel nome della Luce: «E quando avremo edificato un altare alla Luce Invisibile, che vi si possano porre le piccole luci per le quali fu creata la nostra visione corporea. E noi ti ringraziarne che la Tenebra ricordi a noi la Luce. O Luce invisibile, ti siano rese grazie per la tua grande gloria».
Anche i Cori terminano con una preghiera, questa volta meno tesa, meno carica di angoscia e solitudine, perché anche la Tenebra è bene se amata nel nome della Luce: «E quando avremo edificato un altare alla Luce Invisibile, che vi si possano porre le piccole luci per le quali fu creata la nostra visione corporea. E noi ti ringraziarne che la Tenebra ricordi a noi la Luce. O Luce invisibile, ti siano rese grazie per la tua grande gloria».
Nel ’36 si incrociano la stesura dell’Assassinio nella Cattedrale, la prima opera vera e propria in forma drammatica, e la ideazione dei Quattro quartetti, cui seguiranno altre prove drammatiche, di sapore più classico. Scritto quasi in concomitanza con Burnt Norton, il primo dei Quartetti, l’Assassinio nella Cattedrale è la lotta di Thomas Beckett, arcivescovo di Canterbury, per la redenzione della Chiesa dapprima contro le forze di un potere politico che pretende di asservirla e ridurla alla sua misura ma poi sempre di più verso se stesso, contro la sua suprema tentazione. Incarnate in quattro personaggi, i tentatori, le sue stesse ansie e i suoi segreti desideri appaiono a Becket.
Primo è il desiderio della gloria mondana (la alleanza con il re che lui stesso assaporò in età più verde), poi il potere politico (il cancellierato), terza tentazione è la rivolta, la alleanza con i baroni: rovesciare il potere per sostituirsi ad esso, far di sé il nuovo principe.
Ma è il quarto tentatore il più temibile: «Che è il piacere, il governo regale» gli ricorda «o il comando di uomini inferiori al re, con astuzia negli angoli, e furtivi stratagemmi, in confronto al dominio universale del potere spirituale?». «Se è morto un re vi è un altro re, e un altro re è un altro regno. Il re sarà dimenticato, quando ne verrà un altro: il Santo e il Martire regnano dalla tomba».
È la tentazione della Santità, come gloria, conquista personale: «Che cosa può paragonarsi alla gloria dei santi, che dimorano per sempre alla presenza di Dio? Quale gloria terrena di Re o di Imperatore, quale terreno orgoglio, che non sia povertà a paragone della celeste grandezza? Cercate la via del martirio, fatevi il più basso in terra per essere il più in alto in cielo». La lotta è grande, ma occorre che l’Arcivescovo attraversi le sue stesse tentazioni per esserne purificato.
«Ora la strada mi è piana, ora è piano il significato; la tentazione in questa maniera non verrà più. L’ultima tentazione è il più grande tradimento: compiere la retta azione per uno scopo sbagliato. Il rigoglio della nostra natura nel peccato veniale è il modo con il quale comincia la nostra vita. Trentanni or sono cercai tutte le strade che menano al piacere, all’onore, alla lode. Delitto, torto, oppressione e filo d’ascia. Indifferenza, sfruttamento, tu, e tu, e tu, dovete essere tutti puniti. Ed anche tu.,Io non agirò, non soffrirò più a lungo; fino alla fine della spada. Ora Angelo mio buono, che Dio destina ad essere mio guardiano, librati sulla punta delle spade».
Becket ha scelto il martirio. Un martirio voluto, scelto e accettato, ma accettato in nome di Dio. Come affermerà davanti ai suoi assassini: «Non son io Becket della contrada dei mercanti, non è contro di me che voi contendete. Ma la legge della Chiesa di Cristo, il Giudizio di Roma» o, davanti ai sacerdoti che cercano di indurlo a salvarsi. «Per tutta la vita stanno venendo questi piedi. Per tutta la mia vita ho atteso. La morte verrà solo quando ne sarò degno, e se sono degno non c’è pericolo. Ho dunque soltanto da rendere perfetto il mio volere».
La coscienza della Volontà di Dio era nel cuore della predica nella cattedrale, intermezzo della tragedia. Becket diventa sempre più figura Christi. «Troveranno il pastore qui: il gregge verrà risparmiato;» «Tutte le cose procedono verso una gioconda beatitudine».
La scelta è eroica, ma non di eroismo d’uomo, ma dell’eroismo che accetta che sia compiuta la volontà di Dio. «Voi mi credete incauto disperato o pazzo» grida davanti ai sacerdoti che vogliono chiudere la porta del Tempio per tener lontani gli assassini.
«Voi concludete dai risultati come fa il mondo, per decidere se una azione è buona o grama. Vi rimettete al fatto. Che ogni vita e ogni atto può dimostrarsi conseguenza di bene o di male. E come nel tempo sono commisti i risultati di molti fatti così alla fine si faranno confusi il bene e il male. Non è nel tempo che la mia decisione, che la mia morte sarà conosciuta; la mia decisione è presa fuori dal tempo se chiamate decisione ciò al quale tutto il mio essere dona pieno consenso. Io do la mia vita per la legge di Dio sopra la legge dell’uomo. Disserrate la porta! Disserrate la porta! Noi non siamo qui per trionfare con la lotta, con lo stratagemma o con la resistenza, non a combattere con bestie simili a uomini. Noi abbiamo combattuto la bestia e abbiamo vinto. Dobbiamo solo conquistare ora con la sofferenza la vittoria più facile. Ora è il trionfo della croce, ora aprite la porta! lo lo comando. Aprite la porta!».
Dopo il pianto del coro, vero e proprio trait d’union tra la scena e gli spettatori, in cui vi si leggono riflesse le fasi della lotta di Becket e le reazioni emotive di chi assiste alla scena, gli assassini si rivolgono al pubblico. Il discorso è sensato, ordinato. Le cause sono esposte lucidamente «siete inglesi e perciò credete al fair play, alla lealtà del gioco».
Ma attraverso il gioco del discorso, un po’ ironico, sempre distaccato la conclusione coinvolge lo spettatore: ne fa un complice. «Ma se voi siete arrivati ad una giusta subordinazione delle pretese della Chiesa al benessere dello stato, ricordatevi che siamo stati noi a fare il primo passo. Noi siamo stati come gli strumenti per la creazione di quello stato di cose che approvate. Abbiamo servito i vostri interessi, meritiamo il vostro plauso; e se in questo affare vi è una colpa, voi dovete dividerla con noi».
Ma non trionfa la riduzione meschina della ragione divisa da Dio, legata ad un ridicolo, ancorché piccolo, egoismo. «Perché la Chiesa è più forte di questo fatto, trionfante nella avversità. È rafforzata dalla persecuzione: suprema, fin che gli uomini moriranno per essa». Una coscienza che va al di là della negazione: «Coloro che ti negano non ti potrebbero negare, se Tu non esistessi; e la loro negazione non è mai completa, che, se così fosse, essi non esisterebbero. Essi vivendo ti affermano, tutte le cose vivendo ti affermano: l’uccello nell’aria falco e fringuello, l’animale sulla terra lupo e agnello, il verme sotto il suolo e il verme dentro il ventre».
Dunque il teatro era per Eliot « il medium ideale e la più alta espressione della utilità sociale della poesia». Ciò che fece volgere il poeta al dramma non fu un mutamento della sua concezione della vita, impregnata di un assoluto e tesa verso le forme della coralità, verso la forma partecipata; e non fu quindi neppure un mutamento del modo di avvertire l’arte e le sue possibilità ca-tartiche. Fu anzi la stretta coerenza tra forma artistica e tensione vitale a premere verso quel tentativo di ridare allo spazio scenico quell’afflato religioso che gli era stato proprio alle origini.
Certo il teatro viveva, e vive, all’indomani di una perdita di possesso di sé, di identità. Nell’Inghilterra di quegli anni il teatro, se era, era «naturalismo», al massimo critica, critica sociale e istituzionale. Ma perso era lo spazio vero della teatralità, nato come spazio religioso, come ponte offerto all’uomo verso le sue origini e i suoi miti, come luogo di riappropriazione delle sue certezze o di critica dei suoi valori; come luogo, insomma, dove la comunità umana si specchiava e confrontava coi miti stessi che erano alla propria origine e alla propria fondazione.
Una visione questa del teatro che non poteva non derivare a Eliot dalla lunga frequentazione dei classici greci. La forma invece, almeno apparentemente, diremmo meglio «l’ambiente» è quello borghese dell’Inghilterra settentrionale o della Londra del dopoguerra. Ma invano ricercheremmo riferimenti cronoligici reali, il tempo è quello del mito, dove immutabili si inseguono e si rincorrono gli «eterni temi».
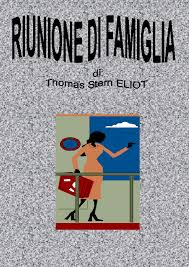 Irrompono sulla tranquilla scena inglese le Erinni, le vendicatici delle Coefere di Eschilo. Nasce così Riunione di famiglia, nel 1939, e suonano voci che bene starebbero nelle poesie e anzi in parte dalle poesie sono tratte o alle poesie torneranno: «Intendo penoso, perché tutto è irrevocabile, perché il passato è irrimediabile, perché il futuro può essere costruito soltanto sul passato reale». Anche qui la coscienza di una presenza assoluta, di un destino che preme la scena degli uomini e del teatro incalza: «In questo momento non vi è alcuna decisione da prendere: la decisione sarà presa da forze al di là di noi che di quando in quando si mostrano».
Irrompono sulla tranquilla scena inglese le Erinni, le vendicatici delle Coefere di Eschilo. Nasce così Riunione di famiglia, nel 1939, e suonano voci che bene starebbero nelle poesie e anzi in parte dalle poesie sono tratte o alle poesie torneranno: «Intendo penoso, perché tutto è irrevocabile, perché il passato è irrimediabile, perché il futuro può essere costruito soltanto sul passato reale». Anche qui la coscienza di una presenza assoluta, di un destino che preme la scena degli uomini e del teatro incalza: «In questo momento non vi è alcuna decisione da prendere: la decisione sarà presa da forze al di là di noi che di quando in quando si mostrano».
Le forze in campo si schierano, e se nella vita esiste un solco, e quindi un dramma, quel solco e quel dramma si riflettono in tutte le opere: la divisione che regna tra chi è consapevole della presenza dell’Assoluto al di là della banale attività quotidiana, o meglio dentro e attraverso la banale attività quotidiana e chi vive nella dimenticanza. In tutte le opere, dall’Assassinio nella cattedrale alla Riunione di famiglia, da Cocktail party rappresentato per la prima volta al festival di Edimburgo nel 1949, all’Impiegato di -fiducia, portato invece sulla scena ad Edimburgo nel 1953, si snoda il dramma della ricerca del proprio destino e dell’accettazione attiva di esso.
Un’accettazione che è possibile nell’Amore, come si legge nelle battute finali del Vecchio statista, l’ultima opera teatrale di Eliot, del 1958. «Lì sono liberato di quell’io che fingeva di essere qualcuno, e nel divenire nessuno comincia a vivere. Vale la pena di morire per scoprire cos’è la vita». «Nemmeno la morte riesce più a stupirmi e a sgomentarmi fissa come sono nella certezza di un amore che non muta. Mi sento interamente sicura in te. Sono parte di te».
Contemporaneamente dunque ad Assassinio nella Cattedrale e accanto a Cocktail party, prendevano forma i Quattro Quartetti. La stesura di questo poema unitario sulla cui struttura e sul cui significato credo tutto si sia scritto, impegna Eliot dal ’36 al ’42. Benché pubblicate separatamente è la stessa struttura che fa delle parti un tutto unico. Ricorre il tema della liberazione dal tempo e dallo spazio, esperienza personale che si fonda e si oggettiva sulla scena della storia e della tradizione che è «esperienza di tutti».
L’esperienza umana e personale anzi è concepita e concepibile solo in quanto capace di cogliere il principio unitario di tutti e di tutto. Diversa la forma in cui avviene e il suo declinarsi particolare, diversi i tempi e gli spazi, ma unica la Forma e il Contenuto, unico il Tempo e lo Spazio, l’Eterno avvenuto nel tempo. Già il frammento Eracliteo in apertura ammonisce l’uomo a diffidare dal porre la propria come unica saggezza: «Benché la parola sia comune a tutti, gli uomini per lo più vivono come se ognuno avesse una sua saggezza propria »
I Quattro quartetti sono costruiti su questo contrasto tra la visione del tempo e l’immettersi nel tempo dell’Eterno «ma comprendere il punto di intersezione del senza tempo col tempo, è un’occupazione da Santi, per la maggior parte di noi non c’è che il momento, a cui non si bada, il momento dentro e fuori dal tempo». Occorre un momento epifanico, una rivelazione: «l’accenno mezzo indovinato, il dono mezzo capito, è la incarnazione» che rivela e lascia intatto il mistero. Che manifesta e vela.
 Difficile è addentrarsi nei Quartetti, senza innanzi tutto considerare il loro sistema compositivo, e del resto la stessa parola «Quartet» richiama alla mente l’analogia della composizione musicale. Lo stesso Eliot aveva scritto: «Penso che un poeta abbia molto da guadagnare dallo studio della musica… Sono convinto che il senso del ritmo e quello della struttura siano le proprietà musicali che più da vicino interessano il poeta… L’impiego di temi ricorrenti è per la poesia tanto naturale quanto la musica».
Difficile è addentrarsi nei Quartetti, senza innanzi tutto considerare il loro sistema compositivo, e del resto la stessa parola «Quartet» richiama alla mente l’analogia della composizione musicale. Lo stesso Eliot aveva scritto: «Penso che un poeta abbia molto da guadagnare dallo studio della musica… Sono convinto che il senso del ritmo e quello della struttura siano le proprietà musicali che più da vicino interessano il poeta… L’impiego di temi ricorrenti è per la poesia tanto naturale quanto la musica».
La struttura musicale individuata da Eliot è la stessa presente in ognuno dei quartetti: al primo movimento, che contiene in genere due elementi contrastanti, si oppone il secondo: identico tema ma svolto su due tonalità diverse. Il terzo è una elaborazione dei temi precedentemente incontrati, il quarto movimento raggiunge l’apice lirico per essere poi ripreso in una sorta di ricapitolazione generale di temi e di stile nell’ultimo movimento.
La struttura estremamente significativa (si pensi alla Commedia), la ripartizione in quattro quartetti corrisponde a quattro luoghi della vita di Eliot rivistati nella memoria, ancora corrisponde alle quattro stagioni (il primo, Euri Norton, è la primavera), e anche ai quattro elementi naturali, (Burt Norton, l’aria, East Cocker, la terra, The Dry Salvages, l’acqua, Little Gidding, il fuoco).
Non mancano elementi mistici ed ascetici, di volta in volta individuati dalla critica. Ci interessa ora rileggere alcuni punti, o degli alcuni «motivi» suggestivi dell’opera, immensa (ancorché piccola per dimensione), sinfonia da camera. Immensa perché capace di dilatarsi, di espandersi nella sua polisenia fino ad essere (ed ancora una volta il parallelo con la Commedia è di rigore) una nuova «summa» della cultura europea.
La circolarità ne è momento cardine: il secondo quartetto che si apre con «Nel mio principio è la mia fine» e si chiude con il ribaltamento della frase «Nella mia fine è il mio principio». La circolarità appare qui in tutta la sua carica semantica, prima ancora che retorica, là dove un principio e una fine, nel loro opporsi e reintegrarsi divengano segno di vita vissuta nella coscienza di un limite e limite accettato nella coscienza del suo essere nuovo principio di vita.
La ricerca di un punto fermo, «il mezzo conflitto», il punto fermo del mondo che ruota, ha una condizione, una condizione di privazione, di spogliazione, di buio interiore (S. Giovanni della Croce è una presenza ricorrente in Eliot). Non la privazione, la spogliazione, il buio di tanta parte della sua società, la quale è piuttosto «un luogo di disaffezione», «una tumida apatia senza concentrazione». Non il buio di un «mondo che cinguetta», ma «più giù», là dove il mondo si scioglie e si arrende. Là dove è stato condotto il verbo di Dio, nel silenzio del nuovo deserto. E il tempo che vuoi prescindere da quel perno, è soltanto XIV XV «ridicolo e squallido».
Eppure il tempo sembra condannato a vivere nel cerchio, e quindi a vivere la sua morte che riavviene, ciclicamente: già all’inizio la fine è presente. Che significano allora, se tutto è solo un continuo e monotono avvenire di nascite e di morti, un ruotare di stagioni già note e sempre uguali, allora che significano le rotture e gli sconvolgimenti che pure accadono, che rompono quell’ordine autosufficiente? Gli antenati ci hanno ingannato: la loro serenità è «solo una deliberata ebetitudine», la loro sapienza «solo conoscenza di segreti morti». Perciò «non voglio sentir parlare della saggezza dei vecchi, bensì della loro follia… la sola saggezza che possiamo ottenere è la saggezza della umiltà».
La parola squarcia, nel vero senso della parola la coscienza del mondo che si è offerta: se saggezza, e conoscenza, è umiltà, allora il modo di essere, e quindi di conoscere, è ribaltato. È attesa, adesione; perché venga il chirurgo ferito, Cristo, e l’infermiera morente, la Chiesa. La terra è un ospedale finanziato da un milionario morente (Cristo, e la croce). Occorre una morte («sarei lieto di un’altra morte» aveva detto nel canto dei magi), perché la frase possa essere ribaltata «Nella mia fine è il mio principio».
È il punto di intersezione tra Tempo e Eterno che ritorna incessantemente. L’avvenimento «mezzo capito» in cui il velo si è squarciato e ha fatto irruzione sulla scena del mondo l’Autore. Il punto nel tempo che del tempo non è prigioniero, e perciò lo sostiene e lo redime. La storia intera vi consiste ed essa stessa è «una trama di momenti senza tempo», una catena di punti di intersezione su cui si radicano le persone e i popoli».
Torna la circolarità in una visione in cui il parallelo dantesco è trasparente: «E tutto sarà bene, e ogni sorta di cosa sarà bene quando lingue di fuoco si incurvino nel nodo di una corona e il fuoco e la rosa siano uno».
«E così eccomi qua» aveva scritto «nel mezzo del cammino, dopo vent’anni… Vent’anni in gran parte sciupati,
gli anni dell’ “entre deux guerres”…
A cercar di imparare l’uso delle parole,
e ogni tentativo
È un rifar tutto da capo,
e una specie diversa di fallimento
Perché si è imparato a servirsi bene delle parole
Soltanto per quello che non si ha da dire,
o nel modo in cui
Non si è più disposti a dirlo.
E così ogni impresa
E un cominciar di nuovo, un’incursione nel vago
Con logori strumenti che peggiorano sempre
Nella grande confusione dei sentimenti imprecisi
Squadre indisciplinate di emozioni.
E quello che c’è da conquistare
Con la forza e la sottomissione, è già stato scoperto
Una volta o due, o parecchie volte,
da uomini che non si può sperare
Di emulare — ma non c’è competizione — c’è solo lotta per recuperare ciò che si è perduto e trovato e riperduto senza fine:
e adesso le circostanze Non sembrano favorevoli.
Ma forse non c’è da guadagnare né da perdere
Per noi non c’è che tentare.
Il resto non ci riguarda ».
|
«E’ questo il modo in cui finisce il mondo» Qui noi giriamo attorno al fico d’India Fico d’India fico d’India Qui noi giriamo attorno al fico d’India Alle cinque del mattino.
fra l’idea E la realtà Fra il gesto E l’atto Cade l’Ombra
Perché Tuo è il Regno Fra la concezione E la creazione Fra l’emozione E la responsione Cade l’Ombra
La vita è motto lunga
Fra il desiderio E Io spasmo Fra la potenza E l’esistenza Fra l’essenza E la discendenza Cade l’Ombra
Perché Tuo è // Regno
Perché Tuo è La vita è Perché Tuo è il
E’ questo il modo in cui finisce i! mondo E’ questo il modo in cui finisce il mondo E’ questo i! modo in cui finisce il mondo Non già con uno schianto ma con uri piagnisteo. (da Gli uomini vuoti, 1925 – Trad. dì Roberto Sanesi) |
|
«Non rinnegherete la straniera» CORO: Edifichiamo invano Il Signore non edifica con noi. Potete reggere forse la Città se il Signore non resta con voi? Mille vigili che dirigono il traffico Non sanno dirvi né perché venite né dove andate. Una colonia intera di cavie o un’orda d’attive marmotte Edificano meglio di coloro che edificano senza il Signore. Ci leveremo in piedi fra rovine perenni? Ho amato la bellezza della Tua Casa, la pace del Tuo santuario, Ho spazzato i pavimenti e adornato gli altari. Là dove non c’è tempo non vi saranno dimore, Sebbene abbiate rifugi e istituzioni, Alloggi precari dove sì paga l’affitto, Scantinati che cedono dove il topo si nutre O latrine con porte numerate O una casa un po’ meglio di quella dei vicino; Quando la Straniera dice: «Qual è il significato dì questa città Vi accalcate vicini perché vi amate l’un l’altro?» Cosa risponderete? «Ci accalchiamo Per trarre denaro l’uno dall’altro»? oppure «Questa è una comodità»? E la Straniera partirà e tornerà nel deserto. O anima mia, che tu sia pronta per la venuta della Straniera, Che tu sia pronta per colei che sa come fare domande. O stanchezza di uomini che vi stornate da Dio Per la grandezza della vostra mente e la gloria della vostra azione, Per le arti e le invenzioni e le imprese temerarie, Per gli schemi della grandezza umana del tutto screditata Che riducete la terra e l’acqua al vostro servizio, Che sfruttate i mari e sviscerate le montagne, Che dividete le stelle in comuni e preferite, Impegnati a ideare il frigorifero perfetto, Impegnati a risolvere una morale razionale, Impegnati a stampare più libri che potete, A far progetti di felicità e a buttar via bottiglie vuote, Passando dalla vacuità ad un febbrile entusiasmo Per la nazione o la razza o ciò che voi chiamate umanità; Sebbene abbiate dimenticato la via al Tempio Ve una che ricorda la via alla vostra porta: Potete eludere la Vita, ma non la Morte. Non rinnegherete la Straniera. (da I cori da «la Rocca», 1934 -Trad. di Roberto Sanesi) |
|
mercoledì delle Ceneri Se la parola perduta è perduta, se !a parola spesa è Spesa Se (a parola non detta e non udita E’ non udita e non detta, Sempre è la parola non detta, II Verbo non udito, II Verbo senza parola, il Verbo Nel mondo e per il mondo; E la luce brillò nelle tenebre e II mondo inquieto contro il Verbo ancora Ruotava attorno al centro del Verbo silenzioso. O mio popolo, che cosa ti ho fatto. Dove ritroveremo la parola, dove risuonerà La parola? Non qui, che qui il silenzio non basta Non sul mare -o sull’isole, né sopra La terraferma, nel deserto o nei luoghi di pioggia, Per coloro che vanno nelle tenebra Durante il giorno e la notte II tempo giusto e il luogo giusto non sono qui Non v’è luogo di grazia per coloro che evitano il volto Non v’è tempo dì gioire per coloro che passano in mezzo al rumore e negano la voce Pregherà la sorella velata per coloro Che vanno nelle tenebre, per coloro che ti scelsero e si oppongono A te, per coloro che sono straziati sul corno fra stagione e stagione, tempo e tempo, Fra ora e ora, parola e parola, potenza e potenza, per coloro che attendono Nelle tenebre? Pregherà la sorella velata Per i fanciulli al cancello Che non lo varcheranno e non possono pregare: Prega per coloro che ti scelsero e ti si oppongono O mio popolo, che cosa ti ho fatto. Pregherà la sorella velata fra gli alberi magri di tasso Per coloro che l’offendono e sono Terrificati e non possono arrendersi E affermano di fronte al mondo e fra le rocce negano Nell’ultimo deserto e fra le ultime rocce azzurre II deserto nel giardino il giardino nel deserto Della secchezza, sputano dalla bocca M secco seme di mela. O mio popolo. Benché non speri più di ritornare Benché non speri Benché non speri di ritornare A oscillare fra perdita e profitto In questo breve transito dove i sogni si incrociano II crepuscolo incrociato dai sogni fra nascita e morte (Benedicimi padre) sebbene non desideri più di desiderare queste cose Dalla finestra spalancata verso la riva di granito Le vele bianche volano ancora verso il mare, verso il mare volano Le ali non spezzate E il cuore perduto si rinsalda e allieta Nel perduto lillà e nelle voci del mare perduto E lo spirito fragile s’avviva a ribellarsi Per la ricurva verga d’oro e l’odore del mare perduto S’avviva a ritrovare II grido della quaglia e il piviere che ruota E l’occhio cieco crea Le vuote forme fra le porte d’avorio E l’odore rinnova il sapore salmastro della terra sabbiosa Questo è il tempo della tensione fra fa morte e la nascita II ‘luogo della solitudine dove tre sogni s’incrociano Fra rocce azzurre Ma quando le voci scosse dall’albero di tasso si partono Che l’altro tasso sia scosso e risponda. Sorella benedetta, santa madre, spirito della fonte, spirito del giardino Non permettere che ci si irrida con la falsità Insegnaci a aver cura e a non curare Insegnaci a starcene quieti Anche fra queste rocce, E’n la Sua volontade è nostra pace E’ anche fra queste rocce Sorella, madre. E spirito del fiume, spirito del mare, Non sopportare che io sia separato E a Te giunga i! mio grido. |
|
L’Arcivescovo predica nella cattedrale la mattina di Natale del 1170. «Gloria a Dio nel più alto dei cieli, e pace in terra agli uomini di buona volontà». Versetto quattordicesimo del secondo capitolo dal Vangelo secondo San Luca. Nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo. Amen Figliuoli cari di Dio, la mia predica questa mattina sarà molto breve. Voglio soltanto che consideriate e meditate il profodo significato e il mistero delle nostre Messe del giorno di Natale. Poiché ogni volta che si celebra la Messa noi compiamo di nuovo la Passione e la Morte di Nostro Signore; e in questo giorno di Natale la compiamo nella celebrazione della Santa Nascita. Cosicché nel medesimo momento godiamo della Sua venuta per la salvezza degli uomini, e rioffriamo a Dio il Suo Corpo e il Suo Sangue in sacrificio, oblazione e soddisfazione per i peccati del mondo intero. Fu in questa notte, da poco trascorsa, che una moltitudine dell’esercito celeste apparve ai pastori a Betlemme, dicendo « Gloria a Dio nel più aito dei cieli, e pace in terra agli uomini di buona volontà »; in questo medesimo momento, unico in tutto l’anno, noi celebriamo insieme la Nascita di Nostro Signore e la Sua Passione e Morte sulla Croce. Carissimi, secondo il mondo, questo modo di comportarsi è strano. Poiché chi nel mondo vuoi piangere e rallegrarsi nello .stesso tempo e per la stessa ragione? Infatti, o la gioia verrà dominata dall’afflizione, o l’afflizione sarà scacciata dalla gioia; ed è perciò soltanto in questi nostri misteri cristiani che noi possiamo gioire e piangere nel medesimo tempo e per la stessa ragione. Ma pensate un po’ al significato di questa parola «pace». Non vi sembra strano che gli angeli abbiano annunziato la Pace, quando il mondo incessantemente è colpito dalla Guerra e dal timore della Guerra? Non vi sembra che le voci angeliche sì stano sbagliate, e che la promessa fu una delusione un inganno? Riflettete ora come parlò delta Pace Nostro Signore stesso. Egli disse ai Suoi discepoli: «Io vi lascio la mia pace, vi do la mia pace». Intendeva Egli dire pace come noi la intendiamo: il regno d’Inghilterra in pace con i suoi vicini, i baroni in pace col Re, il capofamiglia che conta i suoi pacifici guadagni, il focolare ben pulito, il suo miglior vino per l’amico sulla tavola, la sua donna che canta ai suoi bambini? Quegli uomini che erano suoi discepoli non sapevano di queste cose; essi uscirono a fare un lungo viaggio, a soffrire per terra e per mare, a incontrar la tortura, la prigione, la delusione, a soffrir la morte col martirio. Che cosa voleva dunque Egli dire? Se lo volete sapere, ricordatevi che Egli disse anche: «Non come il mondo ve la da, io ve la do». Dunque, Egli diede la pace ai Suoi discepoli, ma non la pace come la da il mondo. Considerate anche una cosa alla quale forse non avete mai pensato. Noi non solo celebriamo insieme nella festa di Natale la Nascita di Nostro Signore e la sua Morte, ma nel giorno seguente celebriamo il martirio del Suo primo martire, il beato Stefano. Credete che sia per caso che il giorno del primo martire segua immediatamente il giorno della Nascita di Cristo? Certamente no. Proprio come noi godiamo e soffriamo insieme, alla Nascita e alla Morte di Nostro Signore, così anche, in proporzione inferiore, godiamo e soffriamo alla morte dei martiri. Soffriamo per i peccati del mondo che li ha martirizzati; godiamo, che un’altra anima è annoverata fra i Santi in Cielo, per la gloria di Dio e per la salvezza degli uomini. Carissimi, noi non pensiamo a un martire semplicemente come a un buon cristiano che fu ucciso perché è un cristiano: ciò sarebbe soltanto piangere. Non pensiamo a lui semplicemente come a un buon cristiano che fu elevato alla schiera dei Santi: poiché questo sarebbe soltanto godere; e né il nostro piangere né il nostro godere sono come quelli del mondo. Un martirio cristiano non è un caso. I Santi non sono fatti a caso. Ancor meno è un martirio cristiano l’effetto della volontà di un uomo di diventar santo, come un uomo volendo e tramando può diventare un reggitore di uomini. Un martirio è fatto sempre dal disegno di Dio, per il Suo amore per gli uomini, per ammonirli e per guidarli, per riportarli sulle Sue vie. Un martirio non è mai un disegno d’uomo; poiché vero martire è colui che è divenuto strumento di Dio, che ha perduto la sua volontà nella volontà di Dio, e che non desidera più nulla per se stesso, neppure la gloria del martirio. Così dunque come sulla terra la Chiesa insieme piange e gioisce, in un modo che il mondo non può capire; così in Cielo i Santi sono molto in alto, essendosi molto abbassati, vedendo se stessi non come noi li vediamo, ma nella luce della Divinità, dalla quale traggono il loro essere. Vi ho parlato oggi, figliuoli cari di Dio, dei martiri del passato, e vi chiedo di ricordare specialmente il nostro martire di Canterhury, il beato Arcivescovo Elfego; poiché ben s’addice, nel giorno della Nascita di Cristo, ricordare qual è quella Pace che Egli portò; e perché, figliuoli cari, non credo che vi parlerò ancora; e perché è possibile che fra breve voi abbiate un nuovo martire, il quale, forse, non sarà l’ultimo. Vorrei che custodiste nel vostro cuore queste parole che dico, e che a ricordarle in altro tempo. Nel Nome dei Padre e del Figliuolo e dello. Spirito Santo. Amen |
BILIOGRAFIA
T.S ELIOT Poesie Bompiani ’61; I ed. Oscar Mondatori ’71, II ed. Oscar Mondatori ’74; Garzanti, coll. Grandi Libri ’75
(Contiene: Poesie giovanili, Prufrock e altre osservazioni, 1917; Poesie, 1920; La terra desolata, 1922; Gli uomini vuoti, 1925; Ariel Poems, Sweeney agonista – frammenti di un dramma aristofanesco, Coriolano, Poesie Minori, cori dalla «Rocca», La Cultura degli alberi di Natale, Versi occasionali)
T.S ELIOT Teatro, Bompiani, 1958; VI es. I Delfini Nuova serie, 1976.
(Contiene: Assassinio nella Cattedrale, La riunione di famiglia, Il Cocktail party, L’Impiegato di fiducia, Il Vecchio statista)
T.S ELIOT, Quattro Quartetti, garzanti 1959, coll. Grandi Libri, I ed. ’76, II ed. ’79