 Tempi 15 giugno 2021
Tempi 15 giugno 2021
Il Green Deal che innerva i prossimi investimenti multimiliardari dell’Europa rischia di portare benefici trascurabili all’ambiente. E più che favorire “ripresa e resilienza”, può affossarle. Consegnandoci allo strapotere cinese. Inchiesta
Leone Grotti

Ursula von der Leyen
Neanche fosse, come i Blues Brothers, «in missione per conto di Dio», nel dicembre 2019 Ursula von der Leyen annunciò un «piano per salvare il pianeta». La presidente della Commissione europea, più conosciuta per i suoi proclami che per i risultati raggiunti, lanciò il famoso Green Deal, un mastodontico piano per rendere l’Europa il primo continente climaticamente neutro entro il 2050.
Senza aspettare di trovare un accordo con i partner internazionali, pur consapevole che l’ambiente è un problema globale e non locale, Bruxelles ha deciso di rivoltare come un calzino la propria economia e il proprio modello produttivo per fare da apripista, nella speranza che il mondo si accodi per invidia o per convenienza.
Dall’approvvigionamento energetico alla mobilità, dalla produzione al commercio, dalla definizione di nuove regole globali al necessario stravolgimento delle alleanze internazionali, tutto dovrà cambiare perché la rivoluzione verde abbia successo. L’Italia ha scelto convintamente di accodarsi, destinando circa 70 miliardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) alla transizione ecologica. Il Green Deal può essere davvero, per l’Europa, «il momento “Uomo sulla Luna”», come affermato dalla Von der Leyen.
 Ma se i ventisette paesi dell’Unione Europea non metteranno da parte gli egoismi nazionali e se non sapranno convincere i grandi emettitori di gas serra come Stati Uniti, Cina, Russia e India a percorrere la stessa strada, allora la missione, più che ricalcare l’Apollo 11, assomiglierà all’Apollo 13, assestando un colpo mortale alla stessa economia europea senza aver migliorato per nulla l’ambiente.
Ma se i ventisette paesi dell’Unione Europea non metteranno da parte gli egoismi nazionali e se non sapranno convincere i grandi emettitori di gas serra come Stati Uniti, Cina, Russia e India a percorrere la stessa strada, allora la missione, più che ricalcare l’Apollo 11, assomiglierà all’Apollo 13, assestando un colpo mortale alla stessa economia europea senza aver migliorato per nulla l’ambiente.
Ets, meccanismo inceppato
Dal punto di vista ambientale l’Europa è la potenza più virtuosa al mondo, avendo ridotto le proprie emissioni del 24 per cento tra il 1990 e il 2019 e addirittura del 3,7 per cento in due soli anni tra il 2018 e il 2019. Attualmente immette nell’atmosfera il 9 per cento dei gas serra, contro il 15 degli Stati Uniti e il 30 della Cina, ma si è unilateralmente impegnata ad azzerare le proprie emissioni nette entro il 2050 e a ridurle del 55 per cento in nove anni entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990.
 Per raggiungere l’obiettivo Bruxelles ha bisogno di investire 1.000 miliardi di euro nei prossimi 10 anni e punta a raggiungere una quota del 32 per cento di energia rinnovabile, migliorare l’efficienza energetica di edifici e aziende del 32,5 per cento, immettere sul mercato una quantità smisurata di veicoli elettrici (e magari renderli obbligatori a partire dal 2035) e soprattutto diminuire la disponibilità di permessi inquinanti rilasciati in base al meccanismo Ets (Emission Trading System), entrato in vigore nel 2005.
Per raggiungere l’obiettivo Bruxelles ha bisogno di investire 1.000 miliardi di euro nei prossimi 10 anni e punta a raggiungere una quota del 32 per cento di energia rinnovabile, migliorare l’efficienza energetica di edifici e aziende del 32,5 per cento, immettere sul mercato una quantità smisurata di veicoli elettrici (e magari renderli obbligatori a partire dal 2035) e soprattutto diminuire la disponibilità di permessi inquinanti rilasciati in base al meccanismo Ets (Emission Trading System), entrato in vigore nel 2005.
L’Unione Europea, in sostanza, stabilisce ogni anno quante emissioni di Co2 permettere sul proprio territorio e obbliga le aziende che rilasciano nell’atmosfera determinati agenti inquinanti (in particolare biossido di carbonio, ossido di azoto e perfluorocarburi) ad acquistare permessi per continuare a farlo. Ogni quota equivale a una tonnellata di Co2 e le aziende interessate, 11 mila al momento, possono accaparrarsi le quote acquistandole o direttamente da altre aziende, che si sono ritrovate a inquinare meno, o sui mercati finanziari.
 L’idea dell’intero sistema, appena entrato nella Fase 4, è semplice: mantenere i prezzi dei “carbon credit” così alti da costringere le aziende a trovare soluzioni produttive più green per risparmiare. Per tenere alti i prezzi dei diritti inquinanti, e conseguire l’obiettivo della decarbonizzazione, a partire da quest’anno l’Unione ha annunciato una riduzione delle quote disponibili del 2,2 per cento all’anno.
L’idea dell’intero sistema, appena entrato nella Fase 4, è semplice: mantenere i prezzi dei “carbon credit” così alti da costringere le aziende a trovare soluzioni produttive più green per risparmiare. Per tenere alti i prezzi dei diritti inquinanti, e conseguire l’obiettivo della decarbonizzazione, a partire da quest’anno l’Unione ha annunciato una riduzione delle quote disponibili del 2,2 per cento all’anno.
Al momento, i settori più a rischio di subire la competizione internazionale ricevono quote gratuite, ma l’intero comparto manifatturiero ne avrà a disposizione sempre meno. Von der Leyen ha annunciato di voler applicare da luglio il sistema anche al settore marittimo, dei trasporti (aereo e su gomma), dell’automotive e delle costruzioni. In un mondo ideale, questo sistema dovrebbe portare le aziende europee a riconvertirsi e a diventare più virtuose dal punto di vista ambientale.
Nella pratica, però, si vedono già i primi effetti distorsivi dell’Ets. Quello secondario, e meno pericoloso, ha già fatto scattare l’allarme dell’Arera (l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente). Per far fronte all’aumento del prezzo delle quote di emissione, circa 50 euro l’una, le aziende stanno di fatto scaricando i costi sui consumatori finali: le famiglie. Secondo l’authority, l’aumento del costo dell’energia potrebbe portare ad esempio a bollette più salate fino al 10 per cento nei prossimi mesi. Ma non finisce qui.
Una tassa molto discussa
 Il problema principale riguarda infatti la competitività dell’intera economia europea. I principali ostacoli al progetto green della Commissione sono due: evitare da un lato che le grandi aziende manifatturiere del continente, costrette a sopportare costi maggiori, vengano surclassate dai rivali di altri paesi, come la Cina, che non si fanno remore ambientali e possono produrre a costi inferiori. Dall’altro impedire che le aziende, per restare sul mercato, delocalizzino in paesi meno climaticamente corretti, producendo le emissioni di Co2 su altri territori, azzerando così i benefici per l’ambiente ma al costo di un’ecatombe occupazionale in Europa.
Il problema principale riguarda infatti la competitività dell’intera economia europea. I principali ostacoli al progetto green della Commissione sono due: evitare da un lato che le grandi aziende manifatturiere del continente, costrette a sopportare costi maggiori, vengano surclassate dai rivali di altri paesi, come la Cina, che non si fanno remore ambientali e possono produrre a costi inferiori. Dall’altro impedire che le aziende, per restare sul mercato, delocalizzino in paesi meno climaticamente corretti, producendo le emissioni di Co2 su altri territori, azzerando così i benefici per l’ambiente ma al costo di un’ecatombe occupazionale in Europa.
Per sviscerare questi problemi e trovare possibili soluzioni, la commissione sul Commercio internazionale del Parlamento europeo ha incaricato il Cepii, think tank francese tra i più rinomati al mondo, di realizzare uno studio. Agli esperti è stato chiesto di trovare uno strumento per raggiungere tre obiettivi: a) ridurre le emissioni in Europa mantenendo la competitività della sua economia, b) incentivare altri paesi a seguire la stessa strada e c) evitare il cosiddetto “carbon leakage” (fuga di carbonio).
 Quest’ultimo fenomeno si può verificare in due modi: diretto, come già visto, quando un’azienda delocalizza la produzione, spostando semplicemente l’emissione di gas serra da un paese all’altro; indiretto, quando la riduzione dell’utilizzo dei combustibili fossili porta a una diminuzione del loro prezzo e, di conseguenza, all’aumento del loro utilizzo soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Lo strumento su cui sta ragionando l’Unione Europea, e che dovrebbe essere presentato a luglio, è il cosiddetto Cbam (Carbon Border Adjustment Mechanism) ed è sostanzialmente un dazio doganale: per scoraggiare la delocalizzazione, si stabilisce un prezzo al carbonio utilizzato per produrre un bene e si richiede, a chi lo importa nell’Unione Europea, di pagarlo.
Quest’ultimo fenomeno si può verificare in due modi: diretto, come già visto, quando un’azienda delocalizza la produzione, spostando semplicemente l’emissione di gas serra da un paese all’altro; indiretto, quando la riduzione dell’utilizzo dei combustibili fossili porta a una diminuzione del loro prezzo e, di conseguenza, all’aumento del loro utilizzo soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Lo strumento su cui sta ragionando l’Unione Europea, e che dovrebbe essere presentato a luglio, è il cosiddetto Cbam (Carbon Border Adjustment Mechanism) ed è sostanzialmente un dazio doganale: per scoraggiare la delocalizzazione, si stabilisce un prezzo al carbonio utilizzato per produrre un bene e si richiede, a chi lo importa nell’Unione Europea, di pagarlo.
La tassa rende meno conveniente andare all’estero a produrre, invoglia allo stesso tempo i paesi più inquinanti a migliorare le proprie politiche ambientali per sfuggire al balzello green, riduce il rischio di “carbon leakage” e rende più accettabile ed equo agli occhi degli imprenditori europei la transizione ecologica.
 La proposta, all’apparenza perfetta, nasconde però problemi difficilmente risolvibili: 1) innanzitutto è quasi impossibile stabilire l’esatto contenuto di carbonio delle importazioni, dal momento che a causa della globalizzazione il prodotto finale viene assemblato con pezzi provenienti da tutto il mondo, e l’esportatore non ha nessun interesse a rivelarlo; 2) non risolve il problema della fuga di carbonio indiretta; 3) la tassa alla dogana potrebbe violare i princìpi dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) e scatenare infinite dispute legali.
La proposta, all’apparenza perfetta, nasconde però problemi difficilmente risolvibili: 1) innanzitutto è quasi impossibile stabilire l’esatto contenuto di carbonio delle importazioni, dal momento che a causa della globalizzazione il prodotto finale viene assemblato con pezzi provenienti da tutto il mondo, e l’esportatore non ha nessun interesse a rivelarlo; 2) non risolve il problema della fuga di carbonio indiretta; 3) la tassa alla dogana potrebbe violare i princìpi dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) e scatenare infinite dispute legali.
Nessuno salva il pianeta da solo
Quest’ultimo non è un rischio remoto: nel 2010 l’India dichiarò preventivamente che avrebbe portato davanti al Wto qualsiasi tassa sul carbonio. Quando nel 2012 poi Bruxelles ha esteso il sistema Ets a tutti i voli che arrivavano o partivano dall’Unione, 23 paesi (tra i quali Stati Uniti, Cina, Giappone e Russia) hanno minacciato ritorsioni commerciali, costringendo l’Europa a fare marcia indietro.
 In uno studio a parte dedicato soltanto a questo tema, il Cepii delinea uno scenario allarmante: dopo l’introduzione del Cbam, l’export europeo calerebbe verso tutti i paesi extra Ue di circa il 2 per cento, mentre gli altri paesi subirebbero danni ancora maggiori. Si calcolano perdite da 2 miliardi per gli Stati Uniti, 1,8 miliardi per la Russia e 1 miliardo per la Cina. Solo le ritorsioni commerciali di questi paesi verso l’Unione Europea, senza contare i contenziosi legali davanti al Wto, causerebbero ai Ventisette una perdita di almeno 6 miliardi di dollari.
In uno studio a parte dedicato soltanto a questo tema, il Cepii delinea uno scenario allarmante: dopo l’introduzione del Cbam, l’export europeo calerebbe verso tutti i paesi extra Ue di circa il 2 per cento, mentre gli altri paesi subirebbero danni ancora maggiori. Si calcolano perdite da 2 miliardi per gli Stati Uniti, 1,8 miliardi per la Russia e 1 miliardo per la Cina. Solo le ritorsioni commerciali di questi paesi verso l’Unione Europea, senza contare i contenziosi legali davanti al Wto, causerebbero ai Ventisette una perdita di almeno 6 miliardi di dollari.
Per superare questi problemi, l’Europa potrebbe applicare una tassa sul carbonio di lieve entità, spiega il Cepii nelle sue conclusioni, ma così annullerebbe di fatto il beneficio ambientale del Cbam. Bruxelles deve trovare una soluzione all’enigma e in fretta. In mancanza di un meccanismo efficace che aggiusti gli squilibri, infatti, il risultato sarebbe disastroso sia per l’economia che per l’ambiente. Secondo una simulazione realizzata dall’Università di Copenaghen, il Green Deal europeo, unito all’inazione degli altri paesi, produrrà questi effetti: per ogni tonnellata di Co2 non emessa dall’Europa, il 61,5 per cento sarà comunque immesso nell’atmosfera in qualche altro paese del mondo. Il beneficio ambientale, rispetto agli sforzi fatti, sarà dunque irrisorio.
 L’inferiore competitività dei produttori europei porterà inoltre le aziende ad aumentare le importazioni con conseguenze devastanti sulla bilancia commerciale e sull’occupazione. Conclude l’autore dello studio, il professore Yu Wusheng: «La transizione green nell’Unione Europea non può da sola ridurre le emissioni globali di gas serra. Bisogna trovare delle strade per far salire a bordo gli altri paesi».
L’inferiore competitività dei produttori europei porterà inoltre le aziende ad aumentare le importazioni con conseguenze devastanti sulla bilancia commerciale e sull’occupazione. Conclude l’autore dello studio, il professore Yu Wusheng: «La transizione green nell’Unione Europea non può da sola ridurre le emissioni globali di gas serra. Bisogna trovare delle strade per far salire a bordo gli altri paesi».
Le incredibili promesse di Pechino
Si potrebbe a questo punto notare che la Cina, in realtà, ha fatto un mucchio di promesse per ridurre l’effetto dei cambiamenti climatici. Il problema è che il regime comunista è inaffidabile. Quest’anno, infatti, per la prima volta la Cina è arrivata a emettere più Co2 di tutti i paesi Ocse messi assieme.
 Secondo il Global Energy Monitor, la Cina ha 1.082 centrali a carbone attive. Per mantenere gli impegni presi, dovrebbe chiuderne nei prossimi dieci anni 588. Invece ne sta attualmente costruendo altre 92 e progettando 135. Se nel 2020 il mondo ha spento centrali a carbone per un totale di 37,8 gigawatt in meno, la Cina ne ha costruite per un totale di 38,4 gigawatt in più, vanificando quindi gli sforzi di tutti.
Secondo il Global Energy Monitor, la Cina ha 1.082 centrali a carbone attive. Per mantenere gli impegni presi, dovrebbe chiuderne nei prossimi dieci anni 588. Invece ne sta attualmente costruendo altre 92 e progettando 135. Se nel 2020 il mondo ha spento centrali a carbone per un totale di 37,8 gigawatt in meno, la Cina ne ha costruite per un totale di 38,4 gigawatt in più, vanificando quindi gli sforzi di tutti.
Per Xie Chunping, membro del Grantham Research Institute on Climate Change, se la Cina vuole mantenere le sue promesse deve ridurre le sue emissioni del 66 per cento entro il 2030. Ma quest’anno le emissioni del Dragone sono aumentate ancora. Proprio perché quella europea rischia di essere una pericolosa corsa solitaria (anche sugli Stati Uniti non c’è da mettere la mano sul fuoco), il Green Deal avrà notevoli ripercussioni internazionali, geopolitiche e di sicurezza, come sottolineato da uno studio approfondito dell’European Council on Foreign Relations.
 Nel 2019 l’Unione Europea ha importato prodotti energetici per 320 miliardi di euro. Verso Bruxelles è diretto il 20 per cento delle esportazioni globali di petrolio. Che cosa accadrà quando l’utilizzo dei combustibili fossili, che rappresenta circa il 75 per cento del mix energetico europeo, verrà azzerato o seriamente ridotto? Entro il 2030, le importazioni europee di carbone diminuiranno del 71-77 per cento, quelle di petrolio del 23-25 per cento, quelle di gas naturale del 13-19 per cento. Dopo il 2030, le seconde diminuiranno del 78-79 per cento e le ultime del 58-67 per cento.
Nel 2019 l’Unione Europea ha importato prodotti energetici per 320 miliardi di euro. Verso Bruxelles è diretto il 20 per cento delle esportazioni globali di petrolio. Che cosa accadrà quando l’utilizzo dei combustibili fossili, che rappresenta circa il 75 per cento del mix energetico europeo, verrà azzerato o seriamente ridotto? Entro il 2030, le importazioni europee di carbone diminuiranno del 71-77 per cento, quelle di petrolio del 23-25 per cento, quelle di gas naturale del 13-19 per cento. Dopo il 2030, le seconde diminuiranno del 78-79 per cento e le ultime del 58-67 per cento.
Instabilità e nuove dipendenze
La decarbonizzazione europea farà verosimilmente crollare il prezzo del petrolio colpendo duramente, e potenzialmente destabilizzando, paesi come Russia (ma solo nel lungo periodo, grazie alla sua ingente disponibilità di gas naturale), Venezuela e Nigeria, che hanno costi di estrazione molto alti. La Russia dal canto suo sarà spinta tra le braccia della Cina, dalla quale «diventerà sempre più dipendente» per esportare petrolio e gas naturale, per quanto a prezzi ridotti.
 L’Algeria, il terzo fornitore di gas naturale dell’Europa, vedrà ridursi drasticamente quelle esportazioni che oggi coprono il 60 per cento del suo budget nazionale. Potrebbe diventare una delle basi della produzione di idrogeno verde per l’Europa, ma se non accadrà la destabilizzazione, causata da fenomeni interni o esterni come il terrorismo islamico, e potenzialmente la colonizzazione da parte di Pechino, saranno dietro l’angolo. Lo stesso vale per un paese come la Libia. Il Green Deal provocherà anche enormi problemi di sicurezza.
L’Algeria, il terzo fornitore di gas naturale dell’Europa, vedrà ridursi drasticamente quelle esportazioni che oggi coprono il 60 per cento del suo budget nazionale. Potrebbe diventare una delle basi della produzione di idrogeno verde per l’Europa, ma se non accadrà la destabilizzazione, causata da fenomeni interni o esterni come il terrorismo islamico, e potenzialmente la colonizzazione da parte di Pechino, saranno dietro l’angolo. Lo stesso vale per un paese come la Libia. Il Green Deal provocherà anche enormi problemi di sicurezza.
Se da un lato l’Europa si affrancherebbe dalla dipendenza dai combustibili fossili – oggi l’Unione deve importare l’87 per cento del petrolio e il 74 per cento del gas naturale che consuma – dall’altro cadrebbe in una nuova dipendenza: quella dalle terre rare e dai minerali indispensabili per produrre batterie e pannelli fotovoltaici. Con una cruciale differenza: i combustibili fossili possono essere importati da molteplici paesi, minerali e terre rare no.
 Il 62 per cento delle materie prime indispensabili a portare avanti la rivoluzione verde viene oggi importata dalla Cina. Il secondo fornitore, in ordine di grandezza, è la Russia, che provvede soltanto all’8 per cento del fabbisogno. Secondo una analisi di Bloomberg New Energy Finance, la produzione globale del polisilicio, fondamentale per realizzare le celle fotovoltaiche dei pannelli solari, è in mano a Pechino.
Il 62 per cento delle materie prime indispensabili a portare avanti la rivoluzione verde viene oggi importata dalla Cina. Il secondo fornitore, in ordine di grandezza, è la Russia, che provvede soltanto all’8 per cento del fabbisogno. Secondo una analisi di Bloomberg New Energy Finance, la produzione globale del polisilicio, fondamentale per realizzare le celle fotovoltaiche dei pannelli solari, è in mano a Pechino.
Attualmente, il 95 per cento dei pannelli solari prodotti nel mondo è fatto di polisilicio che proviene dal Xinjiang (dove il regime sfrutta il lavoro forzato degli uiguri, tra l’altro). Il Pnrr di Mario Draghi prevede di installare 70 gigawatt di potenza da energie rinnovabili, soprattutto solare ed eolico, entro il 2030. Come farà a decuplicare gli sforzi, dal momento che oggi l’Italia installa solo 1 gigawatt all’anno, è un mistero. Ma ad ogni modo, il governo dovrebbe tappezzare di pannelli solari oltre 200 mila ettari, quasi il 2 per cento della superficie coltivata in Italia.
Esiste un piano per non legarsi mani e piedi alla Cina?
Un Dragone a batterie
 Anche il mercato delle batterie al litio di ultima generazione, indispensabili per le auto elettriche che dovrebbero sostituire nei piani europei quelle a benzina e gasolio entro il 2035, è in mano a Pechino. La Cina produce il 60 per cento della grafite mondiale e sebbene possegga appena l’1 per cento del cobalto mondiale, ha comprato negli anni 8 delle 14 miniere di cobalto più grandi del Congo, responsabile del 60 per cento della produzione globale.
Anche il mercato delle batterie al litio di ultima generazione, indispensabili per le auto elettriche che dovrebbero sostituire nei piani europei quelle a benzina e gasolio entro il 2035, è in mano a Pechino. La Cina produce il 60 per cento della grafite mondiale e sebbene possegga appena l’1 per cento del cobalto mondiale, ha comprato negli anni 8 delle 14 miniere di cobalto più grandi del Congo, responsabile del 60 per cento della produzione globale.
Inoltre, i cinesi controllano l’80 per cento del mercato della raffinazione del cobalto. Per quanto riguarda il litio, la Cina è uno dei cinque paesi con maggiore disponibilità e sta acquistando quote nel resto del mondo. Ad esempio, la cinese Tianqi Lithium possiede ormai il 51 per cento della più grande riserva di litio al mondo, la miniera australiana di Greenbushes. La stessa società nel 2018 ha speso 4 miliardi di dollari per diventare il secondo investitore del più grande produttore di litio in Cile.
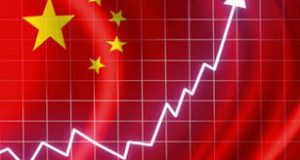 Il Dragone non domina solo il mercato dei minerali indispensabili alla realizzazione delle batterie, ma anche quello della produzione delle batterie stesse: secondo un rapporto di Benchmark Mineral Intelligence, attualmente dispone di 93 megafabbriche ed entro il 2030 ne avrà 140, contro le 17 europee e le 10 americane. Questo predominio non mette però a rischio soltanto i posti di lavoro nel settore automotive europeo e americano.
Il Dragone non domina solo il mercato dei minerali indispensabili alla realizzazione delle batterie, ma anche quello della produzione delle batterie stesse: secondo un rapporto di Benchmark Mineral Intelligence, attualmente dispone di 93 megafabbriche ed entro il 2030 ne avrà 140, contro le 17 europee e le 10 americane. Questo predominio non mette però a rischio soltanto i posti di lavoro nel settore automotive europeo e americano.
Lo ha spiegato al Washington Post William Acker, direttore esecutivo di Ny-Best, organizzazione che promuove lo sviluppo del settore negli Stati Uniti: «Il Pentagono vuole ridurre i costi e utilizzare le batterie per i veicoli militari dell’esercito. Ma se noi abbiamo bisogno delle batterie per condurre le nostre operazioni militari e tutte le nostre batterie provengono dalla Cina, la situazione è preoccupante».
Gli effetti del predominio cinese, in termini di tecnologia e minori costi del lavoro, non si sono fatti attendere. La francese Keolis, specializzata nel trasporto pubblico, dopo aver vinto un appalto da 900 milioni di euro per rifornire l’Olanda del più grande ordine singolo mai commissionato al mondo di autobus elettrici per trasporto urbano, ben 300, ha affidato la costruzione di 259 mezzi alla cinese Byd. Il Pnrr italiano prevede ad esempio il rinnovo del parco autobus composto da 5.540 mezzi secondo i nuovi criteri green: li faremo costruire tutti alla Cina?
La guerra alla plastica e altri scherzi

Nella speranza che Bruxelles abbia chiari quali sono i pericoli di inseguire il mito della decarbonizzazione in solitudine, resta un problema di fondo legato alla consueta natura litigiosa dell’Unione Europea. Alcuni paesi membri utilizzano infatti l’ambiente come scusa per condurre guerre commerciali all’interno del continente.
L’esempio più lampante riguarda proprio il nostro paese: il 31 maggio la Commissione europea ha pubblicato nuove linee guida che obbligano a ridurre a partire dal 3 luglio il consumo di piatti, bicchieri, posate e imballaggi di plastica (ma anche di carta ricoperti da un velo di plastica), mettendo così a serio rischio un comparto dove l’Italia è leader. Sono 50 mila i lavoratori impiegati.
Il ministro Giancarlo Giorgetti ha protestato contro «l’approccio ideologico che lascia sul terreno morti e feriti, in termini di fallimenti aziendali e disoccupazione». Il problema principale riguarda il fatto che l’Italia, in nome del rispetto dell’ambiente, si è specializzata nella produzione di plastica biodegradabile, ma l’Europa ha deciso di accettare solo quella riciclabile.
 La scelta non è affatto neutra e c’è il sospetto che la direttiva sia stata caldeggiata dai paesi nordici, soprattutto Svezia e Finlandia, ricchi di foreste e importanti produttori di carta. Sono gli stessi paesi che in barba a ogni evidenza ambientale hanno fatto inserire nella tassonomia verde, cioè l’elenco delle attività che per l’Unione possono ricevere finanziamenti green, la combustione della biomassa.
La scelta non è affatto neutra e c’è il sospetto che la direttiva sia stata caldeggiata dai paesi nordici, soprattutto Svezia e Finlandia, ricchi di foreste e importanti produttori di carta. Sono gli stessi paesi che in barba a ogni evidenza ambientale hanno fatto inserire nella tassonomia verde, cioè l’elenco delle attività che per l’Unione possono ricevere finanziamenti green, la combustione della biomassa.
Oltre 500 scienziati hanno scritto in una lettera inviata a Bruxelles: «Come si può considerare green l’attività di bruciare gli alberi?». Si può, se fa comodo ad alcuni paesi. Allo stesso modo è stato rinviato il giudizio, per non danneggiare rispettivamente Germania e Francia, sulle dubbie qualità ambientali di gas naturale e nucleare.
 Davanti a queste contraddizioni, viene da chiedersi se il mito del green, nella sua declinazione pericolosa e ideologica che sembra caratterizzare il piano della Commissione europea, sia solo una scusa utilizzata da alcuni (Cina) per distruggere i propri competitor internazionali, e da altri (Germania, Francia, paesi nordici) per danneggiare i rivali interni (Italia).
Davanti a queste contraddizioni, viene da chiedersi se il mito del green, nella sua declinazione pericolosa e ideologica che sembra caratterizzare il piano della Commissione europea, sia solo una scusa utilizzata da alcuni (Cina) per distruggere i propri competitor internazionali, e da altri (Germania, Francia, paesi nordici) per danneggiare i rivali interni (Italia).
Se non apporta i dovuti correttivi, l’Europa potrebbe pentirsi amaramente in futuro della sua “rivoluzione”, disastrosa per l’economia, pericolosa per la sicurezza e poco efficace per l’ambiente.




