 Articolo pubblicato su Avvenire il 6 agosto 2000
Articolo pubblicato su Avvenire il 6 agosto 2000
di Maurizio Blondet
Patrick Keyes O’Clery, irlandese, aveva 18 anni quando nel 1867 si arruolò tra gli Zuavi per difendere il Papa: partecipò alla battaglia di Mentana dall’altra parte, ossia contro i garibaldini. A 21 anni, nel 1870, è nel selvaggio West americano a caccia di bisonti. Ma appreso che l’esercito italiano si prepara a invadere lo Stato Pontificio, torna a precipizio: il 17 settembre ’70 è a Roma di nuovo.
E’ filtrato tra le linee italiane con due compagni, un nobile inglese e un certo Tracy, futuro deputato del Congresso Usa. In tempo per partecipare, contro i Bersaglieri, ai fatti di Porta Pia. Tornato in Inghilterra ed eletto parlamentare, si batterà per l’autonomia dell’Irlanda. Nel 1880 abbandona la politica per dedicarsi all’avvocatura. Morirà nel 1913, avendo lasciato due volumi sulla storia dell’unificazione italiana.
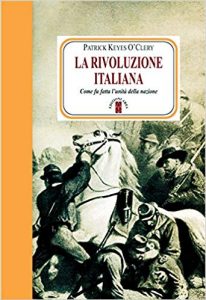 L’opera, che le edizioni Ares di Milano manderanno in libreria alla fine di agosto (Patrick K. O’Clery, La Rivoluzione italiana. Come fu fatta l’unità della nazione, 780 pagine, 48 mila lire), sarà presentata al prossimo Meeting di Rimini giovedì 24 agosto. Opera stupefacente degna del suo avventuroso autore, dovrebbe essere letta nelle scuole italiane: e non solo come esempio di revisionismo storico precoce e antidoto alla mitologia del Risorgimento.
L’opera, che le edizioni Ares di Milano manderanno in libreria alla fine di agosto (Patrick K. O’Clery, La Rivoluzione italiana. Come fu fatta l’unità della nazione, 780 pagine, 48 mila lire), sarà presentata al prossimo Meeting di Rimini giovedì 24 agosto. Opera stupefacente degna del suo avventuroso autore, dovrebbe essere letta nelle scuole italiane: e non solo come esempio di revisionismo storico precoce e antidoto alla mitologia del Risorgimento.
Vedere l’Italia con l’occhio di uno straniero di cultura anglosassone – allora il centro culturale e politico del mondo – risulterà salutare. Esempio. A proposito del brigantaggio del Sud, stroncato in anni spietati dal Regno d’Italia, O’Clery riporta voci di dibattiti parlamentari a Torino. Il deputato Ferrari, liberale, che nel novembre 1862 grida in aula: «Potete chiamarli briganti, ma combattono sotto la loro bandiera nazionale; potete chiamarli briganti, ma i padri di quei briganti hanno riportato due volte i Borboni sul trono di Napoli…
 E’ possibile, come il governo vuol far credere, che 1.500 uomini comandati da due o tre vagabondi tengano testa ad un esercito regolare di 120 mila uomini? Ho visto una città di 5 mila abitanti completamente distrutta: e non dai briganti» (Ferrari allude a Pontelandolfo, paese raso al suolo dal regio esercito il 13 agosto 1861).
E’ possibile, come il governo vuol far credere, che 1.500 uomini comandati da due o tre vagabondi tengano testa ad un esercito regolare di 120 mila uomini? Ho visto una città di 5 mila abitanti completamente distrutta: e non dai briganti» (Ferrari allude a Pontelandolfo, paese raso al suolo dal regio esercito il 13 agosto 1861).
O Clery riferisce i dubbi di Massimo D’Azzeglio («non certo un reazionario») che nel 1861 si domanda come mai «al sud del Tronto» sono necessari «sessanta battaglioni e sembra non bastino»: «Deve esserci stato qualche errore; e bisogna cangiare atti e principii e sapere dai Napoletani, una volta per tutte, se ci vogliono o no… agli Italiani che, rimanendo italiani, non volessero unirsi a noi, credo non abbiamo diritto di dare delle archibugiate».
 Persino Nino Bixio, autore dell’eccidio di Bronte, nel ’63 proclamò in Parlamento: «Un sistema di sangue è stato stabilito nel Mezzogiorno… C’è l’Italia là, signori, e se volete che l’Italia si compia, bisogna farla con la giustizia, e non con l’effusione di sangue». O’Clery non manca di registrare giudizi internazionali sulla repressione.
Persino Nino Bixio, autore dell’eccidio di Bronte, nel ’63 proclamò in Parlamento: «Un sistema di sangue è stato stabilito nel Mezzogiorno… C’è l’Italia là, signori, e se volete che l’Italia si compia, bisogna farla con la giustizia, e non con l’effusione di sangue». O’Clery non manca di registrare giudizi internazionali sulla repressione.
Disraeli alla Camera dei Comuni, nel 1863: «Desidero sapere in base a quale principio discutiamo sulle condizioni della Polonia e non ci è permesso discutere su quelle del Meridione italiano. E’ vero che in un Paese gli insorti sono chiamati briganti e nell’altro patrioti, ma non ho appreso in questo dibattito alcun’altra differenza tra i due movimenti» .
O’Clery fornisce alcune cifre. Tra il maggio 1861 e il febbraio 1863, l’esercito italiano ha catturato «con le armi» e perciò fucilato 1.038 rivoltosi; ne ha uccisi in combattimento 2.413; presi prigionieri 2.768. Inoltre, «secondo Bonham, console inglese a Napoli, sistematicamente favorevole ai piemontesi, c’erano almeno 20 mila prigionieri politici nelle carceri napoletane», ma secondo altre stime 80 mila. I più – indovinate – in attesa di giudizio, o addirittura del primo interrogatorio, «senza sapere di cosa fossero accusati», in celle sovraffollate: testimonianza di Lord Henry Lennox, un turista di rango che nel 1863 visitò appunto le prigioni di Napoli.
 Altro esempio: la politica finanziaria del neonato Regno d’Italia. Non vi stupirà sapere che l’Italia anche allora covava un deficit mostruoso. O’Clery fornisce dati precisi di bilancio. Ma basterà un suo dato: il deficit del Regno nel 1866 fu di 800 milioni di lire, «cifra pari alla metà delle entrate della Gran Bretagna e Irlanda», ossia del Paese allora più ricco d’Europa. Deficit coperto da «prestiti e ipoteche sui beni nazionali, vendita di beni demaniali e istituzione di monopoli», ovviamente coperti da stranieri, prodromo e causa della durevole dipendenza italiana da interessi finanziari estranei.
Altro esempio: la politica finanziaria del neonato Regno d’Italia. Non vi stupirà sapere che l’Italia anche allora covava un deficit mostruoso. O’Clery fornisce dati precisi di bilancio. Ma basterà un suo dato: il deficit del Regno nel 1866 fu di 800 milioni di lire, «cifra pari alla metà delle entrate della Gran Bretagna e Irlanda», ossia del Paese allora più ricco d’Europa. Deficit coperto da «prestiti e ipoteche sui beni nazionali, vendita di beni demaniali e istituzione di monopoli», ovviamente coperti da stranieri, prodromo e causa della durevole dipendenza italiana da interessi finanziari estranei.
 «Altra grande risorsa fu la rapina ai danni della Chiesa» la confisca dei beni e degli ordini religiosi , «che nel solo 1867 fruttò 600 milioni». La condizione della Chiesa nel Regno viene così riassunta dal nostro irlandese: «Esilio e arresto di vescovi; proibizione di pubblicare le encicliche papali; detenzione di preti e sorveglianza della loro predicazione; soppressione di capitoli e benefici e incameramento dei beni; chiusura di seminari; leva obbligatoria per i seminaristi; rimozione delle immagini religiose sulle vie e divieto di processioni».
«Altra grande risorsa fu la rapina ai danni della Chiesa» la confisca dei beni e degli ordini religiosi , «che nel solo 1867 fruttò 600 milioni». La condizione della Chiesa nel Regno viene così riassunta dal nostro irlandese: «Esilio e arresto di vescovi; proibizione di pubblicare le encicliche papali; detenzione di preti e sorveglianza della loro predicazione; soppressione di capitoli e benefici e incameramento dei beni; chiusura di seminari; leva obbligatoria per i seminaristi; rimozione delle immagini religiose sulle vie e divieto di processioni».
Se il lettore d’oggi troverà in questo riassunto qualche tratto anacronisticamente sovietico, non è tutto. Leggendo O’Clery, finirà per chiedersi se i cronici mali italiani che siamo abituati a considerare «retaggi borbonici» (ottusità amministrativa, inefficienza e improvvisazione, centralismo autoritario) o persino «fascisti» (tracotanza guerrafondaia) non sarebbero invece da ribattezzarsi savoiardi o piemontesi.
 L’enorme deficit del regno, scrive O’Clery, è dovuto alle spese per mantenere «il più grande esercito d’Europa» e formare «una marina imponente per numero e qualità», nel tentativo di «recitare il ruolo di grande potenza». Quel costoso esercito fu come noto sconfitto dagli austriaci a Custoza, per l’insipienza dell’«eroe» Lamarmora (ma anche Garibaldi, che proclamò di prendere Monaco «in quindici giorni», fu bloccato in Trentino da pochi jaeger).
L’enorme deficit del regno, scrive O’Clery, è dovuto alle spese per mantenere «il più grande esercito d’Europa» e formare «una marina imponente per numero e qualità», nel tentativo di «recitare il ruolo di grande potenza». Quel costoso esercito fu come noto sconfitto dagli austriaci a Custoza, per l’insipienza dell’«eroe» Lamarmora (ma anche Garibaldi, che proclamò di prendere Monaco «in quindici giorni», fu bloccato in Trentino da pochi jaeger).
L’enorme flotta corazzata subì a Lissa la nota umiliante sconfitta, contro navi di legno. Poteva mancare il ricorso all’iniqua pressione fiscale? Non mancò. «nel Regno delle Due Sicilie la tassazione era, nel 1859, di 14 franchi a testa. Nel 1866, sotto il nuovo regime, le tasse erano salite fino a 28 franchi a testa, il doppio di quanto pagava l’”oppresso” popolo napoletano prima che Garibaldi venisse a liberarlo».
 La tassa sul macinato, bersaglio polemico dei patrioti mazziniani quando l’applicava il governo pontificio, «fu più che raddoppiata ed estesa a tutte le granaglie, perfino alle castagne». Causa la fiscalità, vi stupirà sapere che fu necessario organizzare «la lotta all’evasione»? Fu organizzata, e manu militari.
La tassa sul macinato, bersaglio polemico dei patrioti mazziniani quando l’applicava il governo pontificio, «fu più che raddoppiata ed estesa a tutte le granaglie, perfino alle castagne». Causa la fiscalità, vi stupirà sapere che fu necessario organizzare «la lotta all’evasione»? Fu organizzata, e manu militari.
I contribuenti in arretrato subivano «perquisizioni domiciliari» e durante queste «visite», che evidentemente duravano giorni e notti, avevano l’obbligo di cedere ai soldati «i letti migliori» nelle loro case. Ciò non impedì che il Regno restasse sempre in pericolo d’insolvenza.
Tanto che i titoli del debito pubblico italiano «si vendono a 33 punti sotto il loro valore nominale», al contrario del debito napoletano, che «fino al 1866 era così solido, che i suoi titoli si ponevano al di sopra del nominale». Si dirà: il prezzo fu alto, ma almeno il Sud fu raggiunto dalla modernità, i piemontesi portarono un’amministrazione più razionale; saranno stati ottusi, ma erano incorruttibili. No.
«La contabilità pubblica si trovava in condizione spaventosa, ordini di pagamento non autorizzati apparivano continuamente nei registri della Corte dei Conti», e il caos favoriva «malversazioni di ogni genere».
 O’Clery cita: «Nel 1865 il ricevitore generale delle imposte a Palermo fuggì con 70 mila franchi; a Torino fu scoperta una stamperia di tagliandi del debito pubblico e un impiegato delle Finanze, processato per ciò, fu assolto… L’anno 1866 portò alla luce frodi degli impiegati incaricati della vendita di beni ecclesiastici; a Napoli un alto ufficiale di polizia fu arrestato per essersi appropriato di fondi destinati ai pubblici servizi. Casi simili se ne possono citare all’infinito», conclude O’Clery: e chissà perché, noi spettatori di Tangentopoli 1992, siamo inclini a credergli sulla parola.
O’Clery cita: «Nel 1865 il ricevitore generale delle imposte a Palermo fuggì con 70 mila franchi; a Torino fu scoperta una stamperia di tagliandi del debito pubblico e un impiegato delle Finanze, processato per ciò, fu assolto… L’anno 1866 portò alla luce frodi degli impiegati incaricati della vendita di beni ecclesiastici; a Napoli un alto ufficiale di polizia fu arrestato per essersi appropriato di fondi destinati ai pubblici servizi. Casi simili se ne possono citare all’infinito», conclude O’Clery: e chissà perché, noi spettatori di Tangentopoli 1992, siamo inclini a credergli sulla parola.
Ma almeno uno stato militaresco, mise ordine nel disordine pubblico del Meridione? Stroncò la mafia? Serafico O’Clery dà la parola alla Guida della Sicilia – una guida turistica per inglesi, scritta da un certo Murray, che metteva in guardia: «Le strade siciliane non sono più sicure come al tempo del governo borbonico, il quale, pur con tutti i suoi errori, ebbe il merito di rendere le sue strade sicure come quelle del Nord Europa». Piacerebbe non crederci. Attribuire questi racconti all’animo papalino e «reazionario» dello storico. Purtroppo, qualcosa lo impedisce. L’Italia vista dagli occhi di O’Clery ci appare sinistramente familiare. Per noi lettori del Duemila, l’effetto è un déjà vu.




