 International Family News 28 Febbraio 2021
International Family News 28 Febbraio 2021
Andrea Venanzoni parla del suo libro «Ipotesi neofeudale»
Federico Cenci
Potere pubblico arroccato nei privilegi e colossi del digitale che vanno facendosi essi stessi Stato. È questo lo scoraggiante scenario futuro che Andrea Venanzoni, avvocato e professore di Giurisprudenza nell’Università di Roma Tre, tratteggia nel libro Ipotesi neofeudale. Libertà, proprietà e comunità nell’eclissi globale degli Stati nazionali. Non tutto è però perduto. L’autore, che collabora con la Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine, evoca anche una terza espressione che tutela libertà individuali e collettive, legge naturale, tradizione, famiglia, proprietà e libertà d’impresa: enclave territoriali interconnesse tra loro. Di questo parla ad “iFamNews”.
Professore, la degenerazione ha inizio allorquando «l’unica filosofia accettabile è il decostruzionismo». Ce ne parli…
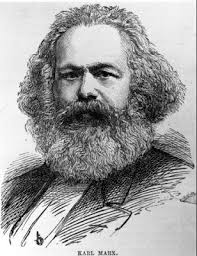 A partire dalla fine degli anni 1960 l’avanzamento di una suadente, ma non per questo meno pericolosa forma di post-marxismo nelle università ha iniziato ad aggredire, decostruendo ogni elemento fondante, il concetto complessivo di società, di autorità, di proprietà privata e di libertà. Il decostruzionismo non è il frutto estemporaneo di una moda culturale, bensì la risultante, più o meno coerente, di questo percorso che, di anno in anno, è andato sedimentandosi in accademia e nel dibattito pubblico.
A partire dalla fine degli anni 1960 l’avanzamento di una suadente, ma non per questo meno pericolosa forma di post-marxismo nelle università ha iniziato ad aggredire, decostruendo ogni elemento fondante, il concetto complessivo di società, di autorità, di proprietà privata e di libertà. Il decostruzionismo non è il frutto estemporaneo di una moda culturale, bensì la risultante, più o meno coerente, di questo percorso che, di anno in anno, è andato sedimentandosi in accademia e nel dibattito pubblico.
Se si prende, per esempio, l’impatto che l’opera del filosofo francese Jacques Derrida (1930-2004), principalmente Forza di legge, ma anche quelle di Gilles Deleuze (1925-1995) e di Pierre-Félix Guattari (1930 -1992), filosofo il primo e psicoanalista il secondo, francesi, hanno esercitato su una parte della scienza del diritto nordamericana, conosciuta come «Critical legal studies» (su cui consiglio la lettura del volume del giurista statunitense Gary Minda, Teorie postmoderne del diritto), ci si rende conto di come la tendenziale «aggressione» culturale a canoni essenziali della società si sia trasformata in un relativismo complessivo che sgretola e che frammenta tutto.
La risultante, come quella di ogni relativismo, è una deriva oscillante e incerta in cui nulla più è sacro. All’individuo si sostituisce la collettività indistinta e alla libertà una declinazione totalizzante di eguaglianza.
È da qui che nasce quella che definisce «proliferazione dei diritti civili»?
 In questa prospettiva i diritti diventano solo dispositivi di complicazione sloganistica, totalmente slegati da una pretesa autentica pienamente esigibile: si individua un soggetto nuovo (in genere per motivazioni afferenti la convenienza ideologica) e gli si riconosce un diritto che però, strutturalmente, è solo un postulato enfatico e non un diritto vero.
In questa prospettiva i diritti diventano solo dispositivi di complicazione sloganistica, totalmente slegati da una pretesa autentica pienamente esigibile: si individua un soggetto nuovo (in genere per motivazioni afferenti la convenienza ideologica) e gli si riconosce un diritto che però, strutturalmente, è solo un postulato enfatico e non un diritto vero.
Lo hanno rilevato nel corso del tempo il filoso italiano Norberto Bobbio (1909-2004) e più di recente il costituzionalista italiano Alfonso Celotto: l’età dei diritti è una rincorsa cieca e bulimica verso i non-diritti. Non basta infatti riconoscere e proclamare una data situazione come diritto: servono implementazione, costruzione di un sistema di esigibilità e finanziamento di una politica funzionale al riconoscimento del diritto. Decostruire è la negazione totale di questo processo.
Quanto influisce oggi il «capitalismo immateriale» su questa deriva antropologica?
 Negli Stati Uniti d’America è ormai invalsa la definizione di «woke capitalism», una espressione che sottende un’agenda progressista da parte delle grandi corporation che spesso piegano i propri brand, e la propria azione commerciale e pubblicitaria, affinché incarni e veicoli messaggi politicamente corretti. Spesso ossessivamente politicamente corretti. Si tratta di grandissime società, la cui posizione dominante è stata propiziata proprio dallo Stato e dai suoi interventi, mediante errori di regolazione e invasioni della sfera pubblica: questo incistamento tra logica pubblica e capitalismo deviante rispetto all’autentica logica concorrenziale di mercato prende anche il nome di «crony capitalism» (traducibile con «capitalismo clientelare»), spesso a braccetto con il «woke capitalism».
Negli Stati Uniti d’America è ormai invalsa la definizione di «woke capitalism», una espressione che sottende un’agenda progressista da parte delle grandi corporation che spesso piegano i propri brand, e la propria azione commerciale e pubblicitaria, affinché incarni e veicoli messaggi politicamente corretti. Spesso ossessivamente politicamente corretti. Si tratta di grandissime società, la cui posizione dominante è stata propiziata proprio dallo Stato e dai suoi interventi, mediante errori di regolazione e invasioni della sfera pubblica: questo incistamento tra logica pubblica e capitalismo deviante rispetto all’autentica logica concorrenziale di mercato prende anche il nome di «crony capitalism» (traducibile con «capitalismo clientelare»), spesso a braccetto con il «woke capitalism».
Per «capitalismo immateriale» si intende molto spesso – penso all’accezione che ne dà l’imprenditore e informatico italiano Stefano Quintarelli – il sistema di produzione connesso al digitale. Ecco, nel digitale delle grandi compagnie hi-tech vi è la sublimazione del politicamente corretto, del «woke capitalism» e del «crony capitalism»: sono un grande sostenitore di innovazione, inventiva, creatività e delle idee che, in origine, erano alla base delle compagnie del digitale le quali però, da tempo, e complice anche l’intervento statale, sono divenute dei semi-Stati privati.
Quale ruolo giocano questi «semi-Stati privati»?
 Di recente, sia in Ipotesi neofeudale, sia scrivendone per la Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine, li ho comparati alla Compagnia delle Indie: soggetti formalmente privati che però finiscono per sperimentare, attraverso incentivi e privilegi commerciali, la replica strutturale di funzioni pubbliche. Fra sistemi di giustizia interni e tentazione di battere propria moneta è evidente che questi social inizino a divenire, nei fatti, una forma sublimata di Stato a base privata.
Di recente, sia in Ipotesi neofeudale, sia scrivendone per la Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine, li ho comparati alla Compagnia delle Indie: soggetti formalmente privati che però finiscono per sperimentare, attraverso incentivi e privilegi commerciali, la replica strutturale di funzioni pubbliche. Fra sistemi di giustizia interni e tentazione di battere propria moneta è evidente che questi social inizino a divenire, nei fatti, una forma sublimata di Stato a base privata.
Ma si badi: uno Stato privato che però non ha per matrice la volontà dei consociati, non è una enclave che nasca da transazioni e da scambi, bensì qualcosa in cui, se all’inizio è dato un vincolo contrattuale, poi, sul lungo periodo, emerge un’asimmetria latamente coercitiva. È parecchio evidente, per esempio, quando i social media maneggiano libertà e diritti costituzionali. Si pensi al caso del presidente Donald J. Trump espunto da tutti i social.
Questa forma di capitalismo distorta e paradossalmente anticapitalistica penetra nel profondo della società e degli individui, permeandone e plasmandone i comportamenti. Si pensi alla enorme questione della profilazione, del data-mining, su cui di recente la psicologa sociale statunitense Shoshana Zuboff ha pubblicato Il capitalismo della sorveglianza.
Cosa sono i cripto-Stati?
 L’espressione «cripto-Stati» indica in genere il decentramento funzionale radicale, importato dalla tecnologia avanzata. Blockchain e crypto-currency concorrono a una sorta di federalizzazione della governance, destrutturando lo Stato-nazione e proponendo l’emersione di nicchie digitali che, sempre più spesso, si arricchiscono di valenza politica. In Ipotesi neofeudale l’espressione indica la strutturazione di enclave che prescindono dalla omogeneità dell’ordinamento singolo-nazionale e si assemblano su coordinate contrattuali comuni, basate su transazioni volontarie, autodifesa, tecnologia, riconoscimento delle specificità locali e territoriali.
L’espressione «cripto-Stati» indica in genere il decentramento funzionale radicale, importato dalla tecnologia avanzata. Blockchain e crypto-currency concorrono a una sorta di federalizzazione della governance, destrutturando lo Stato-nazione e proponendo l’emersione di nicchie digitali che, sempre più spesso, si arricchiscono di valenza politica. In Ipotesi neofeudale l’espressione indica la strutturazione di enclave che prescindono dalla omogeneità dell’ordinamento singolo-nazionale e si assemblano su coordinate contrattuali comuni, basate su transazioni volontarie, autodifesa, tecnologia, riconoscimento delle specificità locali e territoriali.
Quindi digitale e reale si compenetrano fino a dare un panorama istituzionale distinto rispetto a quello del potere pubblico classico. Il federalismo radicale è la forma più elevata di riconoscimento della libertà, e la libertà è sempre assunzione di responsabilità: l’anarchia in fondo non è mai sbraco, ma anzi, al contrario, auto-disciplina, secondo logica di mercato e produzione.
 Chiaramente non mi riferisco all’anarchia collettivistica di matrice comunista, ma alla tradizione dell’anarchismo individualista statunitense. Nello Stato il burocrate maneggia risorse non proprie e cura interessi collettivi: per questo la risultante delle sue scelte e le sue azioni non si riverberano direttamente sulle sue spalle, il che non aiuta propriamente a sentirsi davvero responsabili. Al contrario l’imprenditore sopporta direttamente i costi delle proprie scelte. In una enclave basata su scelte volontarie e transazioni private è evidente che si dovrà stare molto più attenti a ciò che si fa, giacché ogni errore lo si paga in prima persona.
Chiaramente non mi riferisco all’anarchia collettivistica di matrice comunista, ma alla tradizione dell’anarchismo individualista statunitense. Nello Stato il burocrate maneggia risorse non proprie e cura interessi collettivi: per questo la risultante delle sue scelte e le sue azioni non si riverberano direttamente sulle sue spalle, il che non aiuta propriamente a sentirsi davvero responsabili. Al contrario l’imprenditore sopporta direttamente i costi delle proprie scelte. In una enclave basata su scelte volontarie e transazioni private è evidente che si dovrà stare molto più attenti a ciò che si fa, giacché ogni errore lo si paga in prima persona.
Scrive che è a rischio la proprietà privata. È minacciata anche la famiglia? Nella sua opera più celebre, L’azione umana, l’economista austriaco naturalizzato statunitense Ludwig von Mises (1881-1973) scrive: «se l’esperienza storica potesse insegnarci qualcosa, sarebbe che la proprietà privata è inestricabilmente connessa alla civiltà». È innegabile che, sin dall’importante centro abitato neolitico anatolico di Çatal Hüyük, e dalle prime forme di civilizzazione stabile e sedentaria, la proprietà privata abbia esplicato una valenza assai più profonda e incisiva di quella di un mero diritto economico.
 Si pensi d’altronde alla concezione che il filosofo inglese John Locke (1632-1704), ne Il secondo Trattato sul governo, ha della proprietà privata: una proprietà così intensa e profonda da divenire un paradigma di auto-proprietà. È quindi evidente che, laddove la proprietà privata viene svilita, denigrata e limitata, si assista all’emersione di un potere che stritola e che colpisce certamente anche la famiglia. D’altronde sempre Mises avvertiva che la scomparsa della proprietà privata prelude al potere totalitario.
Si pensi d’altronde alla concezione che il filosofo inglese John Locke (1632-1704), ne Il secondo Trattato sul governo, ha della proprietà privata: una proprietà così intensa e profonda da divenire un paradigma di auto-proprietà. È quindi evidente che, laddove la proprietà privata viene svilita, denigrata e limitata, si assista all’emersione di un potere che stritola e che colpisce certamente anche la famiglia. D’altronde sempre Mises avvertiva che la scomparsa della proprietà privata prelude al potere totalitario.
La scomparsa della proprietà non è casuale: è propugnata da quelle dottrine, come il marxismo, che tendono a guardare con ampio sospetto la famiglia stessa. In fondo ne Il Manifesto del partito comunista, i fondatori tedeschi del comunismo Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895) propugnano l’abolizione della famiglia. Oggi uno Stato sempre più assistenzialista aggredisce tanto la proprietà quanto la famiglia. Penso al blocco degli sfratti: una misura in apparenza “umanitaria”, ma che finisce per colpire i proprietari di casa.
La vulgata vede nel proprietario di casa solo uno sfruttatore, uno speculatore, mentre molto spesso si tratta di persone che vivono letteralmente potendo contare sulla locazione di un immobile. C’è un ideologismo distorto che propugna solo logiche di assistenzialismo parassitario, che guarda con favore indulgente alle occupazioni degli immobili e in tutto questo si assiste anche all’attacco ai valori della famiglia, alla sua funzione sostanziale di cellula essenziale della società. La famiglia intesa come società naturale è sempre più sotto attacco, proprio come la proprietà privata.
Cosa sono quelle che definisce «isole di libertà»?
 Le «isole di libertà» sono enclave che maturano consapevolezza e adombrano fisionomie sempre più evidenti in un contesto, come l’attuale, di disgregazione degli ordinamenti. Processo, questo, accelerato dalla pandemia: la finitezza spaziale, la reclusione, la connessione digitale tra distinte aree e città hanno fatto emergere un processo già in fieri da tempo.
Le «isole di libertà» sono enclave che maturano consapevolezza e adombrano fisionomie sempre più evidenti in un contesto, come l’attuale, di disgregazione degli ordinamenti. Processo, questo, accelerato dalla pandemia: la finitezza spaziale, la reclusione, la connessione digitale tra distinte aree e città hanno fatto emergere un processo già in fieri da tempo.
L’economista statunitense Murray N. Rothbard (1926-1995) parla di «nazioni per consenso». Io direi che se si guarda il processo imperfetto di nation-building si deve ammettere che ogni città, ogni comune, ogni campanile, rappresenta, in Italia, un sistema sociale e culturale differenziato che dovrebbe essere valorizzato con libertà e riconoscimento delle specificità, non con l’asfissiante assistenzialismo centralistico che tende a omogeneizzare tutto e troppo stesso ad annegare le aree più evolute e produttive sotto una spessa coltre di tasse.
 Credo nel mercato e nella sua libertà, nei diritti individuali, nella inventiva, nella concorrenza e nella sana competitività, nella responsabilità, e ritengo che una enclave davvero libera dovrebbe basarsi su questi paradigmi. Lo statalismo tende a dipingere questa visione come eccessiva. Sentendo parlare di privatizzazione, per esempio, si storce il naso: si pensa sempre all’arbitrio, alla prevaricazione e si ritiene che solo la sfera statale possa permettere a tutti di fruire di un bene.
Credo nel mercato e nella sua libertà, nei diritti individuali, nella inventiva, nella concorrenza e nella sana competitività, nella responsabilità, e ritengo che una enclave davvero libera dovrebbe basarsi su questi paradigmi. Lo statalismo tende a dipingere questa visione come eccessiva. Sentendo parlare di privatizzazione, per esempio, si storce il naso: si pensa sempre all’arbitrio, alla prevaricazione e si ritiene che solo la sfera statale possa permettere a tutti di fruire di un bene.
In realtà, come dimostra l’orizzonte decadente delle nostre città, la sfera statale non riesce a gestire i beni; si pensi ai parchi “pubblici”, spesso degradati e invivibili. Al contrario, se a gestirli fosse un privato, facendo pagare un biglietto , si può essere ben certi che quei parchi sarebbero curati, attrattivi e sicuri. Per me la libertà deve essere effettiva.
Sono libero di frequentare un parco pubblico abbandonato, sporco e magari invaso da soggetti poco raccomandabili? Sono libero solo in teoria, ma nei fatti non ci andrei mai in quel parco. In questo senso nelle città il maggior numero di beni e di servizi dovrebbero andare ai privati: e non è solo questione di efficienza economica, ma davvero di libertà.




