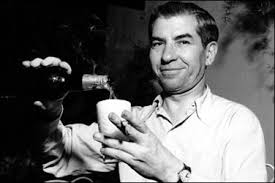il Giornale Mercoledì 19 agosto 1992
Viaggio nell’«onorata società» dall’unificazione nazionale ad oggi -1 / La miopia delle autorità sabaude e le spedizioni militari in Sicilia
MAFIA, COME SI LEGALIZZA UN CRIMINE
La Destra storica tenta la via della repressione, la Sinistra chiama a Palazzo gli uomini d’onore
di Marco Travaglio
Cosa Nostra. Onorata Società, Mano Nera, Grande Mamma, Piovra. Quanta ipocrisia lessicale, pur di non chiamarla col suo vero nome. L’omertà, in Sicilia è una cosa seria serissima. E allora, niente meraviglia se nessuno storico della mafia è ancora riuscito a ricostruirne le origini etimologiche e la data di nascita. Ogni leggenda è buona. Ottima per alimentare quell’aura di romanticismo e di mistero che affascina tanta gente, la soggioga, la narcotizza. E la induce alla complicità, al silenzio.
 BEATI PAOLI E DINTORNI – Il mito più intrigante è quello che rimanda tutto al Beati Paoli: una società segreta nata intorno al 1185 per vendicare i soprusi dei nobili feudali contro la povera gente. Così chiamata perché gli adepti andavano vestiti come i monaci di San Francesco da Paola. Di giorno, narrano le cronache, stavano «entra li chiesi a diri lu rusariu (pri finzioni)», ma di notte si davano convegno nei sotterranei di Palermo per tramare sanguinose vendette. Firmate con il marchio inconfondibile dalla mano armata di pugnale, o delle due spade incrociate e sormontate dal crocifisso, insieme al motto «Et iniquitates non prevalebunt».
BEATI PAOLI E DINTORNI – Il mito più intrigante è quello che rimanda tutto al Beati Paoli: una società segreta nata intorno al 1185 per vendicare i soprusi dei nobili feudali contro la povera gente. Così chiamata perché gli adepti andavano vestiti come i monaci di San Francesco da Paola. Di giorno, narrano le cronache, stavano «entra li chiesi a diri lu rusariu (pri finzioni)», ma di notte si davano convegno nei sotterranei di Palermo per tramare sanguinose vendette. Firmate con il marchio inconfondibile dalla mano armata di pugnale, o delle due spade incrociate e sormontate dal crocifisso, insieme al motto «Et iniquitates non prevalebunt».
Come ha scritto Denis Mack Smith, «Beati Paoli potevano essere o non essere delle organizzazioni serie. Ma senza dubbio esistevano a Palermo gruppi di delinquenti che imponevano tributi tanto ai contadini quanto ai signori». Insomma, nel primo Ottocento «tutti gli ingredienti della mafia erano già presenti, tranne la parola». Nel 1838 don Pietro Ulloa, procuratore generale a Trapani, vergava un allarmatissimo rapporto per il governo borbonico di Napoli: «Non c’è impiegato in Sicilia che non sia prostrato al cenno di un prepotente e che non abbia pensato a trarre profitto dal suo ufficio. Questa generale corruzione ha fatto ricorrere il popolo a rimedi oltremodo strani e pericolosi. Ci sono In molti paesi delle fratellanze, specie di sette che diconsi partiti, senz’altro legame che quello della dipendenza di un capo, che qui è un possidente, là un arciprete. Una cassa comune sovviene ai bisogni, ora di far esonerare un funzionario, ora di conquistarlo, ora di proteggerlo, ora di incolpare un innocente. Il popolo è venuto a convenzione con i rei».
«Come accadono furti, escono dei mediatori a offrire transazioni per il recupero degli oggetti rubati. Molti alti magistrati coprono queste fratellanze di una protezione impenetrabile. Non è possibile indurre le guardie cittadine a perlustrare le strade, né di trovare testimoni per i reati commessi in pieno giorno. Al centro di tale stato di dissoluzione c’è una capitale con il suo lusso e le sue pretensioni feudali in mezzo al XIX secolo, città nella quale vivono 40 mila proletari, la cui sussistenza dipende dal lusso e dal capricci dei grandi. In questo ombelico della Sicilia si vendono gli uffici pubblici, si corrompe la giustizia, si fomenta l’ignoranza». La mafia c’è già; manca la parola
MAFIA CON DUE EFFE – Anche sull’etimologia ce n’è per tutti i gusti, il primo vocabolario Siciliano che registrala parola mafia, è quello del Traina (1868): e la dà come importata in Sicilia dai «piemontesi»,
Cioè dai funzionari e soldati venuti in Sicilia dopo Garibaldi, ma proveniente forse dalla Toscana dove maffia vuol dire miseria e smaferi sgherri. Altri la fanno Invece derivare dall’arabo (mu’afah, forza protetta; mahais, spaccone; Ma’aftr, una tribù che conquistò Palermo), dal greco (morphe, prestante), dal latino (maleficia), dal francese (Maujais, i seguaci del dio Maufe; o mafier, ingozzare), dal piemontese (malaffare). Ma c’è anche chi pensa che le mafie fossero le cave di tufo dove si radunavano i carbonari trapanesi, oppure quelle i cui «picciotti» accolsero Garibaldi sbarcato a Marsala con i Mille. Per non parlare di chi vi legge una sigla: «Morte Al Francesi Italia Anela» (coniata nel 1282, durante i Vespri siciliani), o addirittura «Mazzini Autorizza Furti Incendi Avvelenamenti» (di età risorgimentale).
E chi favoleggia di un tal Turiddu Mafia, padre fondatore della consorteria. Comunque siano andate le cose, è certo che nell’Isola, a metà dell’Ottocento, la parola mafia esprimeva un concetto di superiorità coraggio, intraprendenza, violenza individuale. Ma sempre circondata da un alone di rispetto, di ammirazione, di timore reverenziale: allora i briganti furoreggiavano nei romanzi d’appendice, dipinti come intrepidi giustizieri dei poveri contro i soprusi del ricchi e dei potenti. Al punto che Dumas, nel suo «Pasquale Bruno», poteva scrivere: «In Paesi come la Spagna e l’Italia, dove la cattiva organizzazione della società porta sempre a respingere e mantenere in basso chi è nato in basso, chi si trova in quelle condizioni si ribella contro questa ingiustizia divina, decide di farsi da se stesso difensore del debole e nemico del potente. Ecco perché il bandito spagnolo e quello italiano sono figure cosi poetiche e cosi popolari.
E il più grande studioso di tradizioni popolari siciliane, Giuseppe Pitré, poteva sostenere che «la mafia non è setta né associazione, non ha regolamenti né statuto: è la coscienza del proprio essere, l’esagerato concetto della forza individuale». Qualcosa di simile, insomma, alla balentia dei sardi. Tutto fuorché una banda armata.
 «MAFIUSI» A TEATRO – L’inventore della mafia come associazione a delinquere si chiama Giuseppe Rizzotto: il romanziere siciliano che nel 1862 scrisse e portò in scena un drammone popolare, «I mafiusi de la Vicaria». Narrava la storia delle bravate di una ghenga di frequentatori abituali del carcere di Palermo, la «Vicaria» appunto. Un polpettone quasi inguardabile. Ma gratificato da un enorme successo anche nel Continente (vi volle assistere persino il principe ereditario Umberto di Savoia). E molto istruttivo: fotografava finalmente ciò che era diventata la mafia, una setta in piena regola, con tanto di rituali, leggi, segni di riconoscimento. E delitti a catena. Ovviamente ci fu chi bollò Rizzotto come «traditore della Sicilia», al soldo dei denigratori piemontesi. Ad esempio il suo ben più noto Collega Luigi Capuana, per il quale la mafia non era che un innocuo e comprensibile «spirito di insofferenza per le prepotenze».
«MAFIUSI» A TEATRO – L’inventore della mafia come associazione a delinquere si chiama Giuseppe Rizzotto: il romanziere siciliano che nel 1862 scrisse e portò in scena un drammone popolare, «I mafiusi de la Vicaria». Narrava la storia delle bravate di una ghenga di frequentatori abituali del carcere di Palermo, la «Vicaria» appunto. Un polpettone quasi inguardabile. Ma gratificato da un enorme successo anche nel Continente (vi volle assistere persino il principe ereditario Umberto di Savoia). E molto istruttivo: fotografava finalmente ciò che era diventata la mafia, una setta in piena regola, con tanto di rituali, leggi, segni di riconoscimento. E delitti a catena. Ovviamente ci fu chi bollò Rizzotto come «traditore della Sicilia», al soldo dei denigratori piemontesi. Ad esempio il suo ben più noto Collega Luigi Capuana, per il quale la mafia non era che un innocuo e comprensibile «spirito di insofferenza per le prepotenze».
Di tutt’altro parere magistrati come l’agrigentino Alessandro Mirabile, che proprio in quegli anni preparava le requisitorie dei primi processi alla mafia, sulla scorta delle confessioni del primo «pentito» che si ricordi. L’uomo si chiamava Bernardino Verro: dopo aver aderito in gioventù alla onorata società ne era uscito per iscriversi al nascente movimento socialista dei Fasci siciliani, ed aveva consegnato ai giudici un memoriale pieno di informazioni preziosissime. Il pover uomo pagherà con la vita il suo «sgarro» all’onorata società: lo troveranno cadavere, il 3 novembre 1915, in una stradina di Corleone, di cui era appena diventato sindaco. A quarantott’anni. Il primo «infame» morto ammazzato di una lunga catena.
Intanto, tre anni dopo il suo ingresso nei vocabolari dialettali, la parola mafia aveva fatto il suo esordio in un documento ufficiale, e nel suo significato più autentico: il rapporto del prefetto di Palermo Filippo Antonio Gualtiero, inviato il 25 aprile 1865 al ministro dell’Interno. «I liberali nel 1848, i Borboni nella restaurazione, i garibaldini nel 1880», mandava a dire il prefetto, «ebbero tutti la stessa necessità, si macchiarono tutti della medesima colpa: leganti a quest’associazione malandrinesca detta mafia. Sicché l’altitudine e la necessità della trista associazione la tenne sempre dipendente dai partiti».
IL GOVERNO NON CAPISCE – Distratte, lontane e impreparate, le autorità sabaude fan di tutta l’erba un fascio. E assimilano la mafia alle bande sanfediste e antiunitarie che in quegli anni scorrazzano nel Meridione dando filo da torcere all’esercito. Problema militare, insomma. Cosi, dal 1863, la legge contro il brigantaggio è estesa alla Sicilia, dove giunge alla testa delle truppe regie il generale Gavone. Il quale non trova di meglio che cingere d’assedio Palermo, Girgenti, Trapani e Caltanissetta, provocandovi la rivolta. La Sicilia è messa a ferro e fuoco per una settimana dal 16 al 22 settembre 1866.
 Poi la repressione del generale Cadorna, tanto spietata da costringere il governo ad inviare sul posto una commissione d’inchiesta: la prima di una lunga serie. I lavori si concludono nel giro di una decina di giorni, con vaghe e generiche proposte di sussidi ed opere pubbliche. L’anno seguente, il 1868, un altro generale si affaccia sullo stretto di Messina è Luigi Medici, luogotenente generale con poteri straordinari, per soffocare gli ultimi fermenti. Anch’egli, Invece di scandagliare a fondo l’organizzazione mafiosa si preoccupa soprattutto di reprimere e liquidare i partiti di opposizione al governo: non tanto i borbonici, quanto i democratici garibaldini. Accusati, questi ultimi, di aver scatenato la rivolta in combutta con la mafia ed elementi dell’Ancien Régime. Nel 1871, il «generalissimo» chiede ed ottiene una legge speciale, che gli consente di infliggere l’«ammonizione» (una forma di vigilanza speciale) o il domicilio coatto (in un’isola deserta) a chiunque sia sospettato o denunciato come «sovversivo». Una legge che non serve a recidere le radici della malapianta mafiosa. Anzi, tutto li contrario.
Poi la repressione del generale Cadorna, tanto spietata da costringere il governo ad inviare sul posto una commissione d’inchiesta: la prima di una lunga serie. I lavori si concludono nel giro di una decina di giorni, con vaghe e generiche proposte di sussidi ed opere pubbliche. L’anno seguente, il 1868, un altro generale si affaccia sullo stretto di Messina è Luigi Medici, luogotenente generale con poteri straordinari, per soffocare gli ultimi fermenti. Anch’egli, Invece di scandagliare a fondo l’organizzazione mafiosa si preoccupa soprattutto di reprimere e liquidare i partiti di opposizione al governo: non tanto i borbonici, quanto i democratici garibaldini. Accusati, questi ultimi, di aver scatenato la rivolta in combutta con la mafia ed elementi dell’Ancien Régime. Nel 1871, il «generalissimo» chiede ed ottiene una legge speciale, che gli consente di infliggere l’«ammonizione» (una forma di vigilanza speciale) o il domicilio coatto (in un’isola deserta) a chiunque sia sospettato o denunciato come «sovversivo». Una legge che non serve a recidere le radici della malapianta mafiosa. Anzi, tutto li contrario.
I PALAZZI DEI VELENI – La luogotenenza usa il pretesto della mafia per abusi e soprusi di ogni genere. Operazioni di «repulisti» politico, più che di lotta alla malavita. Scoppiano cosi i primi contrasti tra la polizia e una parte della magistratura, che insorge contro le soperchierie del Medici e dei suoi uomini. I veleni di Palermo giungono fin sulla scrivania dei ministro dell’interno Giovanni Lanza, che si vede recapitare una denuncia riservata sulla condotta del questore di Palermo, Albanese, accusato di insabbiare sistematicamente le inchieste, occultare le prove, minacciare i testimoni, assoldare sgherri e picciotti, promuovere tacite conciliazioni tra assassini mafiosi e parenti delle loro vittime.
Partono le solite inchieste, ma il questore resiste. Finché, nel 1869, non vengono trovati morti ammazzati due testimoni scomodi, che si apprestavano a denunciare le illegalità commesse da alcuni agenti. La magistratura palermitana spicca un mandato di cattura contro il questore, che viene processato. Ma le condanne piovono soltanto sulle teste di alcuni suoi sottoposti. Lui se la cava per insufficienza di prove.
Il procuratore generale di Palermo, Diego Tajani, deluso e amareggiato per quella sentenza scandalosa, lascia il suo posto e torna all’avvocatura, per poi essere eletto alla Camera nel 1874 nelle file democratiche. Sarà proprio lui, l’anno seguente, a puntare il dito contro il governo della destra con un discorso rimasto famoso: «Dal 1860 al 1866 non avete fatto che offendere abitudini secolari, suscettibilità anche puntigliose di popolazioni che erano disposte a ricambiare con un tesoro d’affetti un governo che avesse saputo studiarle e conoscerle. Invece oggi manca in Sicilia un’idea esatta della parola governo. Bisogna ricostituirla, questa idea: bisogna accerchiarla di un’aureola imponente, perché se non si comincia da questo non si farà mai nulla».
Per tutta risposta, il ministro dell’Interno Nicotera, inasprisce la repressione del brigantaggio, vara altre misure eccezionali, spedisce nell’Isola la seconda commissione d’inchiesta. Ancor più inconcludente della prima: «Il fenomeno malioso», si legge nella relazione finaie, «è un pervertimento sociale, residuo dell’antico regime, determinato anche dalla riluttanza delle popolazioni a lasciarsi modificare dalle nuove istituzioni». La mafia come appendice dei Borboni, dunque. Nulla di più superficiale, sbagliato, fuorviarne.
I PERCHE’ DELLA MAFIA – Come ha scritto Leonardo Sciascia, la mafia era, già allora, qualcosa di ben più complesso e originale: «Un movimento che si può paragonare al passaggio da una società feudale ad una società borghese. Quel passaggio che in Francia si realizzò attraverso la Rivoluzione del 1789 e In altri Paesi, attraverso quello che fu detto l’assolutismo illuminato». La Sicilia non conobbe né l’una né l’altro: «La terra passò dal baroni al “borghesi”… attraverso operazioni di tipo mafioso. I contadini promossi a campieri (specie di carabinieri del f eudo alle dipendenze del barone) e da campieri a “gabellotti” (cioè ad affittuari delle terre), intimorendo i baroni, facendo loro del prestiti con usure ingenti, derubandoli del reddito, riuscirono ad impadronirsi della terra. Ma, servi divenuti padroni, i loro vizi furono quelli dei loro antichi padroni: volevano soltanto la terra, terra quanto più estesa possibile. E si contentavano del reddito che la terra aveva sempre dato. Non volevano trasformarla, bonificarla, migliorarla. Il reddito della terra veniva investito in altra terra… Insomma, la classe borghese-mafiosa non sa costruire: sa soltanto divorare. Da ciò deriva che all’interno di tale classe c’è un continuo conflitto, un continuo processo di sostituzione. I delitti della mafia sono perciò, di solito, interni: conflitti tra una nuova generazione e la vecchia, tra gruppi che sono già arrivati al potere, alla ricchezza, al decoro, e gruppi che vogliono arrivare. L’ “arrivo”, dunque, spesso coincide con l’annientamento (anche fisico), con la fine».
eudo alle dipendenze del barone) e da campieri a “gabellotti” (cioè ad affittuari delle terre), intimorendo i baroni, facendo loro del prestiti con usure ingenti, derubandoli del reddito, riuscirono ad impadronirsi della terra. Ma, servi divenuti padroni, i loro vizi furono quelli dei loro antichi padroni: volevano soltanto la terra, terra quanto più estesa possibile. E si contentavano del reddito che la terra aveva sempre dato. Non volevano trasformarla, bonificarla, migliorarla. Il reddito della terra veniva investito in altra terra… Insomma, la classe borghese-mafiosa non sa costruire: sa soltanto divorare. Da ciò deriva che all’interno di tale classe c’è un continuo conflitto, un continuo processo di sostituzione. I delitti della mafia sono perciò, di solito, interni: conflitti tra una nuova generazione e la vecchia, tra gruppi che sono già arrivati al potere, alla ricchezza, al decoro, e gruppi che vogliono arrivare. L’ “arrivo”, dunque, spesso coincide con l’annientamento (anche fisico), con la fine».
E’ con questa organizzazione, prepotente e ramificata, non con presunti residuati del sistema borbonico, che lo Stato italiano, all’indomani dell’Unità, cominciava a fronteggiarsi Ma senza percepirne, per decenni la portata e il pericolo. Eppure due sociologi come Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino, nel 1877, avevano già capito tutto.
E’ stupefacente come la loro inchiesta privata sulla mafia, dopo una visita agli stessi luoghi perlustrati dai miopi onorevoli delle vane commissioni d’inchiesta, sia giunta subito al nocciolo del problema: «Sotto le parvenze politico-amministrative», scriveva Franchetti, «si nasconde spesso il gruppo di mafia: cosicché si rende necessario, direi quasi indispensabile, il bisogno di aderire, cordialmente o per timore, ad una clientela… Qui non si comprende la vita privata e pubblica che si svolga esclusivamente entro il dominio della legge, ma sempre dentro un partito, perché l’uomo onesto è esposto alle vessazioni del primo venuto».
La mafia non come fenomeno occasionale o come residuato di un mondo che agonizza. Ma come conseguenza di certi rapporti sodali ed economici, oltreché della latitanza delle istituzioni
SINISTRA, DI MALE IN PEGGIO. – Se la destra di Lanza e Sella, in gran parte formata da settentrionali, è miope, la sinistra storica – perlopiù meridionale – ci vede benissimo. Ma, dopo il suo avvento al potere (1876), chiude un occhio, se non due. Mentre la Piovra, fino ad allora fenomeno prevalentemente rurale, mette radici nella «conca d’oro» (la zona più fertile intorno a Palermo, dove fioriscono le coltivazioni di agrumi) e allunga anche i suoi tentacoli in città, con i Depretis e i Crispi al governo «inizia – secondo lo storico Salvatore F. Romano – la fase della legalizzazione della mafia».
L’uomo d’onore entra nei palazzi che contano, occupa la poltrona di sindaco e talvolta anche quella di deputato. Francesco De Sanctis, nel 1877, denuncia che «nei consigli comunali, provinciali e parlamentari si formano associazioni di cointeressati i quali, pur nascondendosi sotto una qualsiasi maschera, sono vere associazioni a delinquere. O, se preferite dei mangia con tutti». E Napoleone Colajanni racconterà poco più tardi: «La Sinistra aveva contratto molti debiti politici e morali in sedici anni di lotta contro la destra. Non poteva pagarli che a spese della cosa pubblica, a spese soprattutto della giustizia e della legalità. I favori e le ricompense perciò piovvero sugli amici, sui clienti, sui creditori, sotto forma di impieghi, concessioni di ogni genere, di onorificenze cavalleresche… L’ingiustizia, la sopraffazione, la violazione della legge fecero capo sistematicamente al deputato o al candidato governativo».
La mafia sta col governo, dunque. E dà una mano a Crispi (anche lui buon amico di diversi boss) quando, dimentico delle sue origini democratiche, il «Bismarck all’italiana» reprime nei sangue il movimento dei Fasci siciliani. Il 10 dicembre 1893 campieri e mafiosi aprono il fuoco, a Giardinelle, contro i braccianti che tentano di occupare le terre. Il giorno di Natale, undici morti a Lercara. All’alba del Capodanno ’94, le guardie campestri (al soldo degli uomini d’onore) sparano ancora: sette morti. Un’indagine rivelerà poi che quei colpi di lupara sono partiti dalla casa del sindaco mafioso. Ma il regime Crispino fa di tutto per insabbiare le inchieste che ne seguono, segretamente riconoscente. E i processi si chiudono con una raffica di «insufficienza di prove».
Di lì a poco il governo scioglierà i Fasci, proclamando lo stato d’assedio. Ma senza neppure toccare le cosche (cosca è, in origine, la corona di foglie del carciofo). Anzi, non c’è deputato siculo della sinistra storica che non intrattenga amichevoli rapporti con i mammasantissima, garantendo impunità e favori in cambio di voti: soprattutto dopo la riforma del 1882, che ha quadruplicato il numero degli elettori. Cosi l’onorata società allunga le mani in ogni settore, dall’agricoltura all’industria, dal commercio alla politica. E persino all’alta finanza.
 IL GIALLO NOTARBARTOLO. – Il 1° febbraio 1893, l’ex direttore del Banco di Sicilia di Palermo, il marchese Emanuele Notarbartolo, è assassinato con ventisette coltellate sul diretto Termini Imerese-Palermo, e gettato dal treno in corsa. Per mesi gli inquirenti brancolano nel buio. Poi il figlio della vittima, il guardiamarina Leopoldo Notarbarolo, si decide a raccontare ai giudici ciò che a Palermo sanno anche le pietre: a fare ammazzare suo padre è stato l’onorevole Raffaele Palizzolo, uomo di Crispi eletto a Palermo, noto capomafia, nonché consigliere d’amministrazione dell’istituto di credito nell’occhio del ciclone per lo scandalo delle speculazioni e dei libri contabili falsificati che coinvolge parecchi parlamentari.
IL GIALLO NOTARBARTOLO. – Il 1° febbraio 1893, l’ex direttore del Banco di Sicilia di Palermo, il marchese Emanuele Notarbartolo, è assassinato con ventisette coltellate sul diretto Termini Imerese-Palermo, e gettato dal treno in corsa. Per mesi gli inquirenti brancolano nel buio. Poi il figlio della vittima, il guardiamarina Leopoldo Notarbarolo, si decide a raccontare ai giudici ciò che a Palermo sanno anche le pietre: a fare ammazzare suo padre è stato l’onorevole Raffaele Palizzolo, uomo di Crispi eletto a Palermo, noto capomafia, nonché consigliere d’amministrazione dell’istituto di credito nell’occhio del ciclone per lo scandalo delle speculazioni e dei libri contabili falsificati che coinvolge parecchi parlamentari.
Uno dei killer di Notarbartolo è il ferroviere Giuseppe Fontana vi Villabate, membro della «famiglia» di Palizzolo. E II movente è chiaro come il sole: l’ex banchiere ha denunciato l’onorevole per aver falsificato un mandato di pagamento di 8 mila lire. Denaro che è servito a Palizzolo per finanziarsi la campagna elettorale: se non fosse stato eletto, avrebbe perduto l’immunità parlamentare e subìto un processo per l’assassinio di un suo colono. Prove schiaccianti, dunque.
Tantopiù che Fontana viene arrestato e riconosciuto dal vice capostazione di Termini come «l’uomo dalla faccia dura» salito sul convoglio la sera del delitto. Ma al primo dibattimento, nel ‘94, il testimone ritratta. Seguono altri due processi, uno a Milano nel ‘99, l’altro l’anno seguente a Bologna. Alla fine Palizzolo, arrestato dopo che la Camera ha concesso l’autorizzazione a procedere, è condannato a trent’anni.
Le lunghe udienze sconvolgono il Paese e scoperchiano la maleodorante fogna delle complicità politico-mafiose. Risulta che il generale Mirri, direttore della Pubblica sicurezza e buon amico di Palizzolo, gli ha reso parecchi favori: alla vigilia delle elezioni politiche di Alcamo, nel 1895, ha fatto avere la libertà provvisoria a un certo Saladino, pregiudicato per associazione a delinquere e omicidio, sostenitore del candidato governativo Damiani, con questa raccomandazione: «Bisogna ad ogni costo che Damiani sorta vittorioso dalla lotta, perché Damiani è Crispi».
E l’anno seguente, alle amministrative palermitane, lo stesso Palizzolo ha fatto scarcerare un altro pregiudicato, Matisi, candidato Crispino alla carica di sindaco di un comune alle porte del capoluogo. Dopo la condanna del deputato, nasce subito un «Comitato prò Sicilia» tra i suoi «amici» isolani, che stigmatizzano duramente la sentenza, E il 27 gennaio 1903 la Cassazione annulla tutto. Un anno dopo Palizzolo è assolto dal tribunale di Firenze per «insufficienza di prove». E Corrado Carnevale non è neppure nato.
(1-continua)
_______________________________
Il Giornale Giovedì 20 agosto 1992
Viaggio nell’ «onorata società» dall’unificazione nazionale ad oggi -2 / Le connessioni con la mafia americana e l’intervento di Mussolini
UN PAISA’ E UN PREFETTO CONTRO LE COSCHE
La sfida di Joe Petrosino alla Mano Nera e l’impresa interrotta di Cesare Mori
di Marco Travaglio
Lo chiamano Lupo Solitario, e non a torto. Joe Petrosino è uno di quei detective venuti dalla gavetta che non rispettano granché le forme, ma che badano parecchio alla sostanza. Che non guardano in faccia nessuno, e di nessuno si fidano se non di se stessi. L’uomo più adatto a combattere la Mano Nera. Ossia la potente organizzazione criminosa che, nata per assicurare «protezione» agli emigranti italiani i quali – a cavallo tra Ottocento e Novecento – cercano fortuna (o impunità) In America, si è subito trasformata in una tenibile affiliazione gangsteristica della mafia siciliana, terrorizzando col racket la Little Italy newyorkese e mettendo le mani su tutti gli affari più proibiti e lucrosi del tempo.
DA STRILLONE A DETECTIVE – Nato a Padula, nel Salernitano, nel 1860, Giuseppe Petrosino emigra in America a 13 anni, col padre. E lì, come tutti i paisà (o dago, come li chiamano sprezzantemente gli americani) della Grande Mela, s’arrabatta a lare un po’ di tutto: dal lustrascarpe allo strillone allo spazzino. Poi l’ingresso nella polizia, dove mostra subito coraggio ed abilità investigative da vendere. Primo italiano ad indossare quell’uniforme, è anche l’unico dei 30 mila agenti di New York a capire e parlare la lingua dei dago. Cosi, a capo di un pugno di italo-americani pomposamente battezzati Italian Branch, si getta a capofitto nell’operazione repulisti di Little Italy. Entrando subito in rotta di collisione con la Mano Nera.
Nel giro di pochi anni, questo poliziotto bruttareIlo, tarchiato, alto non più d’un metro e sessanta si guadagna la stima degli italiani perbene, i titoli a tutta pagina dei giornali, l’amicizia personale del presidente Roosevelt. Le sue imprese hanno sempre un che di pittoresco, di misterioso, di thrilling. Maestro nei travestimenti, Joe è solito presentarsi in casa dei boss abbigliato da barbone, da contadino, da manovale, da gangster. Insomma, il classico personaggio da prima pagina. Da film poliziesco. Insofferente alle norme ed al cerimoniali, regala sempre un suo «ricordo» a chiunque passi sotto le sue grinfie: più d’un capomafia, nel suo ufficio, lascia buona parte della dentatura. «Cosi vi ricorderete chi è Petrosino», è il suo rituale commiato.
Tra le centinaia di criminali che in quegli anni fanno i conti con lui, c’è tutto il fior fiore della malavita italo-americana: da Ignazio Lupo a Joe Morello, futuri capi della Mano Nera; da Giovanni Alfano, il boss camorrista coinvolto nel delitto CuocoIo, all’onorevole Palizzolo che, assolto al processo Notarbartolo, ha preferito cambiar aria in America; ma soprattutto don Vito Cascio Ferro, l’uomo che ha inventato in Sicilia ed esportato negli States il racket delle estorsioni. Il primo grande boss dell’Onorata Società siciliana.
DON VITO, SUPERBOSS – Padrino di gran calibro, forse il più noto e potente della prima metà del secolo, don Vito è di due anni più anziano di Joe. Nato a Bisaquino, a due passi da Corleone, è figlio di un «campiere» ed ha imparato a leggere e scrivere solo dopo il matrimonio con una maestrina. Alto e robusto, barba fluente e portamento signorile, si guadagna ben presto il prestigio di «galantuomo» e il tradizionale titolo di «don». Dopo la militanza giovanile nelle file anarchiche (all’epoca dei Fasci siciliani, 1892), che gli procura una condanna e lo costringe a rifugiarsi in Tunisia per un po’, aderisce alla mafia. E già nel ’98 deve rispondere dei reati tipici dell’Onorata Società di allora: abigeato (furto di bestiame), violenza, incendio doloso, sequestro di persona.
Prosciolto per mancanza di indizi, nel 1901 preferisce espatriare oltreoceano. E lì, forte del suo gran prestigio internazionale, assume il controllo della Mano Nera, modernizzandola, collegandola con la mafia palermitana, insegnandole ad autofinanziarsi con un sistema tutto nuovo di sua invenzione: il «pizzo» («fateci bagnare ‘u pizzu», Il becco, dicono i suoi emissari alle vittime designate). Un giorno, però, incappa In Joe Petrosino. Che lo incrimina per il delitto dell’uomo nel barile», uno del gialli più complicati risolti dal piccolo grande detective. Per don Vito sono subito dolori: arrestato, strapazzato e – nonostante l’assoluzione per insufficienza di prove – espulso senza tanti complimenti dall’America. Torna a Palermo, dove non fatica molto per riprendere in mano l’Onorata Società, ripetendo l’opera di riorganizzazione già attuata a New York.
E’ tra gli uomini più ricchi dell’isola, controlla migliaia di voti, è amico e sponsor di politici locali e nazionali. Che lo ricambiano con la croce di cavaliere del Regno eppoi addirittura con la completa riabilitazione, dando un bel colpo di spugna ai reati che macchiano la sua fedina penale. Ora è di nuovo un uomo rispettabile. E «di rispetto». Ma in tasca conserva una foto di Joe Petrosino, e ripete agli «amici»: «Non ho mai ammazzato nessuno, con le mie mani. Ma se mi capita a tiro quello lì, me lo dovete lasciare tutto per me».
L’occasione si presenta nel 1909, quando il poliziotto più famoso del mondo, stufo di reclamare dalle autorità italiane un «filtro» più severo ai permessi d’emigrazione, approda a Palermo per bloccare sul nascere l’espatrio in massa di boss e picciotti verso l’America. E’ in missione segreta, e sotto falso nome: Simone Velletri. Ma il capo della polizia newyorkese spiffera subito tutto ad un quotidiano. E chi «deve» sapere, sa.
 DELITTO NELLA NOTTE – Giunto a Palermo il 28 febbraio, dopo un cordiale e riservato, incontra col capo del governo Giolitti, Petrosino batte in lungo e in largo la Sicilia annotando sui suoi registri i capi d’imputazione dei principali padrini italo-americani, per preparare i provvedimenti di espulsione dagli Usa. Un’operazione che, se andasse in porto, mozzerebbe di netto la Mano Nera. La mafia lo lascia lavorare pochi giorni, poi due o tre killer l’ammazzano con quattro colpi di pistola, la sera del 12 marzo, nella centrale piazza Marina. Si sussurra che, a capeggiare il comando dei sicari, ci sia don Vito in persona. Quella sera è a cena in casa dell’onorevole Domenico De Michele Ferrantelli. Si assenta giusto il tempo di uccidere la sua bestia nera, poi fa ritorno dall’amico, per il caffè. Alibi di ferro. Al processo, il deputato giura che don Vito non s’è mosso un istante dalla sua tavola. Cosi, arrestato il 3 aprile 1909, Cascio Ferro è prosciolto con tante scuse due anni dopo, insieme ai 14 presunti complici. E riprende la normale attività, in grande stile.
DELITTO NELLA NOTTE – Giunto a Palermo il 28 febbraio, dopo un cordiale e riservato, incontra col capo del governo Giolitti, Petrosino batte in lungo e in largo la Sicilia annotando sui suoi registri i capi d’imputazione dei principali padrini italo-americani, per preparare i provvedimenti di espulsione dagli Usa. Un’operazione che, se andasse in porto, mozzerebbe di netto la Mano Nera. La mafia lo lascia lavorare pochi giorni, poi due o tre killer l’ammazzano con quattro colpi di pistola, la sera del 12 marzo, nella centrale piazza Marina. Si sussurra che, a capeggiare il comando dei sicari, ci sia don Vito in persona. Quella sera è a cena in casa dell’onorevole Domenico De Michele Ferrantelli. Si assenta giusto il tempo di uccidere la sua bestia nera, poi fa ritorno dall’amico, per il caffè. Alibi di ferro. Al processo, il deputato giura che don Vito non s’è mosso un istante dalla sua tavola. Cosi, arrestato il 3 aprile 1909, Cascio Ferro è prosciolto con tante scuse due anni dopo, insieme ai 14 presunti complici. E riprende la normale attività, in grande stile.
E’ il capo indiscusso di tutte le cosche siciliane. Gli onorevoli dell’isola fanno la fila per baciargli le mani. Arriva addirittura ad acquistare una flotta dì pescherecci per traghettare sui mercati nordafricani il bestiame rubato e gli altri bottini della mafia, e ad accompagnare i mafiosi nel mirino della giustizia in alto mare, per l’imbarco clandestino sui bastimenti in rotta verso l’America. Ma che fanno i governi di quegli anni contro l’Onorata Società?
Poco, male e distrattamente. Basti pensare che il protettore di don Vito, l’onorevole Ferrantelli, è un giolittiano di stretta osservanza: esempio tipico del mafioso «vincente», ha sbaragliato appena pochi giorni prima del delitto Petrosino Raffaele Palizzolo, il notabile Crispino legato alle vecchie cosche ormai in disgrazia.
IL SARTO E LA MAFIA – Il fatto è che, nei primi turbinosi vent’anni del secolo, i governi di Roma hanno ben altro a cui pensare che non l’Onorata Società. La vec-chia classe politica dei notabili se ne serve come serbatoio di voti, contro i nascenti partiti di massa (il socialista e il cattolico). Piemontese scettico e culturalmente lontano dal problemi della Sicilia, Giovanni Giolitti rifugge dai provvedimenti straordinari. Né può permettersi il lusso di abbattere il sistema clientelare-mafioso nato sotto i Borboni e perpetuato dai governi della destra eppoi della sinistra storica.
Cinicamente convinto che «un sarto, dovendo tagliare un abito per un gobbo, deve fare la gobba anche all’abito», fa poco o nulla per sradicare la malapianta. Eppure, al di là delle accuse – in parte fondate in parte dettate da opportunismo politico – di Gaetano Salvemini al «ministro della malavita», lo statista non è sospettabile di collusioni mafiose. Semmai, di aver utilizzato con spregiudicatezza gli stessi sistemi dei suoi predecessori e dei suoi successori.
Cosi come Vittorio Emanuele Orlando, il quale però ha l’aggravante di esser eletto in Sicilia: all’Indomani della prima guerra mondiale, con la fresca aureola di Presidente della Vittoria, ad ogni suo rientro nell’isola natia riceve gli omaggi dei principali capicosca fedeli a don Vito; e nel 1924, alla vigilia delle elezioni che lo videro candidato nel «listone» con i fascisti e i nazionalisti, nobilita l’Onorata Società in un discorso a Palermo: «Se per mafia si intende il sentimento dell’onore portato sino all’esasperazione, insofferenza contro la sopraffazione, generosità… allora anch’io mi dichiaro mafioso».
Eppure neanche lui, a quel che risulta, era affiliato all’Onorata Società. Tutto questo per dire con quanta superficialità e impreparazione lo Stato postrisorgimentale affrontava (anzi, non affrontava) la Piovra. Nulla di strano, allora, se in quegli anni don Cascio Ferro accumulò nell’isola un potere Illimitato, da viceré borbonico. Finché, nel 1928, non trovò sulla sua strada un altro simbolo vivente dell’antimafia: Cesare Mori, il prefetto di ferro.
IL PREFETTISSIMO – Figlio di ignoti, «esposto» appena nato in una delle ruote per trovatelli eppoi adottato da una famiglia di Pavia, Cesare Mori studia all’Accademia militare di Torino. Costretto a lasciare l’esercito per aver sposato una ragazza senza dote e dunque impari al suo rango, entra nella Pubblica sicurezza, percorrendovi il cursus honorum di pari passo con l’ascesa al potere di Giolitti.
Dopo una burrascosa parentesi in Emilia Romagna, da dove è allontanato per le proteste dei repubblicani contro la sua presunta «illegale irruenza», arriva per la prima volta a Palermo nel 1903. Qui entra subito in rotta di collisione con la mafia e si guadagna la fama di uomo energico e brutale, ammazzando a fucilate un pericoloso bandito. E durante la guerra, alla testa di un reparto speciale di carabinieri e poliziotti, dà una caccia spietata ai disertori che ingrossano le file del banditismo.
Dopo Caporetto lo chiamano a Torino, per reprimere i moti delle sinistre: è qui che entra nelle grazie di Giolitti, che lo «raccomanda» presso Orlando per la promozione a questore. A Roma nel ’20 e a Bologna, col grado di prefetto, nel ’21, si inimica subito i «ras» fascisti Balbo e Arpinati, che scorazzano con le loro squadracce nella regione, spalleggiati dagli agrari. «Servitore ottuso del governo di Roma», scrive di lui Mussolini sul Popolo d’Italia, «la sua vita non merita una goccia di sangue dell’ultimo fascista di provincia». «Se avessi quattro o cinque tipi come Mori», lo esalta Giolitti, «spazzerei via le camicie nere in pochi giorni».
Ma il futuro Duce ne chiede il trasferimento, il tremebondo Facta cede relegandolo a Bari e Mussolini, all’indomani della marcia su Roma, lo sospende dal servizio attivo. Ma nel 1924 lo richiama in servizio, su consiglio del quadrumviro De Bono, per far guerra alla mafia Le «coppole storte», come allora si fanno chiamare i nuovi picciotti, hanno appoggiato apertamente le camicie nere nella loro ascesa al potere, fiutando in anticipo l’aria che tira. Ma nel maggio ’24, dopo un viaggio nell’isola, il Cavalier Benito decide di tagliar corto con l’Onorata Società: uscito trionfante con il «listone» dalle elezioni del 6 aprile, teme che il nascente regime, in Sicilia, venga identificato con quei personaggi tutt’altro che raccomandabili.
Quegli stessi «galantuomini» che, nel suo viaggio, gli hanno tributato onori e scorte tanto vistosi da apparire addirittura insultanti, per un capo di governo che aspira a creare uno Stato totalitario. Cosi Mori, già bestia nera del fascismo, diventa l’uomo della provvidenza. E, mandato con poteri eccezionali a «far pulizia» in Sicilia, non si fa troppo pregare.
LA MAFIA CAMBIA PELLE – Le cosche che il Superprefetto trova sulla sua strada hanno subito una trasformazione profonda, prima, durante e dopo la guerra. La mafia ottocentesca dei gabellotti e dei campieri, che taglieggiavano da una parte i braccianti e dall’altra i baroni, è un lontano ricordo: ridimensionata, nel suo ruolo di «mediatrice» tra ceti proprietari e contadini, dalle nascenti cooperative rurali rosse e bianche; soppiantata dalle cosche emergenti della nuova malavita piccolo-borghese e cittadina, che ingrassa con il controllo sull’emigrazione clandestina verso l’America e con il monopolio delle attività, economiche lecite e illecite; e sconvolta dai contraccolpi, sociali del primo conflitto mondiale.
Il ritorno a casa dei picciotti «reduci», abituati a maneggiar le armi sul fronte di guerra e smaniosi di ascendere con ogni mezzo nella scala sociale, è per le organizzazioni emergenti un’occasione ghiottissima di sfruttare il malcontento popolare e la disoccupazione dilagante per pescare a piene mani in quel serbatoio di manodopera a poco prezzo. Comincia così una sorda guerra fra la vecchia mafia, conservatrice e legata ai notabili liberali, e quella nuova, che simpatizza per lo squadrismo nazionalista e prefascista affascinata dalla conquista violenta del potere.
La spaccatura è evidente già alle elezioni del 1924, quando l’Ancien Regime mafioso ormai perdente (i gruppi di Alcamo, Castelvetrano, Marsala, Erice), si schiera con Vittorio Emanuele Orlando, mentre i «vincenti» (Palermo e dintorni) stanno con Alfredo Cucco, il giovane medico, già capo dei nazionalisti, che ha subito aderito al fascismo. Oltre che sui piccolo-borghesi insoddisfatti, la nuova mafia in camicia nera può contare anche sugli industriali e gli agrari dell’ ultima generazione, ansiosi di spazzar via — insieme all’ordine costituito – le vecchie caste baronali.
Cosi quando Mussolini visita la Sicilia nel maggio “24, trova ad accoglierlo uno dei padrini più noti, don Ciccio Cuccia, sindaco di Piana dei Greci che si fa fotografare al suo fianco e l’accompagna in tutto il suo viaggio, lamentandosi pure perché il capo del governo s’è circondato di poliziotti motociclisti quando basterebbe lui a garantirgli «il rispetto dei siciliani senza tanti sbirri». E proprio quest’imbarazzante episodio convince il Cavalier Benito che è ora di tagliar la testa alla Piovra.
 OPERAZIONE REPULISTI – Mori approda in Sicilia nel maggio del ’25. In ottobre riceve il decreto con i poteri eccezionali, E si mette subito al lavoro. Gli basta meno di un anno per far tabula rasa della «bassa mafia», quella che con i suoi picciotti e briganti spadroneggia nell’ampia zona montagnosa delle Madonie. Con 800 uomini in assetto di guerra, il «prefettissimo» attacca banditi (Ferrarello. Dino e Andaloro) e mafiosi arroccati su quelle alture, e li sbaraglia. Poi passa al setaccio città e borgate, svuotandole con gigantesche retate e lasciandole – racconterà più tardi – «come se vi fosse stata una frana o un’inondazione». Insomma — sono sempre parole sue – «è uno stato d’assedio in ventiquattresimo».
OPERAZIONE REPULISTI – Mori approda in Sicilia nel maggio del ’25. In ottobre riceve il decreto con i poteri eccezionali, E si mette subito al lavoro. Gli basta meno di un anno per far tabula rasa della «bassa mafia», quella che con i suoi picciotti e briganti spadroneggia nell’ampia zona montagnosa delle Madonie. Con 800 uomini in assetto di guerra, il «prefettissimo» attacca banditi (Ferrarello. Dino e Andaloro) e mafiosi arroccati su quelle alture, e li sbaraglia. Poi passa al setaccio città e borgate, svuotandole con gigantesche retate e lasciandole – racconterà più tardi – «come se vi fosse stata una frana o un’inondazione». Insomma — sono sempre parole sue – «è uno stato d’assedio in ventiquattresimo».
Il proconsole del Duce utilizza con gran disinvoltura confidenti e denunce anonime. E, per stanare i capicosca dell’«alta mafia», ricorre ai mezzi più brutali: confisca patrimoni, sequestra le donne dei latitanti, fa macellare in piazza il bestiame dei sospetti distribuendo la carne ai poveri, mette al suo servizio la magistratura ottenendo condanne quantomeno spicciative (ci sono casi di persone condannate per delitti avvenuti lo stesso giorno, alla stessa ora, a centinaia di chilometri l’uno dall’altro). È una vera «operazione chirurgica»: sua la definizione.
I maxiprocessi si susseguono a tambur battente: due a Palermo, uno a Termini Imerese, uno a Sciacca, 3-400 imputati alla volta. E le carceri di Sicilia, Ustica e Lipari si riempiono di migliaia di mafiosi, veri o presunti Quasi tutti pesci piccoli (detti in gergo «scassapagliari»), ma pure qualche pezzo da novanta, come il vecchio Cascio Ferro e i nuovi boss destinati a succedergli: Calogero Vizzini e il suo delfino Giuseppe Genco Russo. Don Vito è condannato all’ergastolo per concorso morale in due omicidi e contrabbando, e rinchiuso nel carcere di Pozzuoli (dove morirà – pare – di fame e di sete nel 1943, «dimenticato» in cella nelle ore convulse dei bombardamenti alleati). Le cose vanno un po’ meglio per il giovane Genco Russo, che comunque resta al fresco per qualche tempo. E ancor meglio per don Calò Vizzini, il futuro Grande Zio della mafia.
Nato a Villalba nel 1887 da una famiglia di piccoli coltivatori, Calogero mostra fin da ragazzo la sua natura violenta, contendendo a bastonate la più bella figliuola del paese al cancelliere del tribunale.
Precoce anche come mafioso, si specializza subito nell’offrire «protezione» prezzolata contro i briganti ai contadini della zona. Nel 1898 e nel 1903 i primi guai con la giustizia: assolto per insufficienza di prove, come gli capiterà un’altra dozzina di volte nella sua lunga vita. Durante la guerra, il salto di qualità: don Calò e i suoi «amici» accumulano una fortuna speculando sulle requisizioni di animali per l’esercito, nelle quali fanno confluire a prezzi stracciati il bestiame rubato.
Il resto l’ottengono per la via maestra di ogni mafioso che si rispetti: la manipolazione delle aste per gli affitti dei feudi, tramite cooperative agricole create ad hoc e dirette dal fratello prete del boss, don Salvatore, e un po’ da tutto il resto della famiglia.
CESARE CONTRO CALÒ – Quando sull’isola si affaccia il prefetto Mori, Zu Calò è conosciuto e rispettato in tutta la Sicilia, possiede beni e terre per svariati milioni e persino una tenuta alle terme di Chianciano con tanto di società per lo sfruttamento delle acque. Entrato nel mirino del Prefettissimo, viene ancora assolto per la solita mancanza d’indizi Ma Mori non ci bada granché, e lo spedisce ugualmente al confino, prima a Chianciano eppoi a Roma.
Dovrebbe restarci per cinque anni, ma viene liberato quasi subito, per intercessione di un gerarca toscano suo amico, sottosegretario del governo Mussolini, che don Calò ha nascosto in una sua villa quand’era ricercato per omicidio, nel ’22. Cesare Mori, frattanto, avanza con l’irruenza di una schiacciasassi, senza guardare in faccia a nessuno. «La mafia», dice, «è una vecchia puttana che ama strofinarsi alle autorità per adularle, circuirle e incastrarle». E minaccia: «Se i siciliani hanno paura dei mafiosi, li convincerò io che sono il mafioso più forte di tutti».
Alla fine, i più danneggiati dal ciclone Mori saranno proprio i nuovi mafiosi, i più temibili, spregiudicati e intraprendenti: quelli in camicia nera In cima alla lista del Prefettissimo, oltre ai padrini appena citati, c’è il generale Antonino Di Giorgio, ministro della Difesa uscente; e c’ è quell’Alfredo Cucco che, intanto, è assurto al grado di federale di Palermo. Mori lo denuncia per legami mafiosi e varie malversazioni, la magistratura lo assolve in istruttoria per mancanza d’indizi, ma il Duce lo liquida, sciogliendo il Fascio palermitano ai primi del ’27. E subito dopo, nel celebre discorso dell’Ascensione, elogia pubblicamente il suo Prefetto di Ferro. Poi, l’anno seguente, lo chiama a Roma per esortarlo a «provvedere alla liquidazione giudiziaria della mafia nel più breve tempo possibile».
Un sibillino invito a chiudere i conti al più presto: la mafia ormai, sta diventando un caso nazionale, e la cronaca nera non si addice ad un regime che vuol darsi un’immagine di onnipotenza A ciò si aggiunge il crescente fastidio del Duce per quest’uomo che ormai ha perduto il senso della misura ubriaco della sua straripante popolarità, assume pose gladiatorie e si fa ritrarre sul suo cavallo bianco, camicia nera stivaloni ai piedi e fucile a tracolla.
Mori non capisce l’avvertimento, e tira dritto per la strada dell’«operazione chirurgica». «Il vero colpo mortale alla mafia», scrive ad un collaboratore, «lo daremo quando ci sarà consentito di rastrellare non soltanto tra i fichi d’India, ma negli ambulacri delle prefetture, delle questure, dei grandi palazzi padronali e – perché no? – di qualche ministero». Cosi, il 24 giugno del ’28, ecco il classico promoveatur ut amoveatur: la medaglietta di senatore a vita e il pensionamento «per anzianità di servizio». Morirà, dimenticato, nel ’42, dopo aver raccontato le sue imprese in due volumi di memorie: «Con la mafia ai ferri corti» e «Tra le zagare oltre la foschia».
LA PIOVRA IN FREEZER – L’Onorata Società, o quel che ne resta, tira un grosso sospiro di sollievo: il Grande Giustiziere le ha inferto il più duro colpo della sua storia. I principali boss rimasti a piede libero riparano in massa oltreoceano, tra le braccia della Grande Mamma d’America: Cosa Nostra. In Sicilia, decapitata e tartassata nei suoi affari, l’organizzazione si mette in letargo in attesa di tempi migliori. Ibernata in freezer. E fedele al suo motto: caliti iuncu ca passa la china (piegati giunco che passa la piena).
Intanto, negli Usa, i suoi capi riallacciano i rapporti con Cosa Nostra; eleggono Zu Calò, tornato in libertà, «reggente» della mafia siciliana al posto del vecchio galeotto Cascio Ferro; e gettano le basi per la riscossa del dopoguerra, imparando tutto sulla nuova gallina dalle uova d’oro che sta soppiantando il traffico dell’alcol dell’era del proibizionismo: la droga. E quando Mussolini riceve a Palazzo Venezia don Vito Genovese – il boss italoamericano nativo di Nola, incriminato negli Usa per evasione fiscale, sfruttamento della prostituzione e traffico di droga, la non belligeranza tra il regime trionfante e i rimasugli dell’Onorata Società sembra a prova di bomba.
Ma ancora una volta i boss intuiscono prima di tutti come andranno a finire le cose. E, dai loro rifugi americani, preparano l’ennesimo salto della quaglia, collaborando con l’Intelligence Service ai preliminari dello sbarco alleato in Sicilia. Cosi, nell’estate ’43, approdano nell’isola le truppe angloamericane con vecchi e nuovi mammasantissima. Quelle per andarsene al più presto. Questi per restarci. E per sempre.
(2-continua)
_________________________________
il Giornale Venerdì 21 agosto 1992
Viaggio nell’ «onorata società» dall’unificazione nazionale ad oggi -3 / L’intesa coi «i fratelli d’America» e le stragi degli anni Sessanta
CON LUCIANO E BUSCETTA LA FAMIGLIA CRESCE
L’eliminazione di Salvatore Giuliano e la rifondazione di Cosa Nostra nel dopoguerra
di Marco Travaglio
La mattina del 14 luglio 1943. Nel cielo di Villalba, piccolo paese al centro della Sicilia dove regna incontrastato don Calò Vizzini, il «capo dei capi» della mafia, volteggia un aereo da caccia americano. Qualche evoluzione a volo radente, poi lancia un plico sigillato. La storia ha dell’incredibile, ma parecchi testimoni giurano sulla sua autenticità, e le autorità americane non l’hanno mai smentita: nel pacco c’è un fazzoletto giallo oro con al centro una grande «L» ricamata, ed una lettera. Il tutto intestato «Zu Calò», a cui viene subito consegnato.
Il messaggio contiene le istruzioni di Cosa Nostra americana affinché la mafia non intralci le truppe anglo-americane, sbarcate dieci giorni prima in Sicilia, in marcia verso Palermo. E la «L» altro non è che la sigla di Lucky Luciano, il numero uno dell’onorata società d’Oltreoceano, allora detenuto nel carcere di Albany con una condanna a trent’anni sul groppone.
LUCKY IL GANGSTER – Nato nel 1897 a Lercara Friddi, presso Palermo, Lucky Luciano (nome di battaglia di Salvatore Lucania), è giunto negli States a dieci anni e giovanissimo si è fatto una fama di spacciatore di droga e tenutario di bordelli Trafficante di alcol sotto il proibizionismo eppoi titolare di una grande catena di aziende d’abbigliamento, è amico di politici altolocati. Di casa al congressi del partito democratico. Nel maggio 1929, quando si celebra ad Atlantic City il primo vertice tra mafia americana e siciliana che dà vita all’internazionale mafiosa «Cosa Nostra», Lucky è già uno del più potenti e rispettati capifamiglia del nuovo gangsterismo, insieme a Joe Masseria, Joseph Di Giovanni, il famoso «Scarface», Frank Costello, Joe Adonis e Joe Profaci.
Primo capo di Cosa Nostra è eletto Johnny Torrio, mentre per guidare l’organizzazione in Sicilia, perdurando la detenzione di Genco Russo, viene scelto don Calò. Ben presto Torrio è sostituito da Joe Masseria, subito eliminato da Luciano e dal suo braccio destro, don Vito Genovese (il Vito Corleone del «Padrino» di Mario Puzo) e rimpiazzato da Joe Maranzano, che nel ’31 fa la sua stessa fine.
Ma i due boss vincenti, a metà degli anni ’30, finiscono nei guai con la giustizia: Genovese ripara in Italia, a far la corte a Mussolini, mentre Luciano è arrestato nel ’36. Sei anni dopo, trasferito dal terribile penitenziario di Dannemore in quello più «vivibile» di Albany, nello Stato di New York, riprende i suoi loschi affari. E comincia a collaborare con le autorità. Prima facendo sorvegliare dal «fronte del porto» controllato dalla mafia gli scali di New York, per scongiurare sabotaggi tedeschi, Poi prestando ai servizi segreti le sue «entrature» per lo sbarco in Sicilia.
DON CALO’ E GLI ALLEATI – Contattato in galera dal Naval Intelligence, Lucky collabora dunque all’«Operazione Husky», che scatta il 10 luglio ’43 sulle spiagge siciliane. Con l’aiuto di don Calò, allora indiziato di cinquantun omicidi ma ormai «riabilitato» dopo la parentesi Mori. I due non si conoscono, ma il loro patto di ferro funziona a meraviglia. Il foulard giallo oro con la «L» nera al centro diviene il segno di riconoscimento tra agenti alleati in avanscoperta e mafiosi: i primi trovano ospitalità nei rifugi dei secondi Compreso quel Charles Poletti, legato a Cosa «Nostra americana, che sta per diventare il capo del Governo militare in Sicilia.
 Cosi l’Onorata Società, sia pur decimata e in via di riorganizzazione, si guadagna la gratitudine degli Alleati e persino della nuova (si fa per dire) classe politica Isolana, gabellando per lotta antifascista il duro scontro con Mori. Risultato: don Vito Genovese, l’uomo che capeggerà Cosa Nostra Usa dopo il ’57, è chiamato da Poletti a far parte del Governo militare alleato come suo interprete di fiducia. E quando, nel ’44, tra mille ostacoli, un agente della direzione investigativa dell’esercito Usa riesce a farlo arrestare, è costretto a portarselo appresso per sei mesi nell’indifferenza delle autorità italiane e statunitensi e nel ’45 non può far nulla contro il suo rimpatrio a New York, dove ben presto don Vito tornerà in libertà, grazie alla morte del testimone di uno dei suoi tanti omicidi avvelenato in carcere.
Cosi l’Onorata Società, sia pur decimata e in via di riorganizzazione, si guadagna la gratitudine degli Alleati e persino della nuova (si fa per dire) classe politica Isolana, gabellando per lotta antifascista il duro scontro con Mori. Risultato: don Vito Genovese, l’uomo che capeggerà Cosa Nostra Usa dopo il ’57, è chiamato da Poletti a far parte del Governo militare alleato come suo interprete di fiducia. E quando, nel ’44, tra mille ostacoli, un agente della direzione investigativa dell’esercito Usa riesce a farlo arrestare, è costretto a portarselo appresso per sei mesi nell’indifferenza delle autorità italiane e statunitensi e nel ’45 non può far nulla contro il suo rimpatrio a New York, dove ben presto don Vito tornerà in libertà, grazie alla morte del testimone di uno dei suoi tanti omicidi avvelenato in carcere.
L’Onorata Società, intanto, incassa il compenso di tanto prodigarsi: la gran parte dei nuovi sindaci vengono reclutati dall’amministrazione militare tra i mafiosi o gli «amici degli amici». Idem per i nuovi tutori dell’ordine. E in questi anni che il gangsterismo americano mette radici anche in Italia, esportandovi i suoi metodi spietati, non solo con don Vito ma anche con Joe Adonis (che in realtà si chiama Giuseppe Noto) e con Luciano, liberato nel ’45 per meriti patriottici e rispedito in patria come «indesiderabile» l’anno dopo.
I «fratelli d’America» aiutano i siciliani a riorganizzarsi e a legarsi vieppiù a filo doppio con la classe politica locale e nazionale. Don Calò diviene sindaco della «sua» Villalba (Caltanissetta), e «se avesse voluto – scrive Michele Pantaleone -avrebbe potuto diventare ministro». Genco Russo è primo cittadino a Mussomeli (stessa provincia) e per diversi anni sarà l’uomo forte della Dc nella sua zona d’influenza. Ma prima del grande balzo verso le forze di governo, la mafia si tinge di separatismo.
 LA SICILIA SI RIBELLA – Al primi del ’44 l’on. Andrea Finocchiaro Aprile, figlio di un ministro di Giolitti, che ha appena fondato il Movimento per l’Indipendenza Siciliana, fa appello ai mafiosi palermitani in un comizio a Bagheria: «Se la mafia non ci fosse, bisognerebbe inventarla. Io sono amico dei mafiosi, pur essendo, personalmente contrario al delitto e alla violenza». Cosa Nostra raccoglie l’invito e lo stesso anno don Calò in persona entra ufficialmente nel movimento, cedendo la carica di sindaco al nipote Beniamino Farina, democristiano. Non solo: il 16 settembre, spalleggiato dal nipote e da un pugno di soldati della «famiglia», il Grande Zio dà l’assalto al palco dove tiene un comizio il comunista Li Causi, a Villalba. Scariche di mitra, lancio di bombe a mano. Otto feriti, compreso l’esponente del Pci (il processo, tra mille rinvii e ostacoli, si concluderà 14 anni dopo, in concomitanza con la grazia del presidente della Repubblica: quattro anni dopo la morte di don Calò).
LA SICILIA SI RIBELLA – Al primi del ’44 l’on. Andrea Finocchiaro Aprile, figlio di un ministro di Giolitti, che ha appena fondato il Movimento per l’Indipendenza Siciliana, fa appello ai mafiosi palermitani in un comizio a Bagheria: «Se la mafia non ci fosse, bisognerebbe inventarla. Io sono amico dei mafiosi, pur essendo, personalmente contrario al delitto e alla violenza». Cosa Nostra raccoglie l’invito e lo stesso anno don Calò in persona entra ufficialmente nel movimento, cedendo la carica di sindaco al nipote Beniamino Farina, democristiano. Non solo: il 16 settembre, spalleggiato dal nipote e da un pugno di soldati della «famiglia», il Grande Zio dà l’assalto al palco dove tiene un comizio il comunista Li Causi, a Villalba. Scariche di mitra, lancio di bombe a mano. Otto feriti, compreso l’esponente del Pci (il processo, tra mille rinvii e ostacoli, si concluderà 14 anni dopo, in concomitanza con la grazia del presidente della Repubblica: quattro anni dopo la morte di don Calò).
Con il suo uomo più in vista nell’isola, Bernardo Mattarella, la Dc corre ai ripari e invita sul «Popolo» i militanti separatisti ad iscriversi allo Scudocrociato. L’appello sortirà l’effetto sperato, ma solo due anni più tardi. Per il momento, la mafia appoggia Finocchiaro insieme al fior fiore dell’aristocrazia terriera. Regala manovalanza gratuita all’esercito volontario del movimento, l’Evia. E benedice l’alleanza con il banditismo della Sicilia orientale, quello degli Avila di Niscemi, e occidentale, quello del clan di Salvatore Giuliano. Il gioco di don Calò è rischioso ma lucido: soffiare sul fuoco dei conflitti, per poi ergersi a mediatore tra lo Stato, i banditi e i secessionisti.
Ben presto, tra duri scontri e tentativi di «assorbimento» (dopo la Dc si muovono anche liberali e monarchici), il Movimento separatista comincia a stancare. Gli americani se ne sono andati, e gli appelli agli Usa perché accolgano la Sicilia come cinquantunesimo stato dell’Unione fanno sorridere. La mafia cerca il potere, quel potere che Finocchiaro ha ormai perduto insieme alla sua credibilità. E fa quadrato intorno ai partiti di governo.
De Gasperi invia nell’isola il dc Aldisio come commissario straordinario, suggerendogli di «discriminare la situazione di coloro che, ingannati o fuorviati, dimostrino di recedere prontamente dalle false e pericolose posizioni assunte». Tra i «fuorviati» c’è, manco a dirlo, don Calò, che sfugge all’ondata di arresti e passa armi e bagagli con lo Scudocrociato. E si rende subito utile alla causa dei grandi baroni del feudo, facendo eliminare uno ad uno – in perfetto stile gangsteristico – decine di sindacalisti e leader del movimento contadino che in quell’infuocato dopoguerra predicano l’occupazione delle terre. Ma Intanto la Sicilia è percorsa da un’ondata di delitti senza precedenti. Non più soltanto «esterni», ma anche interni alla mafia. Che succede?
IL RE DI MONTELEPRE – «Il rafforzamento al potere della vecchia mafia nella politica e nella burocrazia», ha scritto Pantaleone, «accentuò l’urto tra alcune cosche e soprattutto tra la vecchia e la giovane mafia. La vecchia pretendeva obbedienza e rispetto per la tradizione mai venuta meno; la giovane, invece, intendeva liberarsi del la protezione degli anziani per dedicarsi senza controllo alla nuova attività del contrabbando delle sigarette e della droga».
Ma la vecchia guardia mafiosa e dura a morire. E si guadagna la gratitudine delle forze dell’ordine e dello Stato con l’Operazione Giuliano. Anche dopo la liquidazione del Movimento indipendentista, che l’aveva nominato colonnello del suo esercito, il Re di Montelepre aveva seguitato a vagheggiare la secessione dell’isola in nome dell’anticomunismo. Arrivando a scrivere a Truman, nel ’49, per invocare «il vostro grandioso e potente appoggio morale» contro le presunte mire sulla Sicilia dei «russi, i quali anelano ad affacciarsi sul Mediterraneo».
E giungendo, nel suo delirio di onnipotenza, a progettare il sequestro di Zu Calò, dell’onorevole Mattarella e del vescovo di Monreale, Filippi. La strage di Portella della Ginestra, dove il Re di Montelepre semina il sangue e il terrore tra la folla in festa per il Primo Maggio ’47, è solo la prima di una lunga sene di attentati, sparatorie, mattanze firmate Giuliano. Cosi la vecchia mafia, d’accordo con settori della polizia e dei carabinieri, lo induce a collaborare con le forze dell’ordine per eliminare le altre bande delinquenziali che scorrazzano nelle campagne. E alla fine, quando Salvatore è rimasto solo, scatta il piano per eliminarlo.
Se ne incarica Gaspare Pisciotta, suo cugino e luogotenente, d’accordo con il colonnello dei carabinieri Luca: la notte sul 6 luglio del ’50, nel suo rifugio di Castelvetrano, il bandito è narcotizzato ed ucciso nel sonno, a pistolettate. Poi la macabra messa in scena nel cortile, con il cadavere crivellato di colpi di mitra per simulare il conflitto con ì carabinieri e dar credito alla versione ufficiale delle autorità, subito sbugiardata da un grande cronista come Tommaso Besozzi.
Al processo di Viterbo, Pisciotta vuota il sacco e tira in ballo, come «amici» del cugino, gli onorevoli monarchici Alliata e Marchesano e il solito dc Mattarella (il padre di Piersanti, ucciso dalla mafia nel 1980, e dell’attuale vicesegretario del partito, Antonio). Annuncia che farà pubblicare i diari di Giuliano, con tutte le prove delle sue accuse. Ma un caffè corretto alla stricnina glielo impedisce: muore il 9 gennaio ’54, allUcciardone.
GENCO RUSSO E AMICI – Il ’54 è un anno importante, per Cosa Nostra. Muore don Calò, pochi mesi dopo la sua celebre «confessione» ad Indro Montanelli. («La gente crede che sia per discrezione che io parlo poco. No, parlo poco perché poco so. Abito in un villaggio, vengo a Palermo solo di rado, conosco poca gente…In ogni società ci deve essere una categoria di persone che aggiustano le situazioni, quando si fanno complicate. In genere sono i funzionari dello Stato. Là dove lo Stato non c’è, o non ne ha la forza sufficiente, ci sono dei privati… La mafia! Ma esiste poi veramente, la mafia?»).
Colto da una crisi cardiaca nell’albergo del Sole, a Palermo, il Vecchio Patriarca chiede di essere portato a Villalba, nel suo letto. Ma, per strada, comprende che non ci arriverà vivo: si fa deporre sul ciglio della strada, per spirare «sulla mia terra siciliana».
Al suo posto, Cosa Nostra elegge come «capo dei capi» Genco Russo. Classe 1893, già incriminato per omicidio, abigeato e varie altre bazzecole, poi incaricato dagli Alleati della distribuzione dei generi alimentari, è un grande elettore della Dc, Più volte sindaco della natia Mussomeli (in provincia di Caltanissetta), dove uscirà primo eletto ancora nel’60, è un personaggio molto meno discreto di don Calò: negli ultimi anni viene sbertucciato dai nuovi mafiosi per la sua mania di pavoneggiarsi in pubblico e dare interviste. Il pentito Calderone ha raccontato a Pino Arlacchi che Totò Minore, riferendosi a lui, usava dire: «L’avete visto oggi, sul giornale, a Gina Lollobrigida?». E qualcuno, oggi, giura addirittura che, pur con il suo grande prestigio, Genco Russo fosse soltanto un «soldato» semplice, o al massimo il capo della provincia di Caltanissetta. Come pure Zu Calò.
Come siano andato veramente le cose non lo sapremo mai: in quel periodo, di pentiti disposti a vuotare il sacco non c’era neppure l’ombra (almeno in Italia, perché negli Stati Uniti infuriava, con le sue confessioni, Joe Valachi). Quel che è certo, è che Genco Russo si trovò a gestire l’ennesimo trapasso generazionale di Cosa Nostra.
Il sistema semifeudale delle campagne siciliane sconvolto dalla riforma agraria di Antonio Segni; l’autonomia regionale concessa alla Sicilia all’indomani dei moti secessionisti; l’istituzione della Cassa del Mezzogiorno (1950): tre novità prontamente sfruttate dalla nuova Cosa Nostra che, mentre la vecchia guardia rimane arroccata in campagna, dà l’assalto alle città, per dedicarsi al contrabbando e gettarsi a capofitto in quella torrenziale colata di cemento che si riversa sulla Palermo degli anni ’50 e ’60: gli anni delle grandi speculazioni edilizie.
I simboli viventi di quest’epoca di trapasso sono, oltre ai due Vecchi Patriarchi, il dottor Michele Navarro da Corleone, medico condotto, proprietario terriero, capo della Dc locale, mandante di una cinquantina di omicidi (uccise con un’iniezione di veleno un pastorello tredicenne che aveva assistito per caso al delitto Rizzotto) e di centinaia di furti ed estorsioni nel Corleonese tra la fine degli anni ’40 e l’inizio dei ’50. E due debuttanti di sicuro avvenire. Il primo è Luciano Leggio detto Liggio: nato a Corleone nel ‘28, contadino feroce e sanguinario, ha avuto il suo battesimo del sangue nel ’48, assassinando il segretario della locale Camera del Lavoro, il socialista Placido Rizzotto, e ponendo così fine alle agitazioni contadine nel Corleonese; luogotenente e killer prediletto di Navarro, lo farà eliminare nel ’58. Il secondo si chiama Tommaso Buscetta.
DON MASINO FA CARRIERA – Nato a Palermo nel ‘26, rampollo di una lunga e onesta dinastia di vetrai, «Masino» era scappato di casa a vent’anni, subito «adottato» dalla famiglia mafiosa di Porta Nuova eppoi, nel ’48, «combinato» (ossia affiliato) a Cosa Nostra con un rito esoterico (forse risalente ai Beati Paoli) che, rimasto sconosciuto per almeno un secolo, verrà rivelato proprio da don Masino ai giudici dopo il suo «pentimento».
La cerimonia si svolge in un casolare appena fuori Palermo. Un vecchio uomo d’onore (come si chiamano fra loro i mafiosi), affiancato da altri due membri della famiglia (i testimoni), pronuncia una formula rituale, poi chiede al neofita se accetta di «unirsi alla cosa». Masino risponde di sì, e uno dei testimoni gli punge il dito indice (della mano con cui spara, come vuole la prassi) con una spina di arancia amara. Il sangue è versato su un «santino» della Madonna dell’Annunziata, patrona di Cosa Nostra, che viene dato alle fiamme e che l’iniziando deve palleggiarsi sulle mani fino al completo spegnimento, pronunciando il giuramento dell’uomo d’onore: «Le mie carni debbono bruciare come questa Santina se non manterrò fede al giuramento». Come dire: chi tradisce, muore.
Segue la lettura del «decalogo» mafioso, sulla falsariga di quello biblico, con tanto di divieto di rubare e di insidiare la donna d’altri, infine il bacio sulla bocca (facoltativo in alcune famiglie). E la descrizione al «novizio» della gerarchia mafiosa, rimasta pressappoco intatta fino ai giorni nostri. Ogni famiglia (negli anni ’50 le cosche sono una cinquantina solo a Palermo) è composta da uomini d’onore (o soldati), coordinati a gruppi di dieci da un capodecina sopra i quali siede il capofamiglia, detto rappresentante, di nomina elettiva. Il capomandamento comanda su tre famiglie confinanti. Poi, a livello provinciale, c’è la Commissione o Cupola, presieduta da un segretario «primus inter pares». Solo negli anni “70, sul modello americano, verrà creata la Commissione regionale, la Grande Cupola.
Ma torniamo a don Masino, che a 25 anni e già capodecina. Abilissimo nel traffico di droga e nel contrabbando, ha fatto tesoro degli insegnamenti di Lucky Luciano che, tornato nel frattempo a Napoli, lo va spesso a trovare a Palermo. Ma don Masino è pure ammesso negli ambulacri dei grandi capi, amico com’è di Salvatore Greco detto Chicchiteddu (l’Uccellino, per distinguerlo dai suoi due omonimi cugini. Salvatore detto il Lungo o l’Ingegnere, e Salvatore detto il Senatore, fratello quest’ultimo di Michele il Papa). Capo della famiglia di Ciaculli, Chicchiteddu è, agli inizi degli anni ’60, segretario della Commissione di Palermo. In pratica, il numero uno di Cosa Nostra, viceré riverito e potentissimo. Ma ben presto, sulla sua pax mafiosa, si addensano i primi, neri nuvoloni
LA PRIMA GUERRA – Dopo il vertice dell’Hotel des Palmes, a Palermo (1957), dove mafia americana e siciliana hanno stretto un nuovo patto d’acciaio per la spartizione del contrabbando di droga e sigarette, la rifondazione di Cosa Nostra sembra affare fatto. Soldi a palate arrivano dai traffici internazionali E altro denaro a pioggia promettono le selvagge speculazioni edilizie a Palermo, favorite dopo il ’58 da Vito Ciancimino, assessore ai Lavori pubblici nelle tre giunte consecutive di Salvo Lima, il cui programma è semplice e chiaro: «Palermo è bella, facciamola più bella». Ciancimino Lima e Giovanni Gioia (segretario provinciale della Dc e futuro ministro): i tre «giovani turchi» della metropoli sommersa dal cemento dei costruttori in odor di mafia, come l’ex carrettiere Francesco Vassallo divenuto il re delle gare d’appalto.
Il denaro corre a fiumi. Ma avvelena i rapporti tra le famiglie di Palermo, dove – dopo il modus vivendi dei primi anni ’50 – i clan Greco e La Barbera sono ormai ai ferri corti, il pretesto della guerra viene dal fidanzamento contrastato fra un soldato della famiglia di Porta Nuova e la sorella di un uomo d’onore del clan di Noce. Per risolvere la controversia, il rappresentante di Noce, Calcedonio Di Pisa, chiede che il giovane venga aggregato, visti i suoi legami sentimentali, alla sua famiglia. Ma Salvatore La Barbera, potentissimo boss dei tre clan di Palermo Centro (Porta Nuova compresa), già In lite con lui per una partita di droga non pagata adeguatamente, si oppone con violenza. E pochi giorni dopo, il 26 dicembre ’62, Di Pisa viene assassinato in piena città. I sospetti si appuntano, com’è ovvio, su La Barbera e gli amici di Buscetta, «processati» davanti alla Commissione dall’ormai strapotente clan dei Greco: non più con Chicchiteddu che, disgustato dalle discordie, se ne andrà presto in Venezuela; ma con suo cugino, Totò l’Ingegnere.
E’ lui a decidere di eliminare pezzo per pezzo il clan avversarlo: Salvatore La Barbera scompare nel nulla (Greco l’avrebbe strozzato con le sue mani in una riunione), il fratello Angelo scampa miracolosamente ad un attentato nel ’63 (ma sarà ucciso in carcere poco dopo), il suo esercito è decimato da attentati e «lupare bianche».
Ma intanto un nuovo, spaventoso delitto sconvolge gli equilibri di Cosa Nostra: il 30 giugno 1963 una «Giulietta» imbottita di esplosivo salta In aria a Ciaculli, a pochi passi dalla villa di Totò Greco, dilaniando sette tra carabinieri, poliziotti e artificieri. Una sfida anonima non solo allo Stato, ma anche al vertice della Commissione. E, nei mesi seguenti, altre sanguinose esplosioni di marca terroristico-mafiosa qua e là per Palermo. Mentre le famiglie si rinfacciano le responsabilità degli attentati e si sparano contro alzo zero, lo Stato si decide finalmente a rispondere.
La magistratura fa arrestare centinaia di mafiosi (anche se poi, al processo di Catanzaro del ’68, saranno quasi tutti assolti). E Parlamento vara la prima Commissione d’Inchiesta suite mafia, il 20 dicembre del ’62: primo presidente, il socialdemocratico Paolo Rossi. Servirà a poco, come tutte le commissioni che verranno. Ma almeno, per te prima volta dai tempi del prefetto Mori, lo Stato dà un segnale di vita nella Sicilia soffocata dalla Piovra. Una Piovra a sua volta dilaniata degli scontri interni fino al ’69, quando si scopre che l’autore del delitto Di Pisa e delle «giuliette» esplosive altri non è che Michele Cavataio, il capo del mandamento palermitano dell’Acquasanta, risentito contro l’élite di Cosa Nostra per una vecchia storia di vendette incrociate.
E’ lui che, dal ’62 in poi, ha scatenato su Palermo quella spaventosa ondata di omicidi, seminando panico e zizania nella Commissione e tentando cosi di prendere il potere. La sua fine si consuma il 10 dicembre ’89, in viale Lazio a Catania, negli uffici dell’impresa Moncada, per mano di cinque killer inviati da Salvatore Bontade, Tano Badatementi e Giuseppe Di Cristina. Dirige le operazioni, a debita distanza Totò Riina, braccio destro del boss emergente di Ciaculli, Michele Greco detto il Papa. Fuoco a volontà, cinque morti: la vittima designata e quattro sicari.
Il cerchio, il terribile cerchio di morte aperto con te strage di Ciaculli si chiude qui, in viale Lazio. La prima grande guerra di mafia è finita. Ma, sullo scorcio degli anni ’60, è finita anche un’epoca. Quella dei codici d’onore, della coppola e della lupara. Da allora Cosa Nostra va a scuote dal terrorismo, piazza le bombe al plastico, imbraccia il Kalashnikov. Gioca al «tutti contro tutti» e non rispetta più le regole del gioco. Neppure le sue
(3-continua)
______________________________
il Giornale Sabato 22 «costo 1992
Viaggio nell’ «onorata società» dall’unificazione nazionale ad oggi 4 / I conflitti interni e l’attacco sferrato contro le istituzioni
PALERMO COME BEIRUT, VENT’ANNI DI SANGUE
La grande sfida allo Stato parte dalla Cupola, droga e finanza i serbatoi delle cosche
di Marco Travaglio
 «Dal 1962 al ’69, anno della strage di viale Lazio, una grande confusione regnò nella mafia palermitana. Ci furono molti morti per la guerra di mafia e molti arresti Più di cento. I capi più importanti furono incarcerati e poi ci fu il processo di Catanzaro. La “Giulietta” di Ciaculli contro i Greco, nel ’63, fu ii danno più grosso. Il governo mandò la Commissione antimafia. Cosa Nostra non è più esistita nel Palermitano dopo il 1963. Era Ko. La mafia fu sul punto di sciogliersi e sembrò andare allo sbando. Basta pensare che il capo della Commissione provinciale di Palermo, Totò Greco Chicchiteddu, abbandonò la sua carica ed emigrò in Venezuela. Era latitante ed era stato pure condannato. Le famiglie erano tutte scassate. Si faceva proprio il minimo indispensabile, Non c’erano quasi più omicidi Neppure il pizzo si pagava più, a Palermo», anche se «nelle altre città la mafia governava ancora».
«Dal 1962 al ’69, anno della strage di viale Lazio, una grande confusione regnò nella mafia palermitana. Ci furono molti morti per la guerra di mafia e molti arresti Più di cento. I capi più importanti furono incarcerati e poi ci fu il processo di Catanzaro. La “Giulietta” di Ciaculli contro i Greco, nel ’63, fu ii danno più grosso. Il governo mandò la Commissione antimafia. Cosa Nostra non è più esistita nel Palermitano dopo il 1963. Era Ko. La mafia fu sul punto di sciogliersi e sembrò andare allo sbando. Basta pensare che il capo della Commissione provinciale di Palermo, Totò Greco Chicchiteddu, abbandonò la sua carica ed emigrò in Venezuela. Era latitante ed era stato pure condannato. Le famiglie erano tutte scassate. Si faceva proprio il minimo indispensabile, Non c’erano quasi più omicidi Neppure il pizzo si pagava più, a Palermo», anche se «nelle altre città la mafia governava ancora».
A leggere il racconto del pentito Antonino Calderone, raccolto da Pino Arlacchi ne «Gli uomini del disonore», non si può non schiumare di rabbia per l’ennesima occasione perduta dallo Stato in Sicilia. Bastava forse insistere di più sulla via della repressione per averla vinta. Invece le cose andarono ben diversamente.
COME L’ARABA FENICE – Il processo di Catanzaro, aperto nel ’68, fa acqua da tutte le parti. E i boss incriminati, da Liggio a Buscetta, da Riina a Liggio (latitanti), da Badalamenti a Bontade a Torretta, finiscono presto o tardi assolti per insufficienza di prove. La sentenza del ‘73, se si eccettua la condanna a 28 anni per Pietro Torretta, cancella con un colpo di spugna dieci anni di indagini e Cosa Nostra, come l’Araba Fenice, risorge dalle sue ceneri. «Non si arrivò subito», ricorda Calderone, «a ricostituire l’organismo provinciale (sciolto da Chicchiteddu, n.d.r.), perché… c’erano ancora instabilità, fastidi Quando Chicchiteddu parti per il Sudamerica e affidò il suo incarico ad Antonino Sorci, quest’ultimo venne arrestato e si dovette ricominciare daccapo. Dopo Catanzaro, in ogni caso, si costituì a Palermo un governo provvisorio – mi pare si chiami “reggenza” – formato da Gaetano Badalamenti, Luciano Liggio e Stefano Bontade».
Agli inizi, gli affari vanno malissimo: «Usciti di galera, verso il ’68, i capi di Cosa Nostra erano quasi tutti morti di fame. Ma se vi dico che Totò Riina piangeva, quando mi disse che sua madre non poteva andare a colloquio con lui in carcere, nel ’66 o ’67, perché non poteva pagarsi il biglietto del treno! L’unica eccezione erano i Greco, benestanti di vecchia data. Poi sono diventati tutti miliardari. All’improvviso, in un paio d’anni. Per merito della droga».
Il triumvirato, dunque, funziona bene. Anche se l’indiscusso numero uno è Liggio, scampato all’arresto nei primi anni ’60 e latitante prima a Catania («ospite» della famiglia Calderone) eppoi a Milano: sempre più ambizioso, feroce, sanguinario, il boss corleonese tratta nel ’69, a Roma, con il principe Junio Valerio Borghese, che ha chiesto l’appoggio di Cosa Nostra al suo folle progetto di golpe, poi finito in burletta. Ma su questa vicenda, come poi sul caso Sindona e sul suo falso rapimento complice la mafia, nel “79, e ancora sui rapporti tra Cosa Nostra, P2, massoneria e Roberto Calvi, il mistero è fitto. E rimarrà tale.
DON TANO E IL FALCO – Impegnato nei suoi affari al Nord, don Luciano si fa rappresentare nella «reggenza» dal fido Totò Riina. Gli altri due triumviri, Bontade e Badalamenti, fanno buon viso. Per ora. Figlio di don Paolino Bontade (o Bontate), un vecchio padrino che si permetteva di prendere a sberle in pubblico i deputate disobbedienti e che portò buona parte della mafia ad appoggiare li- governo-minestrone (dai monarchici al Pci ai de dissidenti) di Silvio Milazzo alla Regione Sicilia, Stefano detto «il Falco» è ancora un ragazzo quando conosce Tommaso Buscetta, nel ’58, all’Ucciardone.
I due diventano amici e lo rimangono anche dopo che Bontade diviene capo della famiglia di Santa Maria di Gesù: si proclamano custodi della tradizione ed eredi spirituali di Chicchiteddu, espatriato dopo la strage di Ciaculli perché – spiegherà Buscetta – «la mafia stava abbandonando i suoi principi per trasformarsi in un’organizzazione di criminali». Perciò si opporranno alla svolta terroristica di Cosa Nostra inaugurata dai Corleonesi e — ironia della sorte – da Miche le Greco, il cugino di Chicchiteddu.
Tutt’altro tipo di boss è Gaetano Badalamenti. Rozzo, ignorante e sgrammaticato, il boss di Cinisi è lo zimbello dei capi mafia ad ogni riunione della Cupola. E soprattutto di Liggio, che si picca della fama di intellettuale e tiene sul comodino «La critica della ragion pura». Eppure don Tano è tanto influente da diventare ben presto il numero uno di Cosa Nostra. E tanto abile da controllare, nella sua zona d’influenza, l’aeroporto palermitano di Punta Raisi e da mettere in piedi, con i «fratelli» d’America, la multinazionale della droga che passerà alla storia come «Pizza Connection», smascherata dall’Fbi nel 1984.
Ma torniamo al “70, quando sia don Tano che Bontade si trovano da qualche tempo in galera, dopo aver organizzato la strage di viale Lazio contro Cavataio. Liggio ne approfitta subito per dichiarare estinta la «reggenza» e mettere a capo di Cosa Nostra Totò Riina, il suo killer di fiducia. E, perché tutti capiscano quanto sono forti i Corleonesi organizza la più grave sfida allo Stato mai vista fino ad allora: l’assassinio di Pietro Scaglione, procuratore della Repubblica di Palermo, trucidato con l’autista il 5 maggio del “71.
LIGGIO E IL PAPA – All’agguato partecipano sia Liggio sia Riina. Affetto dal morbo di Pott, una tubercolosi ossea che quasi lo paralizza e gli dà gravi disturbi ai reni e alle vie urinarie, don Luciano quel giorno non è neppure in grado di muoversi: ma vuole sparare lo stesso contro quello che chiama «il mio persecutore», accucciato sul sedile posteriore della sua auto. Ben presto con una cura da cavallo si rimetterà in forze. Pronto, dopo l’uscita dal carcere di Badalamenti e Bontade, a resuscitare la Commissione.
Da allora i vertici di Cosa Nostra si tengono alla «Favarella», la tenuta di Michele Greco detto il «Papa» a Ciaculli: un rustico di campagna immerso in decine di ettari di agrumeto, «espropriato» nei primi anni ’80 dal potente clan agli eredi del conte Tagliavia. Il superboss non vi abita: troppo scomoda e fuori mano, la villa. Che però, con i suoi sotterranei accessibili solo da passaggi segreti, è la sede ideale per i summit della Cupola e il migliore nascondiglio per i latitanti. La polizia fino al blitz dell’84, ignora addirittura l’esistenza della villa Anche perché Michele Greco, negli anni “70, è tutto fuorché un sospettato.
Riservato fino alla misantropia non ha mai fatto parlare di sé. Vanta parecchie amicizie nell’aristocrazia palermitana E si è fatto largo nel mondo degli affari con la protezione di Cosa Nostra fino a diventarne lui stesso uno dei capi (e poi il capo supremo) dopo l’eclissi dei due cugini, Chicchiteddu e l’ingegnere.
 VENTI DI GUERRA – Ma ecco, nel “73-74, la Commissione impegnata a rimettere ordine tra i suoi affari. Si decide di proibire i sequestri di persona (a cui diverse famiglie sono ricorse per autofinanziarsi dopo la «grande guerra»). Almeno in Sicilia Liggio, che nei rapimenti s’è specializzato con la malavita milanese, dovrà perciò limitarsi all’Alta Italia E viene duramente rimbeccato da don Tano per i suoi eccessi sanguinari, che mettono in allarme le forze dell’ordine.
VENTI DI GUERRA – Ma ecco, nel “73-74, la Commissione impegnata a rimettere ordine tra i suoi affari. Si decide di proibire i sequestri di persona (a cui diverse famiglie sono ricorse per autofinanziarsi dopo la «grande guerra»). Almeno in Sicilia Liggio, che nei rapimenti s’è specializzato con la malavita milanese, dovrà perciò limitarsi all’Alta Italia E viene duramente rimbeccato da don Tano per i suoi eccessi sanguinari, che mettono in allarme le forze dell’ordine.
Ma proprio nel 1974, dopo vent’anni di latitanza, è arrestato a Milano: «Non credere alle infamie che scriveranno su di me», dice uscendo di casa in manette alla sua convivente, ignara della sua identità, «sono tutte bugie». Badalamenti gli rende la pariglia facendosi eleggere segretario della Commissione. E dando il benestare alla nascita, nel “75, della Grande Cupola, la Commissione regionale, ossia il supergoverno del sei rappresentanti provinciali, proposto dal boss catanese Pippo Calderone, che ne diventa segretario dopo don Tano, prima di Michele Greco (ma l’organismo non funzionerà mai, vista la pretesa dei clan palermitani di comandare su tutte le altre province).
Su Cosa Nostra, in quegli anni, sembra regnare di nuovo la pace. Fanno buoni affari le famiglie della provincia di Palermo (una cinquantina), e delle altre province mafiose Catania, Caltanisetta, Trapani, Agrigento ed Enna (molto meno numerose: uno, due, al massimo tre clan per città). E tutte hanno appena scampato un grosso pericolo: nel ’73, un uomo d’onore «pentito» della famiglia di Altarello, Leonardo Vitale, si è presentato alla polizia per rivelare i segreti di Cosa Nostra; ma non l’hanno preso sul serio ed è finito in manicomio (morirà ammazzato nel ’78).
Un altro pericolo, soltanto potenziale, si sgonfia nel ’75, quando si concludono dopo 13 anni i lavori della prima Commissione parlamentare antimafia: 711 pagine di relazione di maggioranza con pochi nomi – tutti stranoti – nessun politico, e scoperte sconvolgenti come questa: «Non si può fare a meno di ribadire che la mafia è un fenomeno tuttora aggressivo con persistenti radici nella società siciliana…». Eppure i pentiti, ma non solo quelli, parleranno di pesanti compromissioni dei partiti, soprattutto quelli di governo ma anche dell’opposizione (dal pri Giumella al psdi Lupis a tanti altri): si scoprirà poi che l’Antimafia ha tenuto ben nascoste quasi 2.500 schede con nomi come Lima, Ciancimino, Gioia, Vassallo, pubblicate da un giornale nell’88. Né faranno di meglio, anche per i loro scarsi e confusi poteri, le altre Commissioni, fino a quella, peraltro attivissima, presieduta oggi dal senatore Chiaromonte.
La tregua armata tra le famiglie dura tre anni. Poi nel ‘77 due feroci esecuzioni ripiombano la mafia nel caos e Palermo nel terrore: cadono il maresciallo di Ps Angelo Sorino e il tenente colonnello dei Carabinieri Giuseppe Russo. Mandante Liggio e Riina, con la benedizione del loro alleato Michele Greco. Scavalcato e Ignaro di tutto, don Tano chiede spiegazioni Ma nessuno risponde. E anzi il «papa», nel “78, fa entrare in Commissione il suo giovane e feroce attendente nonché lontano cugino: Pino Greco detto «Scarpuzzedda» (Scarpetta). Un’altra sfida alla corrente degli «antipapisti», ossia Badalamenti Bontade, Salvatore Inzerillo (rappresentante di Passo di Rigano) e Giuseppe Di Cristina (capo della famiglia di Riesi). E’ il prologo al siluramento del rozzo «segretario», che viene sostituito al vertice della cupola da Michele Greco, rimpiazzato a sua volta come capofamiglia da Scarpuzzedda. Da un giorno all’altro, Badalamenti non è più nessuno: dimesso pure da rappresentante di Cinisi e addirittura «deposto» da Cosa Nostra. La vendetta dei Corleonesi è cominciata
L’ODISSEA DI BUSCETTA – Ma che parte ha avuto, in tutte queste vicende, don Masino Buscetta? L’abbiamo lasciato all’Ucciardone, nel 1958, dopo il suo arresto per contrabbando di sigarette. Poca roba, a confronto dei suoi delitti. Libero dopo qualche mese, il boss di Porta Nuova si vede ritirare il passaporto nel ’61, ma lo riottiene quasi subito per intercessione dell’onorevole Barbaccia (dc), che lo raccomanda alla polizia palermitana come «uomo che mi sta molto a cuore». E’ il maggio ’61. Due anni dopo, ai primi fuochi della Grande Guerra di mafia, vola Oltreoceano: Stati Uniti, Canada, Messico, Brasile. Le polizie locali lo ricercano come uno dei «re della cocaina». Nel ’70 è espulso dagli Usa. Nel ‘72 arrestato in Messico. Estradato in Italia viene rinchiuso all’Ucciardone per scontare una condanna a dieci anni per i reati commessi negli anni ’50.
Qui, prima del trasferimento a Cuneo, incontra i vecchi amici: Bontade, Di Cristina e Badalamenti, tutti in attesa del colpo di spugna di Catanzaro. E da costoro che apprende di esser stato «deposto» (espulso) da Cosa Nostra, per la sua vita sentimentale un po’ troppo disordinata. A farlo espellere è stato don Pippo Calò, l’ex macellaio che proprio Buscetta aveva «iniziato» alla carriera mafiosa tanti anni prima (verrà arrestato nel 1985 per 64 omicidi e per la strage del treno 904 a San Benedetto Val di Sambro). »
«Semilibero» nel 1980, Masino lascia il Piemonte e torna clandestinamente a Palermo, per toccare con mano quali livelli di degenerazione abbia raggiunto Cosa nostra. Incontra i pochi amici rimasti, poi disgustato, torna in Brasile. Vuole dimenticare ed esser dimenticato. Ma nel 1983 una visita inaspettata lo ripiomba nelle beghe palermitane: è don Tano Badalamenti, volato fin laggiù per implorarlo di tornare in Sicilia e guidare la rivolta contro i Corleonesi. E per aggiornarlo sugli ultimi eventi.
PALERMO COME BEIRUT – Da quando il «papa» ha preso il comando della Cupola, Palermo si è libanizzata. Stragi su stragi Tutte interne a Cosa nostra. Tutte firmate Liggio-Riina-Greco contro gli «antipapisti». Una guerra senza quartiere, la seconda Grande Guerra di mafia: sullo sfondo, lo scontro fra don Tano e i Corleonesi per il controllo del traffico internazionale della droga. Il primo a cadere, nel “78, è Giuseppe Di Cristina, capofamiglia di Riesi e boss vecchio stampo, nemico di Liggio, amico di Chicchiteddu e dei cugini Salvo (esattori per conto dello Stato in gran parte dell’isola) nonché grande elettore della Dc, che alla sua morte espone la bandiera a mezz’asta nella sezione di Riesi. Fuori uno.
Dopo di lui tocca a Stefano Bontade: ha avuto il torto di protestare per i delitti Reina, Giuliano, Terranova (1979) e Mattarella (1980), decisi al di fuori della Cupola, e di ripetere un po’ troppo spesso il proposito di far fuori Riina. Tradito dal fratello Giovanni, che sta con i Corleonesi, viene freddato a raffiche di Kalashnikov mentre torna dalla festa per il suo quarantatreesimo compleanno, il 23 aprile ’81. Fuori due.
L’11 maggio scocca l’ora del suo ultimo amico. Salvatore Inzerillo, il boss di Passo di Rigano che per mostrare la sua forza ha fatto uccidere l’anno prima il procuratore Costa. Fuori tre. Lo sterminio è completato con l’eliminazione di Pippo Calderone, boss di Catania, per mano del suo aspirante successore, Notto Santapaola, legato anche lui ai «vincenti» di Palermo come pure il clan dei Madonia, padroni di Caltanissetta. Ora la Commissione è «normalizzata», sotto lo scettro dei Corleonesi e dei Greco.
Ma la seconda Grande Guerra ha fatto oltre cento morti in tre anni. E lo Stato, per arrestare la mattanza, manda a Palermo il generale Dalla Chiesa, l’eroe dell’antiterrorismo: l’ammazzano dopo un mese, con la moglie Emmanuela, il 3 settembre ’82. La stessa fine ha fatto, cinque mesi prima, Pio La Torre, il deputato comunista promotore della legge antimafia. E l’anno seguente, altri due martiri dello Stato: il giudice trapanese Ciaccio Montalto e il vecchio consigliere istruttore Rocco Chinnici, inventore del «pool» investigativo, capo dell’ufficio che ha appena emesso mandati di cattura contro i corleonesi Riina e Provenzano, i fratelli Michele e Salvatore Greco «il Senatore», e Nitto Santapaola.
Non ci sono soltanto delitti «esterni», nella Palermo di quegli anni. La guerra tra bande prosegue senza sosta, anche perché sulla lista nera dei Corleonesi c’è ancora un nome: Salvatore «Totuccio» Contorno, detto Coriolano della Foresta (il leggendario capo settecentesco dei Beati Paoli), appena condannato a 26 anni per sequestro di persona. Nativo di Ciaculli, figlio di un vecchio mafioso a riposo, ha fatto per anni l’allevatore di bestiame prima di trasferirsi nel quartiere Brancaccio ed imbattersi in Stefano Bontade, diventandone il braccio destro nel traffico di droga. Anche lui «deve morire».
E il 25 giugno ’81 scatta l’agguato, condotto da Pino Greco in persona: salvo per miracolo, Totuccio scompare dalla circolazione, mentre Scarpuzzedda gli fa ammazzare sette parenti stretti e decine di complici veri e presunti. E gli mette alle calcagna il suo nuovo, sanguinario alleata Filippo Marchese, il capofamiglia di Corso dei Mille che tortura le sue vittime in un’apposita «camera della morte» per farle confessare, le strangola eppoi le fa sparire in mare o in una cisterna di acido.
Nella sua furia omicida, però, don Filippo non viene a capo di nulla: Totuccio si è fatto arrestare a Roma e di lì a poco comincerà a collaborare con la giustizia. Seguito a ruota da uno dei killer del clan Marchese, Vincenzo Sinagra, sulla strada del pentimento inaugurata da don Masino.
DA BUSCETTA AL NULLA – All’offerta di don Tano di tornare a Palermo, Buscetta ha opposto un bel no. Della mafia di quella mafia non vuol più sentir parlare. Nemmeno quando i Corleonesi gli ammazzano due figli, un fratello, un nipote, un cognato, un genero. Se ne sta buono buono in Brasile, nella speranza che tanta remissività induca i suoi nemici a risparmiare il resto della famiglia.
Arrestato a San Paolo il 24 ottobre 1983, al giudice Falcone che è venuto ad interrogarlo oppone un sibillino «ci rivedremo presto». Estradato in Italia nel luglio ’84, sull’aereo che lo porta a Roma ingerisce una fiala di stricnina, tentando il suicidio: l’unico modo, ormai, per mettere fuori pericolo la sua famiglia. Lo salvano in tempo. E lui si decide a vuotare il sacco. «Sono stato mafioso e ho commesso degli errori»: sono la prime parole della sua lunga confessione, cominciata alle 12.30 del 16 luglio davanti a Giovanni Falcone, e finita più d’un mese dopo.
 All’alba del 29 settembre di quello stesso ’84, giorno di San Michele patrono delle forze dell’ordine, il Grande Blitz: tremila poliziotti e carabinieri setacciano Palermo alla ricerca di trecento latitanti, in esecuzione di altrettanti mandati di cattura. I più sono irreperibili, ma le manette-scattano ai polsi di decine di uomini d’onore. Ed è solo l’inizio. In novembre tocca all’ex sindaco Vito Ciancimino e ai cugini Ignazio e Nino Salvo, i potentissimi «vicerè» legati al clan di Salenni, che negli anni ’50 e ’60 facevano e smontavano a colpi di mazzette le giunte palermitane, ricevendo ministri e deputati.
All’alba del 29 settembre di quello stesso ’84, giorno di San Michele patrono delle forze dell’ordine, il Grande Blitz: tremila poliziotti e carabinieri setacciano Palermo alla ricerca di trecento latitanti, in esecuzione di altrettanti mandati di cattura. I più sono irreperibili, ma le manette-scattano ai polsi di decine di uomini d’onore. Ed è solo l’inizio. In novembre tocca all’ex sindaco Vito Ciancimino e ai cugini Ignazio e Nino Salvo, i potentissimi «vicerè» legati al clan di Salenni, che negli anni ’50 e ’60 facevano e smontavano a colpi di mazzette le giunte palermitane, ricevendo ministri e deputati.
Intanto, mentre cade in trappola anche Pippo Calò, negli Usa finisce dentro don Tano Badalamenti, processato nell’85 per la Pizza Connection e «incastrato» proprio dalla testimonianza decisiva di Buscetta che, in cambio, riceve dalle autorità americane la nazionalità Usa, il perdono di tutti i reati, una nuova identità e un rifugio superprotetto.
Il 1985 è anche l’anno della scomposta replica di Cosa Nostra allo Stato: cadono altri due inquirenti di prima linea, il commissario Montana e il vicequestore Cassarà. Neil’86 il superprocesso istruito dal pool antimafia di Falcone, Ayala e Borsellino a carico di 474 uomini d’onore (più della metà latitanti), sulla base delle confessioni di Buscetta. Contorno, Sinagra ed altri 22 pentiti. Ai presenti si aggiunge presto il Papa, arrestato in una delle sue ville. Ma con un clamoroso verdetto, la Cassazione di Carnevale annulla le condanne dei fratelli Greco per il delitto Chinnici.
E, dopo due anni e mezzo di tregua, Cosa Nostra torna ad alzare il tiro: cadono l’ex sindaco Insalaco, il presidente della Corte d’assise, Antonino Saetta (1988), il giudice di Agrigento, Rosario Livatino (1990). Intanto il maxi-processo s’è chiuso con una raffica di ergastoli (stavolta confermati dalla Suprema corte): ma su fatti ormai vecchi, mentre Cosa Nostra s’è riorganizzata chissà come, sempre più lontana dalla droga e sempre più vicina alle centrali della finanza internazionale, mentre il rubinetto dei pentiti s’è seccato e le «voci di dentro» si sono esaurite.
In questo buio sempre più pesto, i veleni, i corvi, il Csm, i «professionisti dell’antimafia», gli alti commissari, le rivelazioni, le tournée della Commissione parlamentare, gli ammazza-sentenze, le evasioni, la Dia, la Superprocura, Libero Grassi, Lima, Falcone, Borsellino, le polemiche, i super-decreti, le lagne di Orlando Cascio, il tritolo, i funerali, le prediche, i dibattiti, le marce, le lenzuola, l’esercito. Ma questa, più che storia, è cronaca. La solita cronaca.
(4-fine. Le precedenti puntate sono state pubblicate il 19,20 e 21 agosto)